Quali sono le parole e che caratterizzano la sostenibilità ecologica e sociale? E quali sono i significati collegati a queste parole? Questo è il luogo dove approfondire le sfaccettature, le complessità e le sinapsi che esistono tra un termine e l'altro. Naviga tra i temi de La Svolta!
Hai domande?
Sei nel posto giusto
Cambiamento climatico
Che cos’è il cambiamento climatico?
Il vocabolario è un volume ormai sempre pronto a nuovi aggiornamenti, soprattutto negli ultimi anni, quando sono stati inseriti inglesismi e termini di uso comune. Ormai le parole cambiano e aumentano sempre di più, anche grazie alle nuove generazioni che portano a una conversazione diversa e più digitalizzata. Ma non sono solo i social o la comunicazione stessa a evolversi con nuovi termini: anche il clima e i fenomeni atmosferici.
Con la crisi climatica che avanza, i fenomeni meteo negativi sono sempre più intensi e frequenti, capaci in poche ore di sconvolgere l’ambiente. Comprendere a fondo i termini tecnici della meteorologia e gli eventi estremi che ci colpiscono può essere utile per prepararci ad affrontarli e a difenderci. Non solo trombe d’aria improvvise, temporali, grandinate e alluvioni, esistono anche altri fenomeni atmosferici che non tutti conoscono, come downburst, virga o bow-echo.
Gli eventi climatici estremi nel 2022
Per le Nazioni Unite il climate change rappresenta le variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Questi cambiamenti possono avvenire in maniera naturale oppure no. A partire dal XIX secolo infatti le attività umane sono state il fattore principale all'origine dei cambiamenti climatici.
Proprio il 2022 è stato un anno ricco di eventi meteo estremi. Facendo fede agli ultimi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, se ne sono contati 132, il numero più alto della media annuale dell’ultimo decennio.
Considerando che l’anno non è ancora concluso, il numero di fenomeni estremi verificatisi nel nostro Paese risulta già più alto della media degli ultimi anni. Secondo Legambiente, tra il 2010 e il mese di luglio 2022 in Italia ce ne sono stati 1318, con impatti su 710 comuni italiani.
La maggior parte ha riguardato allagamenti in seguito a piogge intense (516 episodi), trombe d’aria (367), piogge (157), esondazioni fluviali (123). Seguono grandinate (63), siccità prolungata (55), frane (55). La crisi climatica sta sicuramente amplificando l’intensità e frequenza di questo tipo di fenomeni.
Termini vecchi e nuovi per i fenomeni atmosferici
Cambia il clima e cambiano anche i termini dei fenomeni atmosferici e ora non possiamo più accontentarci di sapere ascoltare le previsioni meteorologiche e capire cosa dicono: serve di più. Per capire davvero quello che sta succedendo al clima bisogna parlare la sua stessa lingua e imparare nuovi termini. L’espressione crisi climatica, per esempio sarebbe da usare soprattutto quando ci sono fenomeni eccezionali come le recenti ondate di calore (un vero e proprio campanello d’allarme).
Partiamo dalla base. Per pioggia, a esempio, intendiamo una precipitazione atmosferica che raggiunge il suolo in forma liquida. All’origine la pioggia si forma per l’accrescimento di goccioline d’acqua o di cristalli di ghiaccio all’interno delle nubi. Queste particelle, una volta superato un certo peso, non sono più sostenute dai moti dell’aria e cadono verso il suolo; i cristalli di ghiaccio quando incontrano temperature positive fondono. La precipitazione però può anche evaporare prima di toccare terra e creare così una specie di cortina scura sospesa alla base della nube. Questo fenomeno, detto virga, avviene quando sotto la copertura nuvolosa è presente uno strato d’aria molto secca. La virga però non raggiunge il suolo e quindi non rientra nella categoria delle precipitazioni. La pioggia, soprattutto se è temporalesca, può creare dei danni in quanto può provocare delle inondazioni mettendo in pericolo vite umane.
La neve, invece, è composta da cristalli di ghiaccio formatisi all’interno di una nube a temperatura negativa, quando il vapore acqueo gela direttamente attorno a microscopici nuclei solidi. I cristalli di ghiaccio si aggregano a poco a poco formando le ramificazioni (dendriti) che compongono i fiocchi di neve. Quando i fiocchi sono sufficientemente pesanti cadono al suolo.
La tromba d’aria descrive sia quelle marine sia i vortici d’aria sul terreno. In particolare quelle di terra vengono chiamate tornado, nome di origine spagnola. Questi solo alcuni esempi di alcune delle parole più conosciute riferite al clima, ecco invece quelle che dobbiamo imparare oggi per far fronte ai nuovi eventi climatici.
La parola downburst (tipica statunitense) traduce le forti raffiche di vento da temporale, molto intense, anche sopra i 200 chilometri orari. Dibow-echo invece è una parola molto tecnica che indica una curvatura che si forma quando piove e che presenta bande esterne a forme semicircolari. Una linea temporalesca che porta raffiche di vento molto veloci e piogge intense e che si è verificata, per esempio, a metà agosto scorso, tra Ferrara e Modena, causando gravi danni a case e infrastrutture.
Il termine cumulonembo deriva dal latino e spesso è il segnale dell’arrivo di un temporale. Questo sta a indicare nubi temporalesche a sviluppo verticale, grandi, spesso nere e con fulmini, con una forma a un fungo atomico. Quando il cumulonembo raggiunge la tropopausa, lo strato che separa troposfera da stratosfera, la nube si appiattisce e ne forma un’altra dalla forma di incudine appunto. Una nube in fase matura che può essere associata a fulmini o alle grandinate.
A causa della crisi climatica, però, il termine tecnico oggi è più comune è albedo e cioè quanto una superficie riflette i raggi del sole: più la superficie è chiara, più la componente riflessa è maggiore rispetto a quella assorbita.
Anche la parola derecho potrebbe diventare comune: questo è un fronte temporalesco vasto che dura nel tempo. Si sposta rimanendo sempre intatto e nella fase frontale scatena downburst.
Squall line è invece una linea di più temporali uno accanto all’altro che si sposta. Se si parla invece di parte primordiale del temporale si usa il termine cumulo congesto, e temporale grandinigeno quando arriva la grandine.
Riscaldamento globale e cambiamenti climatici, un rapporto di causa effetto da monitorare
In tema cambiamento climatico un’altra parola correlata e sempre più utilizzata negli ultimi tempi è global warming, o riscaldamento globale, un fenomeno che rende più alte le temperature medie globali per l'aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, come l'anidride carbonica. Le cause predominanti del riscaldamento globale sono da ricercare come ormai è noto, nell'attività umana per le emissioni nell'atmosfera terrestre di crescenti quantità di gas serra, che hanno generato l’incremento dell'effetto serra e ad altri fattori.
Le conseguenze del riscaldamento globale sono molte e hanno un impatto significativo sull'ecosistema e sulla vita umana. Come a esempio alcuni cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi anni, tra questi la riduzione delle riserve di ghiaccio che influisce sui cicli climatici, la perdita di habitat che sta causando la scomparsa di molte specie animali e la frequenza di eventi estremi come inondazioni, siccità e tempeste, che mettono a dura prova le comunità umane. Una delle conseguenze che preoccupa di più è sicuramente l'innalzamento del livello del mare che sta minacciando le coste e le isole, soprattutto in alcune regioni del mondo.
Questa situazione ha portato vari paesi ad adottare delle misure per cercare di limitare questo fenomeno. Le misure correttive immediate sono quelle che ruotano intorno alla riduzione della concentrazione di CO2 nell'atmosfera attraverso alcune azioni. In primis ci sarebbe l'abbattimento dell'uso dei combustibili fossili e l'utilizzo di fonti di energia alternativa o rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica. L’altra soluzione è quella del sequestro di CO2 in atmosfera grazie a una maggiore quantità di alberi piantati, oppure con l'uso di appositi filtri industriali e relativo stoccaggio.
L’aumento del riscaldamento globale è confermato anche dagli ultimi dati comparati dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) per il 2022 quando il mondo è stato almeno 1,15°C più caldo rispetto all’età preindustriale e gli ultimi 8 anni sono anche i più caldi di sempre. Con 1,15 gradi sopra la media del periodo 1850-1900, il riscaldamento globale 2022 si piazza al 5° o 6° posto tra gli anni più caldi da quando esistono le rilevazioni scientifiche. Gli ultimi 10 anni, tra il 2013 e il 2022, sono stati 1,14°C più caldi della media della seconda metà dell’800. Se vogliamo guardare all’ Italia, dove il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1800 con +1,15°C rispetto al periodo 1991-2020, il riscaldamento globale aumenta in media di 0,39°C per decennio.
Che cosa sono le emissioni di CO2?
Uno degli argomenti su cui più si dibatte in tema di ambiente è quello riguardante le emissioni di anidride carbonica (denominata CO2 dalla formula molecolare della stessa). Un gas prodotto da tantissime azioni quotidiane della nostra vita, in pratica ogni cosa che abbia a che fare con l'utilizzo dell'energia elettrica. Anche per questo, per la facilità con cui si procuce anidride carbonica persino svolgendo i compiti più elementari, agire in modo importane sulla riduzione delle emissioni è tanto complicato quanto dipendente dalla nostra volontà.
Quando l'emissione di anidride carbonica diventa pericolosa?
Le emissioni di CO2 non sarebbero un problema se fossero contenute. Il guaio per la Terra si presenta nel momento in cui l'emissione diventa superiore a quello che le fonti di assorbimento possono reggere o in generale a quanto si riesce a farne uscire dall'atmosfera del pianeta su cui viviamo. Al momento, secondo gli ultimi studi in materia, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha superato i 400 ppm (parti per milione) e cresce di 2,5 ppm ogni anno. Questo crea il fenomeno conosciuto come effetto serra, uno strato attorno all'atmosfera, invisibile, ma pericoloso per la nostra vita perché trattiene il calore e contribuisce all'innalzamento della temperatura terrestre.
Quando ancora non c'era stata la rivoluzione industriale gli equilibri naturali erano molto più facili da controllare. I livelli di CO2 erano a 270 ppm, ora sono oltre i 400 ormai dal 2020 ed è necessario (spiegano gli esperti) scendere almeno a 350 ppm, anche perché la CO2 rimarrà nell'aria per molto tempo e avrà effetti malevoli per il nostro pianeta ancora per molto tempo. Nel frattempo sarà necessario invertire la rotta e perseguire le politiche (alcune delle quali già in atto) per ridurre l'anidride carbonica.
Emissioni di CO2: gli obiettivi posti dall'Unione Europea
Proprio per questo l'Unione Europea si è data l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030. Per arrivare a questo traguardo sono stati stabiliti determinati paletti che il mondo industriale dovrà evitare di superare e sono stati previsti degli investimenti a lungo termine. Intanto sono stati eliminati i permessi di emissione gratis per l'aviazione e gli operatori marini.
I settori di industria ed energia dovranno ridurre le emissioni dal 43%al 61% ed è stato creato un fondo sociale per il clima in cui finiranno i proventi del mercato del carbonio per un totale di 70 miliardi in sette anni, grazie ai quali saranno cofinanziati i regimi di incentivazione dei singoli stati membri per l'acquisto di auto a emissioni zero e per la riqualificazione energetica degli edifici.
Nel mercato automobilistico, uno degli obiettivi è fermare la vendita di veicoli a benzina e diesel entro il 2035. Serviranno in tal senso diversi punti di ricarica e per questo saranno installate colonnine ogni 60 km per l'elettrico e ogni 160 m per l'idrogeno. Altri provvedimenti riguardano la tassazione minima, sempre su benzina e gasolio, che aumenterà mentre diminuiranno quelle per l'elettricità.
Anche grazie ai fondi europei, l'Italia ha alzato dal 33 al 43,7% gli obiettivi di riduzione delle emissioni per agricoltura, trasporti ed edifici. In tutto i Paesi aderenti all'Unione Europea dovranno contribuire entro il 2030 a tagliare le emissioni di CO2 di 310 milioni di tonnellate. Per ridurre il fenomeno le politiche nazionali e internazionali si sono dirette in particolar modo sulla produzione di energia elettrica e sull'impatto degli autoveicoli, in modo da eludere le previsioni secondo cui nel 2050 si arriverà a emissioni pari a 550-630 ppm ogni anno.
Data l'importanza del problema, gli esperti hanno provato a capire quali altri fenomeni causino l'emissione di anidride carbonica, pur in maniera minore. Il rapporto Livestock’s Long Shadow, pubblicato nel 2008 dalle Nazioni Unite, ha per esempio evidenziato nel 2008 come allora gli allevamenti di bestiame avessero emissioni anche maggiori rispetto al settore trasporti, addirittura pari a due terzi delle emissioni agricole di gas serra.
Negli ultimi anni è diventato preponderante all'interno delle nostre vite lo smartphone. Alcune delle case che producono i nuovi telefoni, così come quelle che si occupano della trasmissione del segnale, stanno portando delle attività per ridurre la produzione di CO2 dovuta a un'idea molto “usa e getta” degli smartphone, contro cui l'idea è stata quella di puntare su smartphone ricondizionati che evitano in egual modo anche l'ammassarsi dei rifiuti solidi, portati così a una seconda vita.
Cosa provoca l'aumento eccessivo dell'anidride carbonica?
Parlando di CO2 è importante porre la giusta attenzione anche alla presenza della stessa all'interno degli ambienti chiusi, dove la concentrazione rischia di crescere a livelli molto elevati, soprattutto in presenza di tante persone. Le alte concentrazioni creano infatti problemi quali mal di testa e in generale problematiche relative alle prestazioni decisionali. A confermarlo è stato uno studio portato avanti nel 2013 dagli scienziati del Lawrence Berkeley Laboratory, in California, che hanno evidenziato importanti cali di concentrazione per chi si trova in condizioni di elevata presenza di CO2.
Emissioni CO2, il problema della deforestazione
Oltre alla produzione di CO2, una delle azioni dell'uomo che sta rendendo pericolosa la sempre più dominante presenza di anidride carbonica nell'aria è la deforestazione. Tagliando gli alberi, il cui compito è anche quello di assorbire CO2 per rilasciare l'ossigeno necessario alla nostra vita, riduciamo anche la possibilità che venga ridotta la presenza di questo gas nell'aria. Proprio in virtù delle problematiche legate alla deforestazione, un altro obiettivo delle politiche comunitarie è quello di piantare tre miliardi di alberi entro il 2030.
Emissioni CO2, lo strano caso delle acque minerali
Negli ultimi tempi, paradossalmente, è diventato invece un problema per il mercato delle acque minerali la scarsa produzione di anidride carbonica. Questo perché nonostante nell'atmosfera, come detto, ce ne sia una quantità sproporzionata rispetto a quella che servirebbe, è diventato sempre meno sostenibile economicamente il processo di lavorazione per trattenere il gas e utilizzarlo nelle bibite, come nelle acque frizzanti. Il presidente di Acqua Sant'Anna, Alberto Bertone, ha dichiarato come sia diventata «letteralmente introvabile» la CO2 che ritroviamo nella bevanda più usata per dissetarci.
Un problema che non ha riguardato tutti i produttori, ma solo una parte, quella che si è affidata alle aziende i cui processi per trattenere la CO2 sono affidati alla produzione di ammoniaca e urea. Sono infatti le realtà che utilizzano grandi quantità di gas metano, oggi sempre più costoso per gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina. Aumentando il prezzo del metano, la produzione è drasticamente scesa e alcune realtà hanno dovuto affidarsi alle proprie scorte.
Chi ha coniato il termine climate change?
La persona che per prima documentò il cambiamento climatico fu Eunice Newton Foote, una suffragetta e scienziata rimasta sconosciuta fino al 2011. Per quasi duecento anni nessuno ha mai saputo niente del suo articolo intitolato “Circostanze che influenzano il calore dei raggi del sole”. Poi, dieci anni fa, un geologo in pensione di nome Ray Sorenson si imbattè in uno dei lavori della donna che, per prima, aveva stabilito una connessione tra anidride carbonica e climate change, senza ricevere mai alcun riconoscimento. E, finalmente, questa statunitense si prese i meriti che le spettavano. E che erano andati a un altro. A un uomo.
Era il 26 maggio del 1859, infatti, quando il fisico irlandese John Tyndall dimostrò alla Royal Society di Londra, una prestigiosa accademia scientifica inglese fondata nel 1660, che diversi gas potevano assorbire calore: “Così l'atmosfera ammette l'ingresso del calore solare, ma ne controlla l'uscita e il risultato è una tendenza ad accumulare calore sulla superficie del pianeta”, spiegò lo scienziato ai suoi colleghi. Era la prima volta che qualcuno scopriva e analizzava il cosiddetto “effetto serra”. O forse no? Tre anni prima, nel 1856, Eunice Foote arrivò alle stesse conclusioni. Ma nella sua lettera alla Royal Society, Tyndall sottolineò che "nulla, per quanto ne so, è stato pubblicato sulla trasmissione del calore radiante attraverso i corpi gassosi".
Eugene si trovava a ben cinquemila chilometri di distanza, nello stato di New York. Era una lontana parente di Sir Isaac Newton, il padre della legge della gravitazione universale, ed era una donna istruita: frequentò un seminario femminile e prese lezioni di scienze in un college maschile. Suo marito Elisha Foote, che sposò nel 1841, era un inventore e un giudice. Sette anni dopo i due coniugi furono tra i primi firmatari della “Declaration of Sentiments” firmata a Seneca Falls, il luogo in cui si trasferirono: si trattava di uno dei documenti fondanti del movimento femminista del Paese.
Come riporta il Washington Post, i Footes conducevano esperimenti scientifici nel tempo libero e Elisha divenne membro dell’AAAS, l’Associazione americana per l’avanzamento della scienza, che è la società scientifica che oggi pubblica la rivista Science. Nel 1856, dopo un suo intervento, l’articolo di sua moglie venne letto dal primo segretario della Smithsonian Institution, Joseph Henry, probabilmente perché venisse preso sul serio. Disse che “la scienza non è di nessun paese e di nessun sesso. La sfera della donna abbraccia non solo il bello e l’utile, ma anche il vero”. E poi lesse l’articolo in cui Eunice parlava del suo esperimento.
In quel periodo gli scienziati discutevano del perché le vette delle montagne, anche se più vicine al Sole, fossero più fredde delle valli. Alla scienziata bastarono due cilindri di vetro, quattro termometri e la luce del sole per scoprire il motivo di questa ambiguità: più anidride carbonica nell’aria significava temperature più alte. Nonostante, secondo Henry, ci fossero “molte difficoltà che precludevano qualsiasi tentativo di interpretare il loro significato”, l’articolo venne pubblicato pochi mesi dopo sull’American Journal of Science and Arts. La conclusione era questa: “An atmosphere of that gas would give the earth a high temperature”, ovvero un’atmosfera ricca di CO2 innalzerebbe la temperatura della Terra. Foote pubblicò anche altri articoli scientifici, ma poi abbandonò le sue ricerche. Il suo attivismo, però, non si fermò, così come la sua inventiva: nel 1860 ricevette un brevetto per un'imbottitura di scarpe di gomma.
Tyndall, “il padre della scienza climatica”, fu una celebrità. Continuò a fare scoperte in fisica e glaciologia fino alla sua morte, nel 1893. Diversi istituti nel mondo portano il suo nome, persino alcune vette montuose - Mounts Tyndall in California e in Australia -, numerosi ghiacciai e addirittura un cratere sulla Luna. Non sapremo mai se Tyndall abbia effettivamente rubato a Foote la sua scoperta. Ciò che è certo è che molte riviste britanniche, canadesi e tedesche fecero riferimento agli esperimenti della donna prima della scoperta di Tyndall. In particolare, quando l’’articolo apparve sul numero di novembre 1856 dell'American Journal of Science and Arts, fu poi ripreso dal Philosophical Magazine. E chi era uno dei redattori della rivista? Sì, proprio John Tyndall.
Carbon neutrality: cos’è la neutralità carbonica e come si può raggiungere?
I gravi impatti che il cambiamento climatico sta avendo sul pianeta sono ormai sotto gli occhi di tutti. Le conseguenze di questa situazione sono molteplici: siccità, alte temperature, inondazioni e frane, l’aumento del livello del mare, l’acidificazione degli oceani e la perdita di biodiversità. Queste per citare solo quelle meteorologiche, senza considerare poi quelle sociali ed economiche.
L’Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, suggerisce per questo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, la famosa Carbon neutrality, entro la metà del 21° secolo. Raggiungere la neutralità climatica è una delle maggiori sfide in questo momento per il mondo ed è anche l’obiettivo stabilito nell’Accordo di Parigi sul clima firmato da 195 Paesi.
“Carbon neutral” nel 2006 è stata la parola dell’anno del New Oxford American Dictionary e da allora si è diffusa in tutto il mondo. Secondo l’IPCC la carbon neutrality si raggiunge quando “le emissioni antropogeniche di gas serra sono compensate da una pari quantità di emissioni ridotte, evitate o sequestrate all’interno di un determinato orizzonte temporale”. Quindi, la neutralità del carbonio coincide con il raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero, bilanciandole in modo tale che siano uguali, o inferiori, alle emissioni rimosse tramite l’assorbimento naturale del pianeta. Per definizione quindi carbon neutrality indica l’equilibrio tra l’emissione di carbonio e l’assorbimento delle emissioni dai pozzi di carbonio naturali.
Per capire cosa si intende per carbon neutrality è necessario una piccola spiegazione tecnica, che parte dal capire che cosa significa zero emissioni nette e quindi il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio; per far questo l'emissione dei gas a effetto serra (GHG) dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio. Entrano in scena ora i pozzi di assorbimento dei sistemi fatti per assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle emesse. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO2 all'anno. Oggi però nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la giusta quantità di carbonio dall'atmosfera, che sia utile a combattere il riscaldamento globale. In più il carbonio conservato nei pozzi naturali viene rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi, i cambiamenti nell'uso del terreno o i disboscamenti. Per raggiungere la carbon neutrality quindi è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio.
Per compensare le emissioni di carbonio e raggiungere la carbon neutrality si può compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro grazie alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica o altre tecnologie pulite e anche con la delocalizzazione della CO2.
Dalla COP21 e con l’adozione dell’Accordo di Parigi sul clima, un numero crescente di nazioni, ma anche di organizzazioni pubbliche e imprese private, si sono impegnate per contrastare concretamente i cambiamenti climatici e per perseguire l’obiettivo comune della Climate Neutrality, prerequisito fondamentale per stabilizzare le temperature globali. La Climate Neutrality rappresenta la condizione in cui le emissioni antropogeniche di tutti i gas a effetto serra (GHG) nell’atmosfera generate da un’azienda durante un dato periodo di tempo, riescono a essere bilanciate da pari compensazioni, rimozioni o assorbimenti.
Le Strategie di Carbon e Climate Neutrality vanno quindi intese come delle tappe verso il raggiungimento dell’obiettivo finale il Net Zero Emissions, ovvero l’eliminazione totale delle emissioni nette di gas serra prodotte dall’uomo, lungo tutta la filiera produttiva di un’azienda entro il 2050. Se non si raggiunge questo, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera continuerà a salire, rendendo impossibile il contrasto al riscaldamento globale.
Come si diventa carbon neutral
Assodato che oggi uno degli obiettivi principali di un’impresa raggiungere la Carbon Neutrality, bisogna far capire alle stesse per farlo e come si diventa carbon neutral. Primo passo è quello di compensare tutte le emissioni di gas serra emesse dall’azienda e non solo anche da una specifica linea di prodotto.
Per far questo è necessario misurare la Carbon Footprint e quindi l’impatto dell’azienda o di una linea di prodotti dell’azienda in termini di emissioni di CO2. La Carbon Footprint può essere calcolata misurando le emissioni dirette e indirette dell’azienda in tre ambiti: con emissioni dirette da fonti o sorgenti all’interno dei confini organizzativi posseduti o controllati dall’azienda, che possono essere stazionarie come le caldaie a esempio, o mobili come i veicoli. Ci sono poi le emissioni indirette correlate alla combustione di combustibili associate alla produzione dell’energia finale. Vi sono infine altre emissioni indirette che si verificano nella Value Chain dell’azienda e sono le più difficili da controllare e di solito rappresentano la quota maggiore delle emissioni di un’azienda (produzione delle materie prime acquistate, viaggi d’affari, spostamenti casa-lavoro, gestione rifiuti, fasi di utilizzo e fine vita dei prodotti, ecc).
Per ricevere la certificazione carbon neutral il principale riferimento normativo è la specifica inglese PAS 2060, che detta una serie di misure e requisiti che i soggetti devono rispettare per dimostrare tale neutralità carbonica. In particolare per le aziende deve esserci un “Carbon Management Plan” che contenga riferimenti a una strategia di riduzione delle emissioni e di compensazione delle quote residue tramite crediti di carbonio, uno strumento finanziario che rappresenta la riduzione o la rimozione di una tonnellata di CO2 equivalente dall'atmosfera. Questi crediti a loro volta devono rispettare determinati criteri di qualità (addizionalità, no double counting, permanenza, ecc), verificati da una parte terza indipendente.
Azienda carbon neutral, quali i vantaggi?
Oggi non esiste ancora un regolamento che obblighi le aziende a ridurre, azzerare o compensare le proprie emissioni di gas serra. Quindi chi decide di diventare un’azienda carbon neutral, investe volontariamente risorse finanziarie soprattutto per il mercato. I consumatori, infatti tendono a orientare i loro acquisti verso quelle aziende che dichiarano di perseguire i valori legati alla sostenibilità. Quindi molte aziende carbon neutral lo sono diventate principalmente per acquisire un posizionamento più competitivo sul mercato, per raggiungere nuove fasce di consumatori, quindi per vendere di più.
I principali vantaggi nell’essere un’azienda carbon neutral, sono legati all’innovazione della proposta per ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti con un importante ritorno di immagine; costruire un posizionamento sul mercato come azienda leader sui temi della sostenibilità; fornire un contributo attivo alla riduzione delle emissioni dei propri clienti; contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU; aumentare l’attrattività e l’engagement nei confronti dell’azienda da parte degli investitori, dei clienti, dei partner, dei dipendenti e realizzare un premium price sui prodotti/servizi venduti, e quindi anche un ritorno economico.
Carbon neutrality 2050
Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° abbiamo visto quanto sia essenziale il traguardo delle emissioni zero entro la metà del ventunesimo secolo. Questo obiettivo è contenuto nell'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi. In questo Accordo l’articolo 4 recita: “Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura […], le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile […] e a intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del secolo.”
A dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il piano per rendere l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050, il Green deal europeo. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la legge europea sul clima che inserisce la neutralità climatica nella legislazione vincolante comunitaria. Nella legge europea sul clima, l'Unione Europea si impegna a raggiungere il traguardo della neutralità carbonica, le cosiddette "emissioni zero" entro il 2050.
Il Parlamento europeo ha approvato il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, ma anche una riduzione delle emissioni del 60% entro il 2030. Si richiede ai singoli stati membri di divenire climaticamente neutrali, così che dopo il 2050 la CO2 rimossa dall'atmosfera sarà maggiore che quella prodotta. Inoltre, tutti i sussidi diretti o indiretti per i combustibili fossili dovranno essere eliminati al massimo entro il 2025. Nell’aprile 2021, si è raggiunto l’obbligo per l’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ed è stato istituito anche un comitato consultivo scientifico europeo indipendente sui cambiamenti climatici, per valutare la qualità degli interventi messi in campo e monitorare i progressi fatti dai Paesi.
Chi colpisce il climate change?
Di cambiamenti climatici si sente parlare ogni giorno in tutto il mondo, a intensità e frequenza diverse a seconda del periodo, del Paese, del media di riferimento e del disastro ambientale di turno.
A soffrirne non sono però solo i ghiacciai, il suolo, i boschi, le specie animali a rischio di estinzione, ma anche e soprattutto l’uomo. A rivelarlo una ricerca pubblicata lunedì sulla rivista Nature Climate Change che ha dimostrato attraverso l’intelligenza artificiale come l’85% della popolazione mondiale sia stata colpita dai cambiamenti climatici.
I ricercatori, dopo aver analizzato e mappato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale più di 100.000 studi sugli eventi che potrebbero essere collegati al riscaldamento globale, hanno abbinato l'analisi a un set di dati sui cambiamenti di temperatura e precipitazioni causati dall'uso di combustibili fossili e da altre fonti di emissioni di carbonio.
I risultati combinati, che si sono concentrati su eventi come la mancata coltivazione, le inondazioni e le ondate di calore, hanno permesso agli scienziati di stabilire un collegamento tra l'escalation degli eventi estremi e le azioni dell'uomo. Tra le conclusioni, quella che il riscaldamento globale ha colpito l'80% della superficie terrestre del mondo: i quattro quinti di essa ha infatti subito impatti legati al surriscaldamento globale.
Solo negli Stati Uniti, i disastri ambientali hanno già causato 388 decessi e più di 100 miliardi di danni nel 2021. Oltre 1 milione di persone in Madagascar sono a rischio di morire di fame a causa di una siccità senza precedenti trasformatasi in una carestia indotta dal clima. Inondazioni catastrofiche hanno allagato interi quartieri da New York City ai campi profughi nel Sud Sudan, fino alla alluvione del secolo abbattutasi in Germania alla fine luglio di quest’anno che ha causato oltre 190 vittime e danni incalcolabili.
Si può frenare il climate change?
I cambiamenti climatici sono ormai costanti - e allo stesso tempo allarmanti - per la maggior parte del mondo: abbiamo tempo da qui al 2030 per contenere l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica di 1,5° rispetto ai livelli pre-industriali.
Questo è possibile, ma solo dimezzando l’attuale livello di emissioni al 2030 e azzerandolo entro il 2050. Per farlo abbiamo necessità di innescare un cambiamento repentino e radicale, che deve coinvolgere inevitabilmente l’innovazione tecnologica e la coscienza individuale di ognuno di noi, a cominciare dai cittadini, dalle imprese fino alle istituzioni.
Climate change: cos’è?
Il climate change indica la variazione di uno o più parametri climatici causata dall’immissione di gas nell’atmosfera, in grado di intrappolare al suo interno l’energia termica proveniente dal sole, provocando così aumento della temperatura.
I cambiamenti climatici vengono interpretati come delle variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici: queste possono avvenire in maniera naturale, oppure condizionate dall’opera dell'essere umano. A partire dal XIX secolo infatti le attività umane sono state il fattore principale all'origine della climate change, soprattutto per la combustione di gas, carbone e petrolio.
In Italia, infatti, queste fonti fossili - utilizzate per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica e termica - sono responsabili del 24% delle emissioni climalteranti. A seguire si aggiungono quelle generate dai trasporti, a cui va un altro 24%, quelle legate al settore residenziale e commerciale per il 17%, quelle del settore industriale con l’11% e del settore agricolo con il 9%.
Come frenare il climate change?
Per capire concretamente come frenare il climate change dobbiamo darci degli obiettivi ben precisi, come l’utilizzo limitato delle fonti fossili, una strategia di rigenerazione delle città e delle aree interne, un nuovo modello energetico, mobilità sostenibile e riqualificazione in chiave energetica dell’edilizia, la tutela delle foreste e del suolo, fino a una riconversione industriale ed economica a favore del paradigma circolare.
Un percorso da condividere, per cercare di capire come frenare il climate change: ecco alcuni consigli che possono fare la differenza.
Cosa posso fare per frenare il climate change?
Gli scienziati affermano che l'umanità potrebbe limitare gli effetti del climate change se ogni persona utilizzasse solo 2.000 watt di potenza all'anno. La sfida è la riduzione coscienziosa in Occidente: come fare?
Il ridimensionamento degli spazi nella propria casa, a esempio, dicono gli esperti, può portare benefici sia psicologici che finanziari: in questo modo si ha meno disordine, bollette più basse, meno spazio da pulire e più tempo da passare all'aperto.
Nei trasporti il mezzo più pulito è la bicicletta, che crea zero gas serra. Oppure, un'alternativa ancora più green, è camminare. Ma i calcoli cambieranno man mano che si passerà, nel mondo, dai combustibili fossili all'elettrico.
Cosa possono fare le imprese?
Il Mit nel 2009, tramite la Sloan Management Review, ha esaminato per la prima volta le aziende sugli sforzi per la sostenibilità, scoprendo che la maggior parte "fa solo ciò che è necessario per soddisfare i requisiti normativi".
5 anni dopo, invece, quasi due terzi delle aziende ha dichiarato che la sostenibilità era in cima alle loro agende, cosa che meno della metà aveva affermato in precedenza. Cosa è cambiato? Il senso del valore delle iniziative verdi da parte degli amministratori delegati.
Le banche ora offrono "obbligazioni verdi", che consentono agli investitori di collegare i loro soldi a cause ambientali. I green bond sono simili alle normali obbligazioni, ma finanziano progetti che mitigano il cambiamento climatico o aiutano le persone ad adattarsi. Le banche statunitensi hanno creato le proprie obbligazioni verdi: all'inizio di quest'anno una delle principali banche ha raccolto mezzo miliardo di dollari per finanziare i piani delle città per nuove capacità solari, turbine eoliche e lampioni ad alta efficienza energetica.
E le città?
Più della metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane: dal momento che queste stesse rappresentano già circa il 76% delle emissioni prodotte di CO2 derivanti dal consumo di energia, ha senso che i funzionari della città si occupino del cambiamento climatico. Così facendo, si potrà ridurre l'inquinamento, migliorare le infrastrutture obsolete e rendere le città stesse più attraenti per i residenti e le imprese.
Le piste ciclabili e i parcheggi dovrebbero essere pavimentati con cemento mangia-smog; i marciapiedi realizzati con materiali riciclati, mentre i lampioni a energia eolica e solare.
Gli edifici sono responsabili di circa un terzo di tutte le emissioni di gas serra, una cifra destinata a ridursi man mano che le città realizzino edifici municipali efficienti dal punto di vista energetico. Questo paesaggio stradale rinnovato utilizza il 42% in meno di energia rispetto al passato e costa il 21% in meno rispetto a un progetto stradale tradizionale.
Cosa possono fare le Nazioni?
Già nel 2014 il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha messo in guardia contro "impatti gravi, pervasivi e irreversibili" a meno che i gas serra non vengano ridotti. Le Nazioni sono fondamentali: le loro politiche possono stimolare o arrestare l'innovazione verde, inasprire gli standard di inquinamento o indebolirli.
Salvaguardare le foreste del mondo potrebbe fare molto per arginare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Le foreste hanno assorbito l'11% delle emissioni degli Stati Uniti nel 2013.
Anche se si stima che un terzo delle foreste mondiali sia stato abbattuto, gli esperti dicono che potremmo essere in grado di recuperare 5 miliardi di acri. Paesi come l'Etiopia e l'Uganda si sono impegnati a ripristinare 865 milioni di acri di terre degradate, che potrebbero sequestrare miliardi di tonnellate di carbonio.
E il mondo?
Con l'aumento delle emissioni globali di carbonio nel mondo, molti affermano che sono necessarie ulteriori ricerche sulla geoingegneria, che indica gli interventi deliberati su larga scala nell'ambiente planetario progettati per contrastare il cambiamento climatico.
Per cominciare, i Governi potrebbero dover concordare se provare a raffreddare una Terra surriscaldata, una misura estrema che potrebbe danneggiare alcuni Paesi e aiutare altri. Circa la metà delle emissioni globali di carbonio viene rimossa naturalmente dall'atmosfera ogni anno. Le strategie di rimozione della CO2 ideate dall'essere umano in genere stimolano i processi naturali.
Quanto costa il cambiamento climatico?
Il cambiamento climatico ha un prezzo. Non solo in termini di impatto ambientale, ma anche, in senso proprio, in quelli di risarcimento del danno. A calcolarlo è il Dartmouth College, l’istituto universitario con sede negli Stati Uniti che ha elaborato un modello per quantificare il costo delle emissioni di gas serra relativo ai singoli Stati.
L’analisi, realizzata su un campione di 143 Paesi per i quali sono disponibili i dati, ha elaborato 2 milioni di valori possibili per ciascuna interazione tra i singoli Paesi e ha processato con un supercomputer un totale di 11 trilioni (miliardi di miliardi) di valori per far fronte alle incertezze relative ai rapporti di causa-effetto.
Si apprende così che i 5 Paesi più inquinanti in fatto di emissioni - Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile e India - hanno prodotto perdite economiche complessive per 6 trilioni di dollari dal 1990 al 2014, paragonabili al 14% del prodotto interno lordo globale annuo. O ancora che i primi 10 emettitori globali sono responsabili del 67% delle perdite a fronte del 70% di benefici.
Nello stesso periodo considerato, Stati Uniti e Cina hanno causato perdite di reddito globale pari a oltre 1,8 trilioni di dollari ciascuno, mentre Russia, India e Brasile hanno prodotto singolarmente danni superiori a 500 miliardi di dollari.
«I nostri risultati sottolineano che la responsabilità del riscaldamento risiede principalmente in una manciata di grandi emettitori e che questo riscaldamento ha portato all'arricchimento degli emettitori a spese delle persone più povere del mondo - afferma lo studio, secondo cui - il riscaldamento globale fino a oggi ha amplificato e continuerà ad amplificare questo modello esistente di disuguaglianza economica globale».
«I gas serra emessi in un Paese causano il riscaldamento in un altro e questo riscaldamento può deprimere la crescita economica», ha spiegato Justin Mankin, coautore della ricerca insieme a Christopher Callahan.
A essere più svantaggiate dal riscaldamento globale sono le regioni torride dei tropici, mentre nei Paesi del Nord l’innalzamento delle temperature può favorire i raccolti e aumentare la produzione.
Se le emissioni degli Stati Uniti sono costate al Messico 79,5 miliardi di dollari di Pil perso tra il 1990 e il 2014, il loro impatto sul Canada ha fatto registrare un guadagno di 247,2 miliardi di dollari.
«L'affermazione che è possibile e scientificamente credibile collegare un singolo attore a un impatto tangibile individuale è un'affermazione che non è stata fatta in modo solido nei lavori precedenti», sostiene Callahan. Ma i ricercatori dichiarano che il nuovo metodo di calcolo fornisce stime «giuridicamente valide» dei danni finanziari connessi alle emissioni.
Secondo un rapporto dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford, il numero dei contenziosi legali legati al clima è più che raddoppiato a partire dal 2015, quando un tribunale dell'Aia ha ordinato al governo olandese di ridurre le proprie emissioni di almeno il 25% in quella che viene considerata la prima causa al mondo per responsabilità climatica.
Se la nuova metodologia verrà accolta con favore dalla comunità scientifica, potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo per accertare la responsabilità climatica degli attori coinvolti e determinare il risarcimento economico adeguato.
Servono 9 trilioni di dollari l’anno per fermare il climate change
Nessuno ha mai detto che raggiungere le emissioni zero sia cosa facile, ma secondo un rapporto di McKinsey gli investimenti attuali in nuove infrastrutture e sistemi dovrebbero aumentare del 60%.
La società di consulenza statunitense, una delle più influenti al mondo, ha stimato che serviranno 9,2 trilioni di dollari all’anno da qui al 2050 per azzerare l'impatto dell'inquinamento da gas serra come previsto dall’Accordo di Parigi, siglato nel 2015 dagli Stati membri dell’Unfcc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si tratta di 3,5 trilioni di dollari in più rispetto a quanto si sta investendo oggi. “La portata della sfida è aggravata dalla velocità con cui è richiesta” si legge nel rapporto: “Interi sistemi energetici e di uso del territorio che si sono evoluti nell'arco di un secolo o due dovrebbero essere trasformati nei prossimi 30 anni”.
Nello studio McKinsey mostra che servirà una trasformazione radicale dell'economia globale: il cambiamento dovrà interessare ogni Paese e settore, in particolare quelli legati ai combustibili fossili. Gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni sono, inoltre, opportunità di crescita e porterebbero a un’economia a basso costo e più efficiente di prima. E raggiungere le net zero (zero emissioni nette, ndr) è una condizione essenziale per evitare gli impatti più catastrofici del riscaldamento globale che danneggerebbe - già lo fa, ma in numeri minori - miliardi di persone. Più questi investimenti vengono rimandati, tra l’altro, più la trasformazione diventa costosa.
Secondo Jonathan Woetzel del McKinsey Global Institute, il think thank interno alla società che ha sfornato il rapporto, «non si tratta di un numero impossibile, ma sicuramente abbastanza grande da attirare tutta l’attenzione possibile». Raggiungere emissioni zero entro il 2050 richiederebbe una cooperazione senza precedenti da parte di tutti a livello globale, dai leader nazionali, alle società, fino ai singoli consumatori. Il team di ricerca ha identificato 9 requisiti chiave che includono non solo infrastrutture a basse emissioni di CO2, ma anche adeguamenti economici e sociali, grandi cambiamenti nell'allocazione del capitale e nella finanza e istituzioni e sostegno pubblico abbastanza forti da raggiungere i livelli desiderati. Investire in nuove tecnologie, più avanzate, non è l’unica soluzione: come spiega Mekala Krishnan, partner del McKinsey Global Institute, «circa l'85% delle riduzioni delle emissioni di cui abbiamo bisogno per arrivare a quota zero in Europa sono realizzabili con tecnologie che già esistono».
Gli autori hanno anche affermato che il rapporto non è una tabella di marcia, ma una stima approssimativa di ciò che comporta una transizione economica ben gestita, tenendo conto di tutti i fattori possibili, dalle infrastrutture alle disuguaglianze esistenti. Non è chiaro se sarà realizzabile mantenere la temperatura globale al di sotto di 1,5°C. Quel che è certo è che le Nazioni Unite hanno chiarito che per rimanere sotto i 2°C occorre porre fine alle emissioni entro il 2050. Come riporta il Guardian, la compagnia di assicurazioni Swiss Re ha stimato che i danni causati da un aumento di 2,6°C della temperatura globale entro il 2050 ridurrebbero il PIL mondiale del 14%. A ottobre, l'economista climatico Nicholas Stern ha dichiarato che «il raggiungimento delle emissioni zero può essere il grande motore di una nuova forma di crescita: quella del 21° secolo».
Si può sopravvivere alla crisi climatica?
Un manuale per la sopravvivenza dell'umanità, scritto da umani che confidano in altri umani affinché si impegnino a proteggere il futuro di tutte le specie.
Sembra fantascienza ma non lo è, tutt'altro: quello uscito dalle stanze di Interlaken, località Svizzera dove si sono riuniti gli scienziati di tutto il mondo (compresi i luminari di Russia e Ucraina) sono un insieme di «istruzioni per disinnescare la bomba climatica», come ha dichiarato il segretario generale Onu Antonio Guterres.
Dopo infinite ore di discussioni, l'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), l'organismo più importante al mondo che fornisce indicazioni relative all'andamento dell'emergenza climatica, ha chiuso e presentato il sesto ciclo di valutazione (chiamato AR6), pubblicando il Rapporto di sintesi, documento scientifico che indica ai Governi cosa è necessario fare per sopravvivere alla climate change.
Il Rapporto conferma proprio questo: è obbligatorio lavorare per rimanere sotto la famosa soglia di +1,5° decisa nell'Accordo di Parigi, altrimenti le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Per prima cosa, più gli anni passano più gli scienziati si rendono conto che, anche a temperature più basse, gli impatti dei fenomeni meteorologici sono più forti rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.
Nel documento (un testo "faro" da qui al 2030, dato che passeranno almeno altri 7 anni prima di nuove indicazioni dell'Ipcc) viene spiegato come le emissioni sono in costante aumento: abbiamo infatti raggiunto livelli record di CO2 in atmosfera, tanto da arrivare a +1,1 gradi rispetto all'epoca preindustriale.
Perché siamo arrivati a questo punto? La risposta è da ricercare soprattutto nell'utilizzo dei combustibili fossili: quasi l’80% delle emissioni arrivano dal settore energetico, industria, trasporti, edifici, il restante 20% soprattutto da agricoltura e uso dei suoli.
Fatto il danno, ora dobbiamo porci obiettivi per tentare di frenare il surriscaldamento: se vogliamo restare sotto i +1.5 gradi allora bisogna percorrere un cammino preciso che, a oggi, abbiamo circa il 50% di possibilità di raggiungere. Come fare? Per prima cosa, entro il 2030 bisogna ridurre del 48% le emissioni di CO2, del 65% entro il 2035; fra 17 anni, dobbiamo toccare quota 80% e, infine, nel 2050 sfiorare il 100%.
Senza politiche mirate per camminare lungo questa strada, il futuro delle prossime generazioni è a serio rischio, così come peggiorerà la condizione di vita in diversi Paesi del mondo. Già oggi sono gli abitanti e le specie dei luoghi meno responsabili delle emissioni a pagare il conto: le comunità vulnerabili sono colpite in maniera sproporzionata da eventi meteo, e circa 3,3/3,6 miliardi di persone vivono in contesti altamente critici per i cambiamenti del clima. Gli abitanti di queste aree hanno avuto 15 volte più probabilità di morire a causa di inondazioni, siccità e tempeste tra il 2010-2020 rispetto a quelle che vivono in regioni con una vulnerabilità molto bassa.
Lo stesso vale per gli ecosistemi: alcuni, come quelli dell'Artico, si stanno avvicinando a un punto di non ritorno tra ritiro dei ghiacciai e disgelo del permafrost. Vale anche per le persone, se si guarda a come è compromessa la sicurezza idrica e alimentare: stanno aumentando i tassi di mortalità e le malattie, così come gli sfollamenti in Africa, Asia, Nord America e America centrale e meridionale o le isole del Pacifico. Tutto ciò, oltretutto, non fa che aumentare le disuguaglianze sociali.
Detto questo, possiamo ancora salvarci? La risposta, nel manuale di sopravvivenza, è "Sì" ma dobbiamo migliorare tante cose, a partire dalle politiche di adattamento (oggi giudicate al di sotto delle necessità, soprattutto perché non equamente distribuite). Ma anche per i livelli di liquidità e finanziamenti per il clima le scelte intraprese sono finora inadeguate (troppi investimenti nel fossile, per esempio).
Stesso discorso per le politiche di mitigazione: i finanziamenti tracciati sono ancora al di sotto dei livelli necessari per limitare il riscaldamento a 2°C o 1,5°C. Questo anche perché molti Paesi non stanno attuando (o ancora non ne ha uno) piani nazionali di contrasto alla crisi del clima: senza inversione di rotta, fanno sapere dall'Ipcc, arriveremo a un riscaldamento globale di 3,2°C entro il 2100.
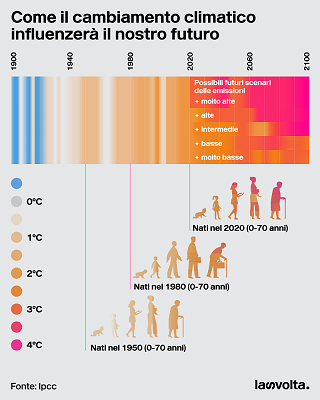
Eppure, in questo scenario preoccupante, ci sono anche buone notizie: sviluppi rapidi dell'energia solare ed eolica, l'elettrificazione dei sistemi urbani, i piani green delle città, la protezione delle foreste, la riduzione in certe aree del consumo di suolo o degli sprechi alimentari. Il punto è che queste buone pratiche, per essere davvero efficaci, necessitano di politiche immediate (come decarbonizzazione e taglio alle emissioni). Perché in un mondo più caldo, le opzioni di adattamento e mitigazione che oggi abbiamo non è detto che funzioneranno.
"Il lavoro è vitale, urgente e possibile. Un futuro resiliente e vivibile è ancora a nostra disposizione, ma le azioni intraprese in questo decennio per ottenere tagli alle emissioni profondi, rapidi e sostenuti rappresentano una finestra che si sta rapidamente restringendo per consentire all'umanità di limitare il riscaldamento a 1,5°C con un overshoot minimo o nullo" sostengono gli scienziati, sottolineando anche l'importanza di impegnarci per il ripristino della natura, la più preziosa alleata contro il surriscaldamento, dato che nell'ultimo decennio ha assorbito circa il 54% delle emissioni di anidride carbonica prodotte dalle attività umane.
E tutto questo vale ovunque, in ogni Paese, anche per la nostra Italia che, come ha ricordato uno degli autori del rapporto, Piero Lionello, «è soggetta ai rischi tipici dell'Europa Mediterranea, alcuni dovuti a peculiarità del cambiamento climatico, altri alla particolare vulnerabilità di ecosistemi e settori produttivi: dalla diminuzione della precipitazione alla vulnerabilità delle coste, all'importanza economica del settore turistico alla vulnerabilità degli ecosistemi terrestri e marini, minacciati anche da sovrasfruttamento e inquinamento».
Tutte queste informazioni ora sono nelle nostre mani: a noi scegliere se trattarle come un bugiardino da ignorare, nonostante contenga le soluzioni per la cura, oppure come un vero manuale di istruzioni per riparare i danni fatti.
«La bomba climatica - spiega Antonio Guterres, Segretario Generale Onu - scandisce i secondi. Ma il rapporto Ipcc è una guida pratica per disinnescare la bomba a orologeria climatica. Come il rapporto mostra, il limite di 1,5 gradi è realizzabile. Ma ci vorrà un salto di qualità nell'azione per il clima. Ciascun Paese deve essere parte della soluzione. Chiedere agli altri di fare la prima mossa, vuol dire soltanto essere certi che l’umanità arriverà per ultima».
La sostanza, ricordano anche i think tank e i gruppi di lavoro italiani che da anni seguono da vicino i rapporti Ipcc e le Conferenze delle parti sul clima, è che per invertire davvero la rotta non si può più perdere tempo.
Il rapporto di sintesi è infatti «l’ennesima conferma di una situazione critica e di una scienza inascoltata – chiosa Serena Giacomin, Presidentessa di Italian Climate Network – Gli assessment report dell’Ipcc sono la rassegna scientifica più approfondita e accreditata sul cambiamento climatico a disposizione dell’umanità. In particolare, questo report si appoggia su una mole di dati ed evidenze di enorme valore strategico. Dobbiamo imparare a utilizzare questi dati per analizzare il presente e scegliere il nostro futuro. Dobbiamo superare il livello di mera consapevolezza del problema climatico – necessario, ma non sufficiente - e applicare i dati con strategie di azione».
«La scienza parla chiaro – spiega Giacomin –, il tempo per agire con azioni di adattamento e mitigazione è poco, ma gli strumenti conoscitivi e tecnologici ci sono. Non serve altro che la volontà. Come Italian Climate Network facciamo un appello al mondo della comunicazione, perché si stringa al mondo scientifico e lo aiuti a superare le barriere del dubbio e del ritardo d’azione. Collaborazione e senso costruttivo sono alla base di un processo di sviluppo sostenibile, la transizione di cui abbiamo bisogno non è solo ecologica, ma culturale. La scienza non ha dubbi, così non si può andare avanti e più aspetteremo più gli impatti della crisi climatica saranno difficili da sopportare».
Il climate change è anche una questione di salute fisica?
Quando parliamo della minaccia rappresentata dal cambiamento climatico pensiamo, prevedibilmente, agli effetti devastanti sull’ambiente, che modificheranno drammaticamente e irreversibilmente l’aspetto del Pianeta. Quello a cui pensiamo meno, è l’impatto di queste trasformazioni non solo sul tessuto sociale ed economico globale, ma anche sulla salute pubblica. E sbagliamo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, il global warming rappresenta la più grande minaccia sanitaria per l'umanità. I cambiamenti climatici influiscono sui fattori sociali e ambientali determinanti per la salute: aria pulita, acqua potabile e sicura, cibo a sufficienza e possibilità di trovare un riparo sicuro.
Non solo la disintegrazione degli ecosistemi causata dalla combinazione letale di deforestazione, urbanizzazione, inquinamento e cambiamento climatico ha portato a una sempre maggiore frequenza di epidemie legate a zoonosi (di cui la pandemia di Covid-19 è solo una manifestazione), ma la qualità dell’aria è drasticamente compromessa in molte regioni del Pianeta e l’aumento delle temperature ha effetti devastanti non solo sui territori ma anche sulle persone che li abitano. Già oggi, il 24% di tutti i decessi globali è legato a fattori ambientali e si prevede che la malnutrizione, la malaria, la diarrea e lo stress da caldo legati ai cambiamenti climatici provocheranno 250.000 morti in più ogni anno tra il 2030 e il 2050.
Un costo enorme, non solo in termini di vite umane, ma anche a livello economico: i costi dei danni diretti per la salute, infatti, sono stimati tra i 2 e i 4 miliardi di dollari all'anno entro il 2030.
A pagare il conto saranno i Paesi che hanno contribuito meno alle cause del riscaldamento globale, in particolare i Paesi in via di sviluppo con infrastrutture sanitarie deboli, che sono quelli meno attrezzati per proteggere le loro popolazioni e, quindi, saranno i più colpiti.
Allo stesso tempo, a essere esposti ai rischi maggiori saranno i più vulnerabili e svantaggiati, comprese le donne, i bambini, le minoranze etniche, le comunità povere, i migranti o gli sfollati, le popolazioni più anziane e quelle con condizioni di salute di base. Il cambiamento climatico, infatti, sta già incidendo sulla salute minando molti degli elementi fondamentali per una buona salute, come i mezzi di sussistenza, l'uguaglianza e l'accesso all'assistenza sanitaria e alle strutture di supporto sociale.
Stimare con precisione la portata e l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana è una sfida, ma non ci sono dubbi: la correlazione è inequivocabile.
A rischio ci sono gli ultimi cinquant'anni di progressi in materia di sviluppo, salute globale e riduzione della povertà: se non interrompiamo immediatamente questa tendenza, le disuguaglianze sanitarie esistenti tra e all'interno delle popolazioni peggioreranno.
Questo significa, spiega il WHO, che non solo la realizzazione della copertura sanitaria universale (UHC) è a repentaglio, ma che ad aggravarsi potrebbe essere anche l'attuale carico di malattie e che le barriere esistenti all'accesso ai servizi sanitari potrebbero aumentare, spesso nei momenti in cui questi servizi sono più necessari.
Oltre 930 milioni di persone - circa il 12% della popolazione mondiale - spendono già almeno il 10% del budget familiare per pagare l'assistenza sanitaria, mentre 100 milioni di persone ogni anno scendono sotto la soglia della povertà a causa delle spese sanitarie. Una tendenza che il cambiamento climatico può solo peggiorare.
Il WHO ha avvertito: se nel medio termine gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute saranno determinati principalmente «dalla vulnerabilità delle popolazioni, dalla loro resilienza all'attuale tasso di cambiamento climatico e dalla portata e dal ritmo dell'adattamento», a lungo termine, gli effetti dipenderanno dalle misure che verranno intraprese per contrastarli.
Per evitare impatti catastrofici sulla salute e prevenire milioni di decessi legati ai cambiamenti climatici, il mondo deve limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, ha spiegato l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ogni decimo di grado aggiuntivo avrà un grave impatto sulla vita e sulla salute delle persone.
Il cambiamento climatico compromette anche la salute mentale?
Nel 2009 l’Istituto per la salute globale della University College London descriveva il cambiamento climatico come “potenzialmente la più grande minaccia per la salute globale nel ventunesimo secolo”, con effetti negativi sulla salute fisica e non solo.
Infatti, da alcuni anni ormai, molti studi tentano di definire al meglio le relazioni fra cambiamenti climatici e salute mentale. È in questo quadro di ricerca scientifica che termini come “eco-ansia” hanno iniziato a far capolino.
Attualmente, questa espressione viene definita come “la paura cronica della rovina ambientale” o ancora “la sensazione generalizzata che le basi ecologiche dell’esistenza siano in procinto di crollare”.
Grazie a queste ricerche, la preoccupazione di moltissime persone che vedono nei cambiamenti climatici una reale minaccia per il proprio futuro, ha finalmente un nome.
Tuttavia, l’aumento di temperatura globale, di umidità e gli eventi meteorologici estremi rappresentano una nuova costellazione di rischi per i disturbi mentali comuni che non sono ancora stati indagati a fondo, soprattutto nei Paesi a basso reddito.
Un gruppo di ricercatori della Georgetown University e della George Washington University ha cercato di colmare proprio questa lacuna, pubblicando recentemente su The Lancet Planetary Health uno studio condotto in Bangladesh.
Il Global Climate Risk Index ha classificato il Bangladesh come il settimo Paese più vulnerabile al mondo relativamente ai cambiamenti climatici. La popolazione è costretta, ormai da anni, ad affrontare fenomeni estremi come il ciclone tropicale Sitrang, che il 24 ottobre 2022 ha provocato la morte di almeno 35 persone e più di 1 milione di sfollati.
In quell’occasione, nella capitale Dhaka sono stati registrati 434 millimetri di pioggia in 48 ore, una quantità cinque volte maggiore rispetto alle precipitazioni medie del mese di ottobre. Eventi come questo rendono sempre più necessaria l’adozione di misure di mitigazione e adattamento, non solo da un punto di vista economico ma anche per prevenire e contenere gli effetti del riscaldamento globale sulla salute mentale.
I risultati riportati su The Lancet Planetary Health mostrano una prevalenza complessiva, nella popolazione bangladese, del 16,3% per la depressione e livelli di ansia del 6%: dati notevolmente superiori alle stime proposte dall’Oms nel 2017 che indicavano una prevalenza, a livello globale, di depressione del 4,4% e di ansia del 3,6%.
L'esposizione al peggioramento delle inondazioni, legate al cambiamento climatico, nella regione è stata attribuita a un aumento delle probabilità di tutte le condizioni: depressione del 31%, ansia del 69% e presenza di entrambe dell'87%.
La relazione, riscontrata nello studio, tra cambiamenti climatici e disturbi mentali rappresenta un campanello d’allarme per popolazioni come quella del Bangladesh, la cui disponibilità di risorse per l’assistenza alla salute mentale è molto bassa. Come indicato dallo studio, nel 2021, il numero di psichiatri era di 1 su 625.000 abitanti mentre il numero di psicologi era di 1 su circa 294.000 abitanti.
Tendenzialmente, i Paesi che soffrono maggiormente gli impatti del cambiamento climatico sono quelli che hanno contribuito di meno alla genesi del fenomeno.
Le future generazioni rischiano, quindi, non solamente di vivere in condizioni ambientali peggiori delle nostre ma anche di affrontare effetti sulla salute mentale sempre più pesanti. La situazione descritta per il Bangladesh potrebbe sembrarci lontana, ma in realtà ci coinvolge molto più di quello che potremmo pensare.
La regione in cui viviamo, il Mediterraneo, rappresenta infatti un hotspot per i cambiamenti climatici ovvero una di quelle zone in cui le conseguenze del riscaldamento globale saranno più severe.
Per questo è prioritario discutere degli impatti dei cambiamenti climatici anche sulla nostra salute mentale, per capire in che modo sviluppare interventi e offrire servizi mirati, non solamente per noi ma anche per tutte quelle comunità che sono più a rischio.
Che cos’è l’ansia climatica?
Immaginate una giornata in cui, nonostante la vostra ferrea volontà di cambiare le cose per un mondo migliore, non riuscite a trovare al supermercato un prodotto non avvolto dalla plastica.
Oppure, mentre passeggiate su una spiaggia, non vi date pace per la quantità di rifiuti. O ancora, sono giorni che avete a che fare con piogge sempre più intense, grandinate improvvise, aria irrespirabile. A fine giornata poi le notizie vi raccontano di disastri climatici, inondazioni, ghiacci che si sciolgono. Dentro di voi - e questi sono soltanto esempi – potrebbe nascere un senso di colpa, di vergogna, d'impotenza, uno stato di difficoltà, come ha raccontato di recente il New York Times riportando storie di persone a cui è accaduto.
Quello che sentite potrebbe essere "ansia climatica", chiamata anche "eco ansia" o con altri nomi, ma in sostanza generata da un senso di impotenza e di paura per quanto sta accadendo al Pianeta.
Capita sempre più spesso, dai giovani della generazione verde agli adulti preoccupati per il futuro: anche per questo, ormai da qualche anno, stanno nascendo sempre più percorsi terapeutici per affrontare il problema. A Portland per esempio, racconta il Nyt, da tempo lo psicologo Thomas J. Doherty si è specializzato nell'aiutare ad affrontare proprio l'ansia climatica o le paure legate al surriscaldamento globale.
Già oggi, soprattutto negli Usa, la Climate Psychology Alliance fornisce un elenco online di terapisti sensibili al clima e la Good Grief Network, rete di supporto, sostiene gruppi con programmi di certificazione professionale in psicologia del clima. Fra i pazienti, ha raccontato Doherty, ci sono giovani 18enni con attacchi di panico, geologi anziani che hanno paura per il futuro del mondo, persone che non riescono ad accettare le scelte consumistiche di amici e parenti e via dicendo.
Spesso il senso di impotenza legato a questi possibili disturbi è dato anche dall'impossibilità di cambiare le cose: sebbene nel quotidiano una persona si impegni a rispettare il Pianeta attraverso diverse azioni sostenibili, poco può fare rispetto al problema generale della quantità di emissioni climalteranti. L'inazione stessa dei governi nell'affrontare la crisi climatica, acuisce poi diverse sensazioni in chi è sensibile a questi problemi.
Sul tema sono stati realizzati anche sondaggi in 10 Paesi su 10.000 persone come campione, tutte di età tra i 16 e i 25 anni, con risultati pubblicati su The Lancet: il 45% degli intervistati ha affermato che la preoccupazione per il clima ha influito negativamente sulla propria vita quotidiana. Tre quarti hanno anche sostenuto di ritenere che "il futuro è spaventoso" e il 56% che "l'umanità è condannata".
Sebbene sia un senso angosciante, secondo gli esperti l'ansia climatica è qualcosa di razionale e non implica malattie mentali o altro, ma è soprattutto legata a fattori di stress dovuti alle aspettative per il futuro. A livello emotivo si possono provare sentimenti come disperazione, senso di colpa, preoccupazione, paura, rabbia, dolore, vergogna.
Tutte condizioni che, già da oggi, stanno portando sempre più terapisti a cercare di documentarsi su quella che è la più grande emergenza del Pianeta, la crisi climatica, e a fornire ai pazienti gli strumenti per poter affrontare i timori che questa comporta.
Il climate change è portatore di nuovi virus?
Torna sul banco degli imputati il cambiamento climatico. Insieme a uno dei possibili effetti che porta con sé. Il divampare di nuove pandemie.
Lo scambio di virus tra specie animali sembra essere direttamente collegato all’aumento della temperatura terrestre, e a tutte le conseguenze che ne derivano. Lo attesta un nuovo studio, pubblicato su Nature, nel quale si prevede che entro i prossimi 50 anni gli effetti della crisi climatica potrebbero indurre oltre 15.000 scambi di virus tra mammiferi. Questo perché il climate change comporterà un mutamento spaziale degli habitat della fauna selvatica, incrementando gli incontri tra specie e dunque la possibilità di trasmettere agenti patogeni.
Lo studio, tra i primi a quantificare quante volte potrà verificarsi uno spillover, da una parte avverte che l’esplosione di più focolai rappresenterebbe una seria minaccia per la salute umana e animale, dall'altra cerca di fornire ai governi e alle organizzazioni sanitarie un motivo in più per investire nella sorveglianza dei patogeni e nel miglioramento delle infrastrutture sanitarie.
«Questo lavoro ci fornisce prove più incontrovertibili sul fatto che i prossimi decenni non saranno solo più caldi, ma anche più malati» afferma Gregory Albery, ecologista delle malattie presso la Georgetown University di Washington DC e coautore dello studio. Per fare le loro previsioni, per 5 anni Albery e i colleghi hanno combinato modelli di trasmissione del virus e distribuzione delle specie in vari scenari di cambiamento climatico, concentrandosi sui mammiferi per la loro rilevanza per la salute umana.
Il modello di trasmissione del virus prevede la probabilità che un virus salti tra le specie per la prima volta, analizzando dove le specie potrebbero incontrarsi quando i loro habitat muteranno e quanto siano strettamente correlate dal punto di vista evolutivo. Infatti, si legge nello studio, è più probabile che i virus si trasmettano tra specie correlate.
La ricerca prevede che gran parte della nuova trasmissione del virus avverrà quando le specie si incontreranno per la prima volta mentre si spostano in luoghi più freddi. Secondo gli autori dello studio, questo accadrà più spesso ad alta quota negli ecosistemi ricchi di specie, in particolare nelle aree dell'Africa e dell'Asia, e in aree densamente popolate da esseri umani, tra cui la regione africana del Sahel, l'India e l'Indonesia.
Supponendo che il surriscaldamento del Pianeta si mantenga entro i +2 °C rispetto al periodo preindustriale, il numero di inediti incontri tra le specie raddoppierà entro il 2070.
In tutto questo, i pipistrelli potrebbero essere i protagonisti di questo quadro a tinte fosche. Noti serbatoi di virus, costituiscono circa il 20% dei mammiferi e, in parte perché in grado di volare, hanno meno probabilità di incontrare ostacoli allo spostamento dei loro habitat.
Ad oggi rimane però difficile ipotizzare le conseguenze dirette sulla salute umana.
«Prevedere il rischio di salti virali dai mammiferi all'uomo è più complicato, poiché queste ricadute si verificano in un complesso ambiente socioeconomico, ecologico e umano», ha spiegato Kate Jones, esperta di modelli che analizzano le interazioni tra ecosistemi e salute umana all'University College di Londra.
Tuttavia, i ricercatori esortano a non perdere tempo: il Pianeta si è già riscaldato di oltre 1 °C rispetto al periodo preindustriali e questo sta guidando la migrazione delle specie. Dunque anche lo scambio di malattie.
Proprio per questo, i ricercatori chiedono ai governi e alla comunità internazionale di migliorare il monitoraggio e la sorveglianza degli animali selvatici e delle malattie zoonotiche, in particolare nei futuri hotspot come il sud-est asiatico. Per lo stesso motivo, lo stop alla deforestazione sarà strategie indispensabile a scongiurare il peggio.
Il climate change può aggravare le malattie infettive?
Oltre ad aggravare le condizioni atmosferiche del Pianeta, i cambiamenti climatici hanno un effetto negativo anche sulle malattie infettive che colpiscono gli esseri umani.
Secondo uno studio pubblicato sulla celebre rivista scientifica Nature, inondazioni, ondate di calore e siccità hanno aggravato più della metà di quelle conosciute finora, tra cui malaria, epatite e colera.
I ricercatori e le ricercatrici di varie università, tra cui quella delle Hawaii, negli Stati Uniti, e di Göteborg, in Svezia, hanno esaminato decenni di articoli scientifici (circa 77.000 in totale) sui casi accertati di malattie patogene e hanno scoperto che 218 delle 375 conosciute sembravano peggiorate da uno dei 10 tipi di condizioni meteorologiche estreme legate al cambiamento climatico: riscaldamento atmosferico, ondate di calore, siccità, incendi, forti precipitazioni, inondazioni, tempeste, innalzamento del livello del mare, riscaldamento degli oceani e cambiamento della copertura del suolo.
Il team composto da 11 scienziati e scienziate ha scoperto che il cambiamento climatico influenza più di 1000 vie di trasmissione, quindi ha tracciato in una mappa interattiva un database di rischi climatici, vie di trasmissione, agenti patogeni e malattie.
Sul sito di informazione The Conversation, a cui collaborano accademici e ricercatori da tutto il mondo, alcuni autori dello studio, Tristan McKenzie, Camillo Mora e Hannah von Hammerstein, spiegano che, per essere in grado di prevenire le crisi sanitarie globali, "l'umanità ha bisogno di una comprensione completa dei percorsi e dell'entità con cui il cambiamento climatico potrebbe influenzare le malattie patogene”.
Hanno rilevato che il maggior numero di malattie aggravate dai cambiamenti climatici riguarda la trasmissione tramite vettori, che possono essere zanzare, pipistrelli o roditori.
Invece, considerando il tipo di rischio climatico, hanno scoperto che la maggior parte era associata al riscaldamento atmosferico (160 malattie), alle forti precipitazioni (122) e alle inondazioni (121).
Queste ultime, a esempio, “possono diffondere l'epatite. L'aumento delle temperature può prolungare la vita delle zanzare portatrici della malaria. La siccità può portare roditori infetti da hantavirus (il virus della febbre emorragica, ndr) nelle comunità mentre cercano cibo. Gli oceani riscaldati e le ondate di calore contaminano i frutti di mare di cui ci cibiamo”, spiegano sul sito.
Ma come fa il clima a influenzare il rischio di agenti patogeni? In quattro modi: avvicinando gli agenti patogeni alle persone e viceversa, aumentandoli, e indebolendo la capacità dell’organismo di reagire.
Non è la prima volta che i medici collegano malattie e clima, ma questo studio mostra quanto sia diffusa l'influenza delle condizioni atmosferiche sulla salute umana. Il dottor Jonathan Patz, co-autore dello studio e direttore del Global Health Institute dell'Università del Wisconsin-Madison, ha spiegato all’agenzia Associated Press che «se il clima sta cambiando, anche il rischio di queste malattie sta cambiando». Le patologie, ha detto, dovrebbero essere considerate come i sintomi di una Terra malata.
Oltre a esaminare le malattie infettive, i ricercatori hanno ampliato il discorso anche a quelle non infettive come l'asma, le allergie e persino i morsi di animali: delle 286 analizzate, 223 sembravano essere peggiorate da almeno un rischio climatico, solo 9 erano state ridotte e 63 attenuate.
Camilo Mora, analista di dati climatici presso l'Università delle Hawaii, ha specificato a Associated Press che lo studio non riguarda la previsione di casi futuri: «Non c'è nessuna speculazione qui, sono cose che sono già successe». Per esempio, nel 2016, in Siberia, una carcassa di renna vecchia di decenni morta per antrace, un’infezione batterica molto rara ma altrettanto grave, è stata portata alla luce quando il permafrost si è scongelato a causa del riscaldamento: un bambino l'ha toccata, è stato infettato e ha dato vita a un focolaio.
Per quanto riguarda il Covid-19, sono stati trovati casi in cui il clima estremo ha sia esacerbato che diminuito le possibilità di contagio: il caldo estremo nelle aree povere ha fatto radunare le persone per rinfrescarsi e le ha esposte di più alla malattia, ma in altre situazioni i forti acquazzoni ne hanno ridotto la diffusione perché le persone sono rimaste a casa e al chiuso, lontano dagli altri.
L'esperta di lunga data del clima e della salute pubblica Kristie Ebi della Washington University ha espresso alcuni dubbi sullo studio: «Gli autori non hanno discusso in che misura i rischi climatici esaminati siano cambiati nel periodo di tempo dello studio e in che misura eventuali cambiamenti siano stati attribuiti al cambiamento climatico».
Ma il dottor Aaron Bernstein, direttore a interim del Center for Climate, Health, and the Global Environment presso la Harvard School of Public Health, ha detto si tratta di un buon avvertimento sul clima, sulla salute e il futuro, soprattutto perché il riscaldamento globale e il danneggiamento degli habitat spingono gli animali e le loro malattie a spostarsi più vicino agli esseri umani.
Cosa si può fare a riguardo? “A nostro avviso, per ridurre il rischio, l'umanità dovrà porre un freno alle emissioni di gas serra causate dall'uomo che alimentano il riscaldamento globale”, scrivono gli autori.
Quali sono gli effetti del climate change sul sonno?
Vi è mai capitato di svegliarvi poco riposati o accusare maggiore stanchezza quando fa caldo? Sicuramente sì, ma solo recentemente è stato dimostrato che esiste un legame tra l’aumento delle temperature e come dormiamo.
Ormai la comunità scientifica concorda sul fatto che il riscaldamento globale influenza la nostra salute e il nostro benessere, ma, fino a oggi, non era mai stata provata nessuna connessione tra il cambiamento climatico e la durata e la qualità del sonno.
Questa informazione ci viene rivelata in un studio effettuato da un gruppo di cinque ricercatori dell’Università di Copenaghen, della Technical University della Danimarca e del Max Planck Institute for Human Development di Berlino e pubblicato il 20 maggio su One Earth.
Lo studio effettuato spiega, infatti, che l’aumento delle temperature globali influisce sulle ore di riposo, ritarda l’ora in cui andiamo a dormire e provoca un sonno agitato.
Ma ciò che è più scioccante è che, secondo i ricercatori, questo avverrebbe in modo considerevole già dall’inizio del XXI secolo. E in generale, dormiremo sempre meno man mano che le temperature aumentano.
I ricercatori sostengono, in particolare, che il cittadino medio sta già perdendo 44 ore di sonno ogni anno e, per almeno 11 notti, dorme meno di 7 ore, considerata la durata minima che ognuno di noi dovrebbe dormire. Anzi, hanno stimato che se il riscaldamento globale aumenta con questo ritmo, la perdita individuale di sonno potrebbe aumentare fino a 50-58 ore all’anno entro il 2099.
Questo comunque non vale per tutti. Lo studio rivela che, nonostante l’innalzamento delle temperature notturne si verifichi in tutto il mondo, le conseguenze vengono percepite maggiormente dai gruppi e dalle comunità di per sé già vulnerabili e aggravano le disuguaglianze ambientali esistenti e reiterate attraverso i sistemi di sviluppo sociale, economico ed educativo.
Le popolazioni con un basso reddito e/o che vivono nelle regioni più calde, in particolare, accusano di più l’innalzamento delle temperature. All’interno di queste, poi, sono le donne e gli anziani i soggetti più suscettibili, a causa di alterazioni nel processo di raffreddamento del loro corpo, fondamentale per poter dormire bene, e, di conseguenza, a un sonno più agitato e/o più breve.
Per condurre questo studio, i ricercatori hanno analizzato miliardi di misurazioni di braccialetti per il monitoraggio del sonno, o “sleep-trackers”, considerando il più grande campione mai usato composto da 47.000 persone provenienti da 68 Paesi per 7 milioni di notti.
Questi dati sono stati, poi, messi a confronto con il meteo giornaliero di tutti i Paesi di origine di ogni individuo appartenente al campione stesso.
E perché è importante sapere se la qualità e la durata del sonno vengono influenzati dal cambiamento climatico? Semplicemente, perché ci riguarda. È solo l’ultimo esempio di come la crisi climatica influenzi la nostra salute fisica e mentale.
Un sonno insufficiente, infatti, aumenta il rischio di problemi fisiologici, comportamentali, sociali ed economici. Può portare, per esempio, a una maggiore aggressività o ipertensione, a complicazioni cardiache, a una minore concentrazione e, più in generale, a una compromissione del funzionamento di tutto il sistema immunitario.
Ma soprattutto ci riguarda perché, per evitare di dormire sempre meno a causa del caldo, è necessario investire in progetti ambientali e psicosociali per proteggere, in modo equo, tutta la popolazione mondiale
Il climate change è un motivo per non fare più figli?
Che senso ha fare figli su un Pianeta che sta bruciando? È un atto d’amore o di egoismo? Siamo già oltre 7 miliardi su questa Terra sovrappopolata, c’è davvero bisogno di altre persone? Possiamo davvero permetterci di mettere al mondo bambini che aumenteranno il tasso di inquinamento già critico?
Quelle che avete appena letto non sono solo domande retoriche, ma riflessioni etiche e sociali che spingono un numero sempre maggiore di persone a decidere di non fare figli, unendosi idealmente al movimento childfree che acquista un peso via via maggiore.
Secondo una ricerca della società Morning Consult, tra gli adulti senza figli negli Stati Uniti uno su quattro cita il cambiamento climatico come un fattore del motivo per cui attualmente non ha figli, mentre già nel 2018 il 33% dei giovani americani che si aspettavano di avere meno bambini rispetto al numero che consideravano ideale aveva indicato il cambiamento climatico come causa, mentre il 27% aveva identificato il problema nella crescita della popolazione mondiale.
Non solo l’inquinamento contribuisce alla denatalità impattando negativamente sulla fertilità, ma l’aumento delle temperature dovuto ai gas serra e le sue conseguenze catastrofiche sarebbero quindi direttamente legati a un calo delle nascite.
Questo non è connesso solo agli effetti degli shock termici sulle attività riproduttive – secondo uno studio che ha analizzato i trend negli Usa dal 1931 al 2010, i giorni con una temperatura media superiore a 26°C causano un forte calo dei tassi di natalità da 8 a 10 mesi dopo – ma anche a una scelta deliberata e consapevole.
Cambiamento climatico e denatalità: di cosa (anzi, di dove) parliamo
Una premessa è necessaria. Quando si parla di denatalità e cambiamento climatico, sarebbe più corretto dire che in alcune zone del Pianeta si fanno meno figli (anche) per colpa del cambiamento climatico.
Nei Paesi in via di sviluppo – dove secondo un report delle Nazioni Unite 1 madre su 3 è bambina o adolescente – infatti, tra gli effetti del global warming c’è anche quello di aumentare le gravidanze e i parti prima dei 17 anni, sconvolgendo i mezzi di sussistenza delle famiglie e lasciando le ragazze fuori dalla scuola, rendendole più vulnerabili. Un fenomeno che si traduce in una maggiore fertilità di queste madri, perché secondo lo studio le ragazze che partoriscono in età adolescenziale hanno maggiori probabilità di partorire altre quattro volte prima dei quarant’anni.
Niente figli: perché?
Chi sceglie di non fare figli per paura del cambiamento climatico lo fa principalmente per due motivi: la paura di costringere un bambino a sopravvivere a quelle che potrebbero essere condizioni apocalittiche e il timore di amplificare i danni del riscaldamento globale e dell’inquinamento.
«Il mondo ha bisogno di più persone?» aveva chiesto la poetessa e saggista Katha Pollitt in un saggio su The Nation. «Non se chiedi ai ghiacciai, alle foreste pluviali, all'aria o alle oltre 37.400 specie sull'orlo dell'estinzione grazie all'inarrestabile espansione degli esseri umani in ogni angolo e anfratto del nostro pianeta surriscaldato».
Stando ai dati, i nuovi nati rappresenterebbero effettivamente una fonte di inquinamento aggiuntiva. «Avere un figlio è 7 volte peggio per il clima a livello di emissioni di CO2» secondo gli analisti della banca d'affari Morgan Stanley, che spiegano: ogni bambino nato nei Paesi sviluppati ha un'impronta di carbonio di 58,6 di tonnellate all'anno.
Un’affermazione che trova riscontro in uno studio svedese pubblicato su IOPscience nel 2017, che ha rilevato che avere un figlio in meno per famiglia potrebbe far risparmiare circa 58,6 tonnellate di carbonio ogni anno nei Paesi sviluppati.
Secondo Kimberley Nicholas, una delle autrici dello studio, però, ridurre la popolazione – o portarla all’estinzione, come vorrebbero alcuni attivisti radicali antinatalisti – non è il modo per risolvere la crisi climatica: «È vero che più persone consumeranno più risorse e causeranno più emissioni di gas serra. Ma questo non è il periodo di tempo rilevante per stabilizzare effettivamente il clima, dato che abbiamo questo decennio per dimezzare le emissioni».
Il fattore ambientale, del resto, non sembra essere determinante per tutti coloro che scelgono di non avere figli a causa del cambiamento climatico. Secondo lo studio Le preoccupazioni eco-riproduttive nell'era del cambiamento climatico – che ha intervistato le persone di età compresa tra 27 e 45 anni che stavano prendendo in considerazione le preoccupazioni climatiche nelle loro scelte riproduttive – solo il 60% degli intervistati era molto agitato per l’impronta ambientale dei futuri nati. A essere più preoccupati per l'impatto sul clima che i loro figli avrebbero subito erano, significativamente, gli intervistati più giovani.
Fare figli in un mondo che muore
«Le paure sull'impronta di carbonio dell'avere figli tendevano a essere astratte e aride», ha affermato Matthew Schneider-Mayerson, dello Yale-NUS College di Singapore, che ha guidato lo studio. «Ma le paure sulla vita dei bambini esistenti o potenziali erano davvero profonde ed emotive».
Non sorprende, quindi, che il 96% degli intervistati fosse molto o estremamente preoccupato per il benessere dei propri potenziali futuri figli in un mondo cambiato – e, potenzialmente, morente – a causa del clima.
Una preoccupazione che coinvolge non solo chi i figli ha deciso di non averli, ma anche chi è già padre o madre: i ricercatori hanno scoperto che il 6% dei genitori ha confessato di provare un certo rimorso per aver avuto figli. Una madre di 40 anni ha detto: «Mi dispiace di aver avuto i miei figli perché sono terrorizzata dal fatto che affronteranno la fine del mondo a causa del cambiamento climatico».
Le paure per la vita dei propri bambini – reali o potenziali – legate al clima sono radicate in una visione profondamente pessimistica del futuro: dei 400 intervistati il 92,3% aveva una visione negativa, il 5,6% era mista o neutra e solo nello 0,6% dei casi era positiva.
Che cos’è il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici?
Uno degli strumenti principali per contrastare la crisi climatica nel nostro Paese, ma non solo, è sotto esame. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la fase di consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica per la proposta del governo sul Piano nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. C’è tempo fino al 2 aprile per presentare le proprie osservazioni, questa dovrebbe essere uno degli ultimi passaggi per l’adozione, anche in Italia, di un piano che andrebbe ad agire sull’emergenza ambientale che abbiamo ormai da tempo. Il piano ribattezzato PNACC, atteso già nel 2012, ha fin dalla nascita avuto un iter molto complesso, è stato già bloccato più volte pur essendo uno strumento operativo di una strategia già approvata nel lontano 2015. Non si sa se questa possa essere la volta buona per vederlo finalmente approvato e funzionante, ma capiamo bene cos'è il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Cos'è l'adattamento ai cambiamenti climatici
Prima di tutto per capire c’è questo piano è necessario fare un quadro più generale e spiegare cosa si intende per “cambiamenti climatici”. Questi stanno a indicare tutti i cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici, che possono avvenire anche in maniera naturale, ma nella maggior parte dei casi recenti non è stato così. Dal diciannovesimo secolo in avanti infatti e nostre azioni sono state il motivo principale all’origine dei cambiamenti climatici, che sono da ricondurre essenzialmente a un tema principale, quello della combustione di combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas, che genera emissioni di gas a effetto serra che avvolgono la Terra, trattenendo il calore del sole e innalzando le temperature.
Eliminare ora i gas serra dall’atmosfera è compito molto arduo, per questo fermare il cambiamento climatico mentre nasce e quindi operare oggi una mitigazione non è più concretamente fattibile. Questo cambiamento è già ampiamente in atto quindi bisogna realisticamente dirottare verso un adattamento al cambiamento climatico e cioè qualsiasi azione che ci permette di continuare a soddisfare i nostri bisogni fondamentali, come avere cibo, acqua, salute e un tetto sopra la testa, adattandoci ai cambiamenti climatici attuali. L'adattamento coinvolge tutti noi, dalla casalinga all’agricoltore, dal manager alla politica. Le scelte effettuate da tutti possono aiutare a ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico, o anche a sfruttare al massimo i suoi potenziali benefici. Alcune scelte che facciamo ora, possono finire per aumentare il nostro rischio in futuro.
Azioni di adattamento al cambiamento climatico
Ci sono diversi modi per abbracciare questo adattamento al cambiamento climatico. Esiste un "adattamento reattivo", o "retrofitting" quando gli effetti del cambiamento climatico si sono già fatti sentire, come l’aumento del livello del mare o i livelli di inquinamento nell’aria a cui le comunità costiere e cittadine si devono già adattare. E poi c’è anche un “adattamento precauzionale" e cioè quando scegliamo di adattarci prima di sentire le conseguenze del cambiamento climatico, che in molti casi è più efficace e più facile di farlo in un secondo momento. Gli adattamenti invece "No-" o "low-regret" ("a basso impatto") sono soluzioni che creano benefici immediati, come la raccolta dell'acqua piovana, o il non costruire in aree non adatte.
Ma quali sono i costi di tutto questo? Non sono quantificabili nello specifico, ma quello che si può dire è che man mano che il clima cambia, il costo dell'adattamento aumenta, incorrendo in un costo sempre maggiore in termini di danni del cambiamento climatico a cui non possiamo adattarci, questi sono chiamati "danni residui".
Cos'è il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Necessario quindi intervenire anche da un punto di vista politico-legislativo con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), uno strumento di pianificazione nazionale per supportare le istituzioni nazionali, regionali e locali nell’individuazione e nella scelta delle azioni di adattamento più efficaci, secondo vari fattori tra questi: il settore di intervento e le specificità del contesto, favorendo l’integrazione dei criteri di adattamento nei processi e negli strumenti di pianificazione. Il PNACC andrebbe a fornire una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile alla definizione dei percorsi settoriali e/o locali di adattamento ai cambiamenti climatici allo scopo di contenere agli impatti dei cambiamenti climatici e migliorare le possibilità di sfruttamento di eventuali opportunità.
Dopo il 2 aprile, giorno ultimo per depositare le proprie osservazioni sulla proposta del governo per il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, si potrebbe arrivare dopo anni all’approvazione definitiva del Piano, come conferma lo stesso ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Esaminate le osservazioni e conclusa la procedura di VAS il testo andrà all’approvazione definitiva con decreto del Ministro. Si procederà poi all’insediamento dell’Osservatorio Nazionale, che dovrà garantire l’immediata operatività del Piano attraverso l’individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori. L’Osservatorio definirà le priorità, individuerà i soggetti interessati e le fonti di finanziamento, oltre che le misure per rimuovere gli ostacoli all’adattamento. I risultati di questa attività potranno convergere in piani settoriali o intersettoriali, nei quali saranno delineati gli interventi da attuare”. Quello che si teme potrebbe essere un ulteriore allungamento dei tempi per l’approvazione con un’adozione solo formale e non concreta del Piano.
Quello che bisogna subito dire che la burocrazia anche in questo caso si fa sentire, la proposta del governo Meloni del PNACC, che risale al dicembre scorso, ha al suo interno dati analizzati dagli esperti abbastanza vecchi, come accade spesso per report climatici devono fare i conti, dato che la climatologia è una scienza sempre in evoluzione. In questo modo in quadro d’insieme potrebbe non essere esattamente quello attuale, ma parziale, visto che all’interno è presente un’analisi del clima che ha come riferimento il periodo 1981-2010.
Nel Piano comunque sono riportate le misure da adottare per porre rimedio ai danni dei cambiamenti climatici. “Esempi di misure di adattamento sono modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per la protezione di persone o strutture dall’innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli. Le misure soft invece includono misure di policy, giuridiche, sociali, gestionali, finanziarie, che possono modificare il comportamento e gli stili di vita, contribuendo a migliorare la capacità adattiva e ad aumentare la consapevolezza sui temi del cambiamento climatico. Misure verdi: prevedono azioni basate sulla natura/ecosistemi, che impiegano i servizi multipli forniti dagli ecosistemi naturali per migliorare la resilienza e la capacità adattiva. Misure infrastrutturali/tecnologiche: interventi fisici e/o misure costruttive utili a rendere gli edifici, le infrastrutture, le reti, i territori, più resilienti ai cambiamenti climatici”.
Nel Piano poi vengono citate possibili fonti di finanziamento per sostenere le azioni di adattamento come “un riordino della fiscalità che promuova maggiormente l’utilizzo degli strumenti fiscali ambientali produrrebbe un doppio beneficio: quello di ridurre gli impatti negativi sul clima e quello di ridurre l’impatto fiscale altri temi, tra cui quello sul lavoro”. Infine il documento recita che “nell’ottica di garantire la circolarità delle risorse, la struttura di governance del PNACC dovrà garantire una stretta sinergia con l’Osservatorio sull’attuazione della strategia nazionale dell’economia circolare”.
Un quadro più chiaro forse della situazione attuale italiana si può trovare comunque sulla Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici, realizzata dal ministero dell’Ambiente e da ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), un portale che “vuole informare e informare e sensibilizzare i cittadini e i portatori di interessi sulla tematica dell’adattamento” e vuole “rendere disponibili dati e strumenti utili a supportare la pubblica amministrazione”.
La soluzione al climate change sarà raffreddare il pianeta?
Il nostro Pianeta è malato e, dopo Cop27, si sta ancora cercando la cura migliore. Il 2022 è stato l’anno più caldo registrato in Italia dal 1800, e a quanto pare sarà il più fresco rispetto a quelli che ci attendono. Tutto ciò ha un costo che Banca d’Italia ha quantificato in una pubblicazione: Gli effetti del cambiamento climatico sull’economia italiana. Un progetto di ricerca della Banca d’Italia.
Intanto oltre oceano, per cercare delle soluzioni a questi problemi che ormai coinvolgono tutto il mondo, scende in campo direttamente la Casa Bianca. Infatti, l’Office of Science and Technology Policy (Ostp) sta coordinando un piano di ricerca quinquennale per studiare come raffreddare la Terra o, più precisamente, come modificare la quantità di luce solare che raggiunge il nostro Pianeta con l’obiettivo di moderare gli effetti del riscaldamento globale.
Il progetto
Il piano di ricerca valuterà l'irrorazione di aerosol nella stratosfera per riflettere la luce solare nello spazio. Tra gli obiettivi, capire quale impatto possono avere questi interventi. Alcune delle tecniche, come l'irrorazione di anidride solforosa nell'atmosfera, sono note per avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. Ma gli scienziati dichiarano che la ricerca punta a comprendere come bilanciare al meglio questi rischi.
L'idea della riflessione della luce solare è apparsa per la prima volta in un rapporto della Casa Bianca del novembre 1965 al presidente Lyndon B. Johnson intitolato Restoring the quality of our environment.
All’epoca il costo stimato era di 500 milioni di dollari all’anno, ma oggi sono cambiate le tecnologie e il costo è aumentato, arrivando a 10 miliardi di dollari all’anno. Oggi l'iniezione di aerosol stratosferico comporterebbe aerei volanti nella stratosfera impegnati nello spruzzare una nebbia che sarebbe “appesa” nell'aria, le cui particelle sarebbero le responsabili della riflessione delle radiazioni solari che non raggiungerebbero il suolo terrestre.
Un'opzione per un aerosol è l'anidride solforosa, i cui effetti di raffreddamento sono ben noti dalle eruzioni vulcaniche. L'eruzione del 1991 del Monte Pinatubo, a esempio, ha versato migliaia di tonnellate di anidride solforosa nella stratosfera, causando temporaneamente un calo delle temperature globali di circa 1 grado Fahrenheit.
L’anidride solforosa si ottiene anche quando si brucia il carbone, che ha un po' di zolfo al suo interno che ossidandosi si trasforma in anidride solforosa. Quindi bruciando carbone si è prodotta una riflessione della luce solare per decenni ma in modo incontrollato. Ma riempire di anidride solforosa gli strati più altri dell’atmosfera comporta anche dei rischi poiché alla fine il tutto si riverserebbe sul suolo sotto forma di pioggia acida. Inoltre, lo zolfo comporterebbe delle alterazioni nella quantità di ozono con conseguenze sul buco dell’ozono.
Il piano dell'Ostp non sarà certo la soluzione definitiva al cambiamento climatico ed è importante valutare gli effetti di queste scelte. Certamente la riduzione delle emissioni rimane la priorità.
Cos'è l'Office of Science and Technology Policy?
L’Ostp nasce nel 1976 con la necessità di coordinare la politica federale in materia di scienza e tecnologia, offrendo al Presidente degli Stati Uniti la migliore consulenza sulla ricerca in questi ambiti, lavorando per “massimizzare i benefici della scienza e della tecnologia, promuovere la salute, la prosperità, la sicurezza, la qualità ambientale e la giustizia per tutti gli americani”.
Chi è a capo dell’Ostp consiglia il Presidente riguardo i bilanci per lo sviluppo nella ricerca, partecipa ai lavori del Consiglio di Sicurezza Nazionale per la redazione dei piani di Preparazione in caso di Pandemia e guida il Cancer Moonshot.
A capo dell’Ostp, da fine settembre, c’è Arati Prabhakar (prima donna a ricoprire questo ruolo e prima persona non bianca): una personalità di notevole rilievo non solo per l’America ma per l’intero Pianeta, sia per il ruolo che ricopre ma anche perché Prabhakar è stata direttrice dagli anni ’90 dell’ufficio della tecnologia microelettronica del Defence Advanced Research Projects Agency – Darpa.
Cos'è la Defence Advanced Research Projects Agency?
Darpa è l’agenzia che nel 2013 lavorava già su vaccini a Rna messaggero investendo sull’allora piccola impresa Moderna, che nel 1958 lavorava sul Global Positioning System – Gps, che oggi utilizziamo quotidianamente. Certamente, però, il successo più grande di Darpa è ArpaNet, l’antenato dell’odierno internet, lanciato negli anni ’60 con l’obiettivo di creare una rete di comunicazioni militari sicure ed efficienti.
Darpa nasce in piena Guerra Fredda in risposta al lancio in orbita da parte dell’Unione Sovietica del primo satellite artificiale nell’ottobre del 1957. Si trova ad Arlington, in Virginia, vicino al Pentagono, e il suo scopo è sempre stato quello di studiare innovazioni tecnologiche avanguardistiche da applicare nel campo militare.
L’agenzia però ha anche gestito l’Information awareness office, il cui compito era la sorveglianza di massa attraverso l’immagazzinamento di informazioni personali prelevate tramite internet, smascherato da Edward Snowden, l’informatico e attivista statunitense ex dipendente della National Security Agency americana che ha svelato l’esistenza al mondo di questi programmi.
Oggi Darpa e Ostp lavorano cercando di risolvere i problemi che interessano non solo l’America ma il mondo, concentrandosi molto, per volontà del Presidente Biden, sull’annoso problema dei cambiamenti climatici.
Le foreste saranno sufficienti per compensare il cambiamento climatico?
Le foreste del patrimonio Unesco non reggono più il riscaldamento globale. Il nuovo rapporto pubblicato da tre organizzazioni internazionali come IUCN - Unione internazionale per la conservazione della natura -, World Resources Institute e Unesco, mostra che questi ecosistemi sono sempre meno in grado di assorbire anidride carbonica.
Il ruolo di regolazione climatica proprio di oceani e foreste sta venendo meno a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane. In primis incendi, tempeste, inondazioni, siccità e temperature estreme, e disboscamento illegale, raccolta del legno e invasione agricola. Ognuno di questi motivi colpisce circa il 60% dei siti Patrimonio dell’Umanità disboscamento.
Attraverso la fotosintesi, le foreste assorbono grandi quantità di anidride carbonica emessa principalmente dalle attività umane, limitando l’accumulo di gas serra nell’atmosfera. Secondo uno studio pubblicato a gennaio sulla rivista Nature Climate Change, i boschi del nostro pianeta consentono di catturare, ogni anno, quasi 8 miliardi di tonnellate nette di Co2: equivalgono a poco meno delle emissioni della Cina relative al 2020.
Per tracciare l’anidride carbonica assorbita e rilasciata dalle aree forestali prese in analisi, i ricercatori si sono serviti dei dati satellitari del Global Forest Watch, che scruta in tempo reale l’evoluzione delle foreste nel mondo. Grazie a queste mappe e alla ricerca condotta da WRI, per la prima volta sono stati stimati il carbonio lordo e netto assorbito ed emesso dalle foreste Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco tra il 2001 e il 2020 e sono state determinate le cause delle emissioni da alcuni siti. Tali siti, che coprono 69 milioni di ettari, contengono 13 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nella vegetazione e nel suolo.
Si stima che “Le foreste di tutti i siti Patrimonio dell’Umanità abbiano rimosso dall’atmosfera circa 190 milioni di tonnellate di CO2 all’anno tra il 2001 e il 2020”. Ma negli ultimi 20 anni, queste aree hanno perso 3,5 milioni di ettari di foresta, l’equivalente del Belgio, e 10 siti su 223 hanno emesso più Co2 di quanta ne abbiano assorbita. “Le foreste del patrimonio mondiale dell’Unesco possono continuare ad assorbirla solo se saranno protette efficacemente dalle minacce locali e globali”, conclude lo studio. La portata globale dei cambiamenti climatici e la rilevanza dei Patrimoni dell’umanità dovrebbero spingere governi, società civile, popolazioni indigene, comunità locali e settore privato ad agire concretamente. O sarà troppo tardi.
Gli anelli degli alberi raccontano il climate change?
Quando da piccoli capitava di imbattersi in un tronco tagliato, si faceva a gara per indovinare quanti anni potesse avere. Il numero delle linee circolari segnate sul ceppo ne rivela l’età, l’ampiezza variabile, invece, fornisce indizi ulteriori. Gli anelli sottili, per esempio, testimoniano stagioni particolarmente secche, quelli larghi, invece, periodi più umidi, mentre le macchie annerite indicano il passaggio delle fiamme. Gli alberi, quindi, non tramandano solo la propria storia, ma anche quella del mondo.
La dendrocronologia è un modello di datazione messo a punto dall’astronomo Andrew Ellicott Douglass negli anni ’20, basato sull’osservazione della crescita annuale degli anelli sul tronco degli alberi, che può risalire indietro nel tempo di diversi secoli, a volte persino millenni. L’elaborazione di questa tecnica, utilizzata molto anche in archeologia per la datazione di manufatti in legno, avvenne casualmente, nel corso degli esperimenti dello scienziato sull'influenza dei cicli solari sul clima terrestre.
Nel tempo, ovviamente, le modalità di lavoro degli studiosi sono cambiate, divenendo sempre meno intrusive e dannose per gli alberi: niente più asce o motoseghe per prelevare le sezioni di tronco migliori. Adesso si utilizza una sottilissima trivella in metallo e infilandola nel tronco, si ricava una piccola scheggia di legno delle dimensioni di una cannuccia.
Ad oggi il Laboratory of Tree-Ring Research dell’Università dell’Arizona vanta l'archivio più ricco al mondo, con oltre 700.000 campioni a disposizione: 600.000 sezioni di alberi e 100.000 frammenti di carbone, tutti etichettati, catalogati e conservati. Solo i ricercatori possono accedere alla collezione del laboratorio, ma è in preparazione una versione digitale, un database pubblico, su cui sarà possibile compiere delle ricerche.
"L’andamento del cambiamento climatico incide sugli anelli degli alberi", ha spiegato l'ecologo Thomas W. Swetnam, l'ex direttore del laboratorio, al Washington Post. Lo descrive come "una grande biblioteca del clima e della storia umana". Un ambito della conoscenza di cui sappiamo ancora poco e che potrebbe avere delle ricadute interessanti sull'esame del ciclo globale del carbonio, dei modelli di crescita delle foreste e dei cambiamenti climatici.
Recentemente, inoltre, il laboratorio ha fornito un contributo fondamentale a uno studio sui 22 anni di siccità che stanno affrontando i Paesi occidentali. I ricercatori dell'Università della California hanno tratto delle conclusioni preoccupanti: è in corso una crisi idrica senza precedenti, la peggiore degli ultimi 1.200 anni, un lasso di tempo confermato proprio dalla lettura degli anelli degli alberi.
Anche in Europa non mancano iniziative al riguardo. Il progetto TREE-RINGS & CLIMATE (Temporal instability of tree-ring/climate relationships: Tree responses to climatic change and implications for paleoclimate research), lanciato nel 2011, cofinanziato dai fondi dell'Ue e conclusosi nel 2014, si prefiggeva l’obbiettivo di approfondire il rapporto tra gli anelli degli alberi e il clima. Studiando le interazioni l’impatto degli agenti atmosferici sulle foreste nel tempo, concentrandosi sulla Penisola iberica e sulla regione boreale, i ricercatori hanno potuto individuare una serie di indicatori climatici contenuti negli anelli dei tronchi.
In Italia, invece, il Laboratorio di dendrocronologia di Rovereto, fondato nel 2011 da Maria Ivana Pezzo, custodisce il più grande archivio nazionale, con 8.000 campioni e 13.000 file di misurazioni e cronologie. Gli alberi, conservando la memoria del passato, funzionerebbero come "scatole nere", hanno spiegato Maria Ivana Pezzo e i suoi colleghi alla conferenza del 2020 "Leggere il clima negli anelli degli alberi", organizzata dalla Fondazione Alvise Comel e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto.
Perché il cambiamento climatico amplifica le guerre?
Non solo siccità, tornado e alluvioni. In base ai dati emersi dall’ultimo Environmental Risk Outlook, pubblicato da Verisk Maplecroft, il cambiamento climatico aumenterà anche l’instabilità globale, spingendo sempre più aree del Pianeta al conflitto.
Secondo il report, che riassume le questioni più urgenti di rischio ambientale, nemmeno i Paesi del ricco Occidente sono immuni: anche loro, pur sembrando protetti dagli impatti secondari dei cambiamenti climatici, non hanno le garanzie per proteggere le loro società dai rischi legati al peggioramento delle condizioni meteorologiche estreme.
«I governi stanno iniziando a creare ampi piani di mitigazione per le minacce al clima fisico, ma i bassi livelli di investimento nell'analisi dei rischi secondari mostrano che la maggior parte è quasi del tutto impreparata ad affrontare gli impatti politici, economici e sullo sviluppo più ampi di un pianeta in fase di riscaldamento», ha affermato Will Nichols, responsabile del rischio climatico e della resilienza di Verisk Maplecroft.
Disordini civili, instabilità politica, insicurezza alimentare, migrazioni di massa, peggioramento dei diritti umani e aumento dei conflitti sono gli impatti secondari intrinseci del cambiamento climatico, ma governi e imprese non sembrano considerare questi effetti nel loro approccio alla lotta al riscaldamento globale.
Man mano che gli eventi meteorologici estremi che il mondo sta già vivendo diventano più frequenti, questi rischi climatici di secondo ordine si diffonderanno sempre più in un'ampia fascia di Paesi.
Un rischio che potrebbe riguardare, a esempio, le principali economie emergenti come l'India e l'Indonesia, vulnerabili agli effetti a cascata dei cambiamenti climatici e scarsamente preparati per queste minacce. Anche nazioni economicamente e geopoliticamente strategiche come Brasile, Messico, Vietnam e Russia, però, si trovano in una posizione pericolosa e anche la Cina potrebbe finire sotto pressione se il cambiamento climatico continuasse ad accelerare.
Se Paesi come questi dovessero soccombere ad attacchi estremi di instabilità indotta dal clima, gli impatti a catena potrebbero sopraffare le economie e le popolazioni in tutto il mondo, conclude il report.
Gli effetti climatici immediati come lo stress idrico e il fallimento dei raccolti possono portare alla lotta per le risorse e a migrazioni di massa, fenomeni che possono sfociare in disordini civili, instabilità politica e guerre, uno scenario che si è verificato in Siria dopo la peggiore siccità degli ultimi 900 anni.
Ma il caso della Siria non è isolato: l’estrema siccità ha portato a rivolte sociali, sfollamenti di massa e violenze anche in Mali, mentre in Venezuela la cronica scarsità d'acqua e le inondazioni costiere hanno accelerato il tracollo socioeconomico nel Paese con le più grandi riserve di petrolio del mondo.
Identificare dove questi impatti saranno prevalenti e quali Paesi sono più a rischio è fondamentale: per questo, il rapporto ha valutato la vulnerabilità di 196 Paesi, analizzando 32 criticità, tra cui l'esposizione a calamità climatiche, la sicurezza delle risorse naturali e la povertà estrema, combinando dati provenienti da diverse fonti, tra cui le Nazioni Unite e la Banca mondiale.
I Paesi sono quindi stati classificati come "precari", "vulnerabili" o "protetti" dagli impatti climatici a cascata.
Non sorprende che il gruppo "protetto" comprenda prevalentemente gli Stati più ricchi del mondo, mentre il gruppo "vulnerabile" sia composto prevalentemente da quelli con redditi più bassi.
Tutta l'Asia meridionale e la maggior parte del sud-est asiatico sono considerati vulnerabile, mentre Cina, Vietnam e Malesia sono considerati precari.
Anche i Paesi protetti – gli Stati Uniti, gran parte dell'Europa, Giappone, Corea del Sud e Singapore – però, non possono ritenersi immuni dagli impatti politici, economici e sociali del cambiamento climatico che, spiega il report, non riconoscono le frontiere e hanno la capacità di superare i confini: Stati teoricamente “protetti” come Singapore, a esempio, potrebbero finire per affrontare gli impatti a catena della vicina Indonesia, come una migrazione di massa.
Tuttavia, sono gli Stati che risiedono nel gruppo "precario" quelli in cui «la metaforica diga presenta fratture che potrebbero indebolire la loro forza strutturale complessiva e, in definitiva, la loro capacità di rispondere a grandi scalare le minacce emergenti».
Come il climate change condiziona piante e animali?
Negli anni ‘40, una nave mercantile faceva sbarcare un clandestino a Guam, l’isola più a sud nell’arcipelago delle Marianne: il serpente dagli alberi marroni. Il suo inserimento all’interno dell’ecosistema determinò la distruzione di intere catene alimentari e l’estinzione di quasi tutte le specie di uccelli presenti su Guam. Il nuovo abitante dell’isola provocò infatti un disastroso effetto domino su molte famiglie di alberi, la cui proliferazione dipendeva proprio da quei volatili che si nutrivano dei loro frutti, per poi disperderne i semi.
Nella storia del nostro Pianeta non si tratta di un episodio isolato. Oggi interi ecosistemi sono in pericolo per il declino di particolari specie di uccelli o mammiferi di tutto il mondo.
Uno studio pubblicato su Science, condotto da alcuni ricercatori statunitensi e danesi presso l’Università di Aarhus, ha calcolato l’impatto del cambiamento climatico sulle piante che dipendono dagli animali.
Gli scienziati hanno creato modelli in grado di prevedere due tipi di interazione tra flora e fauna: la germinazione e la superficie di dispersione dei semi. Gli studi precedenti sul fenomeno utilizzavano una semplice equazione: più le dimensioni dell’animale sono grandi, più lontano può trasportare il seme.
Questo ragionamento non può essere applicato alla lettera, ma occorre considerare altri fattori che variano in base alla situazione esaminata. Per esempio, due uccelli con massa corporea simile potrebbero adottare strategie molto diverse, uno potrebbe viaggiare per lunghe distanze mantenendosi sopra la foresta, mentre l’altro potrebbe volare per distanze più brevi sotto la chioma degli alberi. I due comportamenti finirebbero per determinare due distinti gradi di dispersione.
I ricercatori hanno messo a punto un modello servendosi di migliaia di dati relativi a interazioni pianta-animale, per esempio quelle del bucero corrugato e del lemure dal collare, una delle più grandi scimmie dell'Africa sud-orientale. La maggior parte dei dati riguardano specie che in un modo o nell’altro hanno condiviso gli stessi habitat per centinaia di migliaia di anni. Purtroppo, il cambiamento climatico sta modificando questi intervalli di tempo, facendo sì che specie che non si sono mai evolute insieme occupino contemporaneamente lo stesso spazio.
Con quali conseguenze? In molte regioni del mondo, il numero di mammiferi o gli uccelli in grado di trasportare semi a lungo raggio risulta decimato. In America centrale, alcune specie di animali possono garantire 1 km di dispersione, in Africa fino a 5 km. In uno scenario diverso, senza l'impatto dell’uomo o l'introduzione fortuita di nuove specie, questi animali riuscirebbero a trasportare una quantità di semi nettamente superiore.
In media per le piante interessate da questo fenomeno vi è il 60% di possibilità in meno che i loro semi riescano a spostarsi in ambienti nuovi e con condizioni più favorevoli.
Oltre a un approccio conservativo, servirebbero progetti di ripristino e di reinserimento negli ecosistemi di alcune specie animali. Sembrerebbe una prospettiva realizzabile: tra il 2010 e il 2017 in Brasile, per esempio, gli ambientalisti hanno reintrodotto l’aguti dalla groppa rossa e la scimmia urlatrice marrone nel Parco Nazionale di Tijuca.
La crisi climatica colpisce le donne in gravidanza?
La crisi climatica è un questione di genere: incendi, inondazioni, inquinamento e uragani possono impattare molto sulla salute e sullo sviluppo delle giovani donne. E delle madri.
Negli Stati Uniti, ostetriche e ostetrici sono consapevoli dei possibili effetti climatici sulla salute delle loro pazienti. Per questo motivo alcunə di loro stanno fornendo consigli medici al riguardo, «non per allarmare le persone, ma per prepararle», scrive il Washington Post.
«La realtà è che dobbiamo iniziare a dire alle nostre pazienti che il clima sta cambiando», ha spiegato Santosh Pandipati, ostetrico della California. Nello specifico, consiglia loro di monitorare sempre la qualità dell’aria prima di organizzare attività all’aperto (per lui il momento migliore è la mattina presto).
Nathaniel DeNicola, invece, dispensa utili indicazioni da seguire in caso di evacuazione in seguito a uragani e inondazioni: l’ostetrico, scrive il giornale, «incoraggia le persone a mettere in valigia acqua potabile in più, forniture extra di farmaci e una copia cartacea delle loro cartelle cliniche», qualora sia impossibile recuperare quelle elettroniche in caso di blackout.
Pensiamo all’inquinamento atmosferico o all’aumento delle temperature, due fattori di rischio per le donne incinte in tutto il mondo. Uno studio pubblicato nel 2020 sul Journal of the American Medical Association (JAMA) ha rilevato che l’eccessiva esposizione a questi due fattori può portare a parti prematuri, al basso peso alla nascita oppure alla natimortalità.
«Le temperature elevate possono causare disidratazione. Durante la gravidanza, questa può portare al rilascio di ossitocina, un ormone che contribuisce alle contrazioni del travaglio», ha scritto il Washington Post, riportando le spiegazioni di DeNicola. A conferma di ciò, una ricerca più recente, condotta dalla Stanford University e pubblicata nel 2021 su Environmental Research, ha stimato che in California tra il 2007 e il 2012 ci sono stati fino a 7.000 parti prematuri, riconducibili all’eccessiva esposizione al fumo degli incendi.
Oltre agli effetti diretti sulle nascite, lo stress dovuto all'emergenza climatica o alla necessità di evacuare la propria zona (per incendi, inondazioni o uragani) può portare a problemi di salute mentale per le donne, che si ritrovano in una condizione di vulnerabilità assoluta in una fase delicata della vita.
«Le persone ipotizzano che tutto ciò provochi una sorta di catena di conseguenze in gravidanza, che porta poi a eventi come contrazioni premature», spiega DeNicola.
Viene tutto amplificato se poi parliamo di madri nere, le quali già di natura hanno più probabilità di morire per una gravidanza rispetto alle donne bianche (sia per condizioni croniche specifiche che per il pregiudizio razzista nell’ambito sanitario).
Secondo l’epidemiologa Rupa Basu, la ricerca del JAMA (di cui lei è stata co-autrice) mostra come per le donne nere esistano più rischi di un parto prematuro o di basso peso del bambino alla nascita rispetto alle donne di altra etnia, in contesti di eccessiva esposizione al calore e all’inquinamento atmosferico.
La gravidanza si aggiunge così agli altri motivi per i quali la crisi climatica è anche una questione di genere. Sarà forse per questo che le donne risultano più impegnate rispetto agli uomini nella lotta al climate change?
Chi è più attivo nella lotta al cambiamento climatico?
Le donne sono più impegnate rispetto agli uomini nel contrastare il cambiamento climatico. Lo dimostra un sondaggio condotto dal Women’s Forum for the Economy and Society, che riunisce leader e personalità influenti e si fa interprete della voce delle donne sulle principali questioni sociali ed economiche mondiali.
Il barometro sull’equità di genere pubblicato a ottobre dal WF ha analizzato lo stato di disuguaglianza di genere in vari ambiti: business, cambiamento climatico, salute e tecnologia. Tra le 10mila persone intervistate nei Paesi del G20, le donne hanno cambiato più degli uomini il loro comportamento e le loro abitudini quotidiane per ridurre le emissioni di anidride carbonica attraverso il riciclo, l’acquisto di merci locali e la riduzione del consumo di acqua e carne. Rispetto al genere maschile, inoltre, le donne sono più facilmente motivate a ridurre l’impatto ambientale delle proprie azioni perché più interessate al miglioramento delle condizioni del pianeta e dei benefici che questo comporterebbe per le generazioni future. Gli uomini sarebbero, invece, più motivati dalle tasse relative al livello delle emissioni a cui sarebbero sottoposti.
Un altro dato interessante emerso dal Women’s Forum è che i funzionari a capo dei ministeri che si occupano dei cambiamenti climatici - energia, trasporti e ambiente - sono principalmente uomini: la percentuale è del 79% in Germania, seguita dalla’Italia al 78%, dalla Francia al 71% e dal Regno Unito al 61%.
Un altro rapporto pubblicato dal Women’s Forum a settembre ha sottolineato come le donne siano maggiormente colpite dalla crisi climatica, specialmente nelle aree più povere del mondo. Qui le donne costituiscono una parte molto importante della forza lavoro agricola: la combinazione di un forte coinvolgimento con l'agricoltura e le disuguaglianze strutturali, come l'essere escluse dai sistemi finanziari tradizionali, le rende intrinsecamente più vulnerabili ai disastri naturali e ai cambiamenti climatici. Le donne povere hanno 14 volte più probabilità di morire durante un disastro naturale e rappresentano circa l' 80% dei rifugiati climatici.
Perché è importante studiare il climate change a scuola?
I bambini saranno i più colpiti dai cambiamenti climatici. Anzi, in realtà lo sono già: molti di loro sono preoccupati per il futuro, hanno l’ansia per il climate change che, oltre a essere una minaccia fisica, rappresenta un pericolo anche dal punto di vista mentale.
Secondo un sondaggio del 2021 pubblicato sulla rivista scientifica Lancet e condotto in 10 Paesi del mondo, il 60% dei giovani intervistati tra i 16 e i 25 anni è molto preoccupato per il cambiamento climatico. E il 75% crede che il futuro sia spaventoso. Da una ricerca di Save The Children emerge che i bambini nati l’anno scorso dovranno affrontare molti più eventi meteorologici estremi rispetto alla generazione dei loro nonni: in media, ci saranno ondate di caldo 7 volte più torride, le esondazioni dei fiumi saranno 3 volte più frequenti, come i fallimenti dei raccolti, e scoppierà il doppio degli incendi. Fenomeni che si realizzeranno anche se verranno diminuite le emissioni di anidride carbonica come suggerisce l’accordo di Parigi del 2015.
Ma c’è ancora una speranza. E la speranza sono proprio i giovani, non le tecnologie pulite e gli investimenti da miliardi di dollari. Ruolo fondamentale, infatti, l’avrà l’educazione al clima. Lo mostra una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Plos One, del progetto editoriale statunitense Public Library of Science: “Con il 16% dei bambini che ricevono un’educazione climatica, si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 entro il 2050 di 19 gigatonnellate”. Un numero che va contestualizzato: si tratta della metà delle emissioni di anidride carbonica del mondo intero nel 2019. Lo riporta un forum dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico globale, che riunisce esperti e leader di pensiero da tutto il mondo per trovare soluzioni per il futuro.
Come sempre, l’educazione si rivela un’arma molto potente. Lo sanno bene anche gli stessi studenti, insegnanti, genitori che chiedono più istruzione climatica per tutti: secondo l’indagine condotta dal Brookings Institute, l’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Washington DC che riunisce più di 300 esperti di spicco del governo e del mondo accademico, “l'80% dei genitori statunitensi e il 77% degli adulti del Regno Unito sono a favore dell'insegnamento del cambiamento climatico a scuola”. Nonostante la grande richiesta dal basso, i governi non fanno un granché per rispondere in maniera adeguata: solo l’Italia ha previsto la materia di educazione civica-ambientale dedicata a sostenibilità e ambiente a tutte le fasce d’età (un’iniziativa inclusa nel programma RiGenerazione Scuola), mentre Regno Unito e Messico hanno preso l’impegno ma non hanno ancora agito.
Per i più piccoli, in particolare, potrebbe essere utile usare la via del gioco per parlare della crisi climatica: le lezioni di Earth Warriors Global insegnano ai bambini dai 3 agli 11 anni a conoscere questi argomenti attraverso un approccio positivo. Perché i bimbi, per diventare cittadini consapevoli, devono esserlo fin dai primi passi: uno studio pubblicato dall’OCSE nel 2020 ha scoperto che “le abilità cognitive e socio-emotive che i bambini sviluppano nei primi anni di vita hanno un impatto duraturo sui loro risultati successivi durante la scuola e l'età adulta”. I bambini, poi, hanno un influsso positivo nei confronti dei loro genitori, li spingono verso comportamenti più responsabili e sostenibili, come il riciclo. Seppur piccoli, possono avere un grande ruolo nel futuro dei cambiamenti climatici. Proviamo a dargli una possibilità.
COP (Conferenza delle Parti)
Quale accordo sul clima hanno raggiunto Usa e Cina alla Cop26?
Contro ogni pronostico dalla Cop26 è arrivato un accordo tra Cina e Stati Uniti. Sono serviti dieci giorni affinché due dei più grandi produttori di emissioni decidessero di collaborare per l'ambiente.
La “Dichiarazione congiunta Usa-Cina per migliorare l’azione climatica negli anni Venti” è un documento di tre pagine in cui i due Paesi si impegnano a cooperare per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, entrato in vigore nel 2016, e fare qualche passo in più verso la loro attuazione. L’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì, in una conferenza stampa a sorpresa: il delegato cinese Xie Zhenhua ha dichiarato che “entrambe le parti riconoscono che esiste un divario tra lo sforzo attuale e gli obiettivi dell’accordo raggiunto alla Cop21, quindi rafforzeremo congiuntamente i nostri sforzi e la cooperazione per accelerare una transizione verde e a basse emissioni di carbonio”. L’inviato di Xi Jimping si augura che questa cooperazione aiuti a raggiungere gli obiettivi dell'attuale Conferenza delle Parti, come il taglio delle emissioni di Co2 e il mantenimento della temperatura entro la soglia di 1,5° C da qui al 2030.
L’intenzione, di questo si tratta, è dunque di raggiungere obiettivi già fissati in passato, ma c’è una novità imprevista: la volontà della Cina di ridurre le emissioni di metano, il gas serra di breve durata, ma tra i più nocivi al mondo. Il Paese di Xi Jimping si è detto pronto ad attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni e di cessazione del consumo di carbone nel prossimo piano quinquennale che partirà nel 2026. Stati Uniti e Cina si incontreranno l’anno prossimo per discutere del problema, collaborando anche sulle reti intelligenti che devono gestire la produzione di energia solare ed eolica. John Kerry, omologo statunitense di Xie Zhenhua, ha dichiarato che si tratta di un passo per colmare il divario tra i tagli alle emissioni stabiliti finora e quelli necessari. Nel 2025 Stati Uniti e Cina annunceranno nuovi impegni di decarbonizzazione - i cosiddetti Ndc - fino al 2035, creando anche il "Gruppo di lavoro per migliorare l'azione climatica negli anni Venti", che si riunirà con regolarità.
La dichiarazione ha sconvolto più per il suo valore politico che per l’effettivo impegno climatico: lo dimostrano le tensioni dei giorni scorsi tra i due Paesi, con le dichiarazioni di Joe Biden e Barack Obama che si dicevano delusi dall’assenza della Cina (e della Russia) ai vertici internazionali sul clima e per l'assenza di un piano concreto per la riduzione delle emissioni. Questo allineamento tra le due potenze potrebbe essere un ottimo punto di partenza per esercitare più pressioni su quei Paesi che fino a oggi hanno fatto ben poco nella lotta al cambiamento climatico. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore l'accordo: "Affrontare la crisi climatica richiede cooperazione e solidarietà internazionali, e questo è un passo importante nella giusta direzione".
COP26, stop alla deforestazione entro il 2030?
Le 100 nazioni al mondo che rappresentano l’85% delle foreste globali si sono date 9 anni per fermare e invertire la deforestazione. Tra di loro anche Brasile, Indonesia, India, Canada e Colombia. La seconda giornata della Cop26 si focalizza sugli aiuti alle nazioni in via di sviluppo, con una spinta particolare da parte del settore privato per la transizione energetica.
Con un investimento da 19,2 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati, lo stop alla deforestazione è fissato per il 2030. L’accordo denominato “Dichiarazione di Glasgow su foreste e terra” è stato firmato oggi a Glasgow, alla fine del summit di due giorni tra i leader mondiali all’interno della Cop26, la conferenza che durerà fino al 12 novembre. Si tratta del primo grande accordo sul clima raggiunto all’evento globale.
Il premier Boris Johnson ha parlato di "accordo fondamentale per proteggere e ripristinare le foreste della Terra, che sono le cattedrali della natura e i polmoni del nostro pianeta”.
Tra i firmatari ci sono Brasile, Russia, Cina - i cui leader non hanno presenziato alla conferenza sul clima -, Canada, Indonesia, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti e Regno Unito: si tratta dei Paesi che coprono circa l'85 per cento delle foreste mondiali. Alcuni dei fondi stanziati andranno ai Paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare gli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene.
Jeff Bezos, fra i più ricchi uomini del mondo, ha promesso dal palco della Cop26 di donare 2 miliardi di dollari all’Africa per ridare vita a terreni "degradati" dal clima. Il fondatore del colosso americano Amazon lo ha dichiarato durante un intervento al fianco del principe Carlo, l’erede al trono britannico impegnato nella promozione di progetti ecologici e nella raccolta di contributi dal settore privato globale. “Ripristinare le terre può migliorare la fertilità del suolo, far aumentare i raccolti, incrementare la sicurezza alimentare, rendere l'acqua più disponibile, creare lavoro e dare spinta alla crescita economica” ha dichiarato Bezos.
Inoltre, oltre 80 Paesi hanno aderito all'iniziativa globale per ridurre del 30% le emissioni di metano entro il 2030. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: ridurre il gas serra di un terzo rispetto ai livelli del 2020 "rallenterà immediatamente il cambiamento climatico”. Per l’impegno globale sulle foreste è previsto lo stanziamento di un miliardo di euro.
Un’altra notizia segna la giornata di oggi: secondo quanto riferito da alcune fonti dell’amministrazione Usa, gli Stati Uniti sono rientrati nella “High Ambition Coalition”, il gruppo di Paesi sviluppati e in via di sviluppo che ha assicurato che l'obiettivo degli 1,5 gradi fosse un elemento chiave dell'accordo di Parigi. La decisione della più grande economia mondiale e della seconda fonte di emissioni, dopo la Cina, di tornare nel grande gruppo segna un significativo impulso al tentativo di concentrare gli sforzi della Cop26 sulla limitazione dell'aumento della temperatura, il più difficile dei due obiettivi dell'accordo del 2015.
Nel frattempo, però, Cina e India rimandano la scadenza per raggiungere le emissioni zero: il Paese di Xi Jinping ha criticato molto gli Stati Uniti per il tasso di inquinamento del passato, con emissioni che hanno superato di 8 volte quelle della Cina. Ma anche il premier indiano Modi ha preoccupato il forum: "L'India raggiungerà l'obiettivo delle emissioni zero nel 2070”. La Cina, intanto, ha aumentato la produzione giornaliera di carbone di oltre un milione di tonnellate per far fronte alla crisi energetica. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il massimo organo cinese impegnato nella pianificazione economica, ha reso noto che la produzione media giornaliera di carbone da parte di Pechino è salita a oltre 11,5 milioni di tonnellate dalla metà di ottobre, rispetto alle 10,4 milioni registrate a fine settembre.
Cop26 quanto investirà la finanza per tagliare le emissioni di Co2?
A Glasgow è giunto il momento di parlare di finanza.
Nel giorno del Finance Day della Conferenza sul clima organizzata dall’ONU, si è discusso su come mobilitare il denaro necessario per finanziare la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
Così ministri delle Finanze, capi delle istituzioni finanziarie internazionali ed esponenti di banche e gruppi finanziari privati si sono ritrovati al cospetto del grande modellino in scala del Pianeta Terra posizionato nel salone principale dello Scottish Event Campus per parlare di numeri. Anzi, di migliaia di miliardi di dollari di investimenti. Dopo la decisione di alzare a 100miliardi di dollari all’anno la quota da versare ai Paesi in via di sviluppo, la coalizione composta da 450 banche, assicuratori e gestori patrimoniali che rappresentano 45 Paesi ha fissato l’obiettivo di stanziare 130mila miliardi di dollari per raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Lo ha dichiarato Mark Carney, presidente della Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), che verrà affiancato nel suo lavoro dall’imprenditore e politico americano Michael Bloomberg.
Intanto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato che l’Italia sarà co-investitore di un fondo da dieci miliardi (con il proposito di raggiungere quota 100miliardi). Si chiamerà Global Energy Alliance e i capitali arriveranno da attori del settore privato. Il fundraising p in corso: “L’obiettivo è raggiungere 1 miliardo di persone con sorgenti di energia rinnovabile e affidabile - ha detto Cingolani -, ridurre di 4 miliardi di tonnellate la CO2 e creare 150 milioni di posti di lavoro”.
Secondo il premier britannico e padrone di casa Boris Johnson, è necessario andare avanti col “duro lavoro, perché molto deve essere ancora fatto”. C’è bisogno di “saggezza collettiva”, così l’ha definita Johnson, per salvarci da un disastro evitabile. Lo ha detto parlando alla Camera dei Comuni, a Londra. Da Glasgow, a rappresentare il Regno Unito, c’è il ministro delle Finanze Rishi Sunak, che ha annunciato che le aziende che rappresentano il 40% dei capitali finanziari mondiali, si conformeranno agli Accordi di Parigi per contenere l’aumento delle temperature entro 1,5° C. Dal 2023 entrerà l’obbligo, per queste società, di pubblicare un piano chiaro e attuabile per la decarbonizzazione.
Boris Johnson non è l’unico leader assente alla Cop26: il summit dei capi di Stato e di governo della durata di due giorni, infatti, si è già concluso ieri. Ora tocca a tecnici e negoziatori, che avranno il compito di chiudere gli accordi e portare a casa risultati concreti. Per ora si è parlato di decarbonizzazione più accelerata, del fondo da 100 miliardi all’anno per i Paesi poveri e della definizione di un mercato globale del carbonio.
Tra coloro che sono rimasti a Glasgow c’è anche lei, Greta Thunberg. L’attivista svedese ha annunciato uno sciopero del clima per venerdì mattina e una marcia per sabato: un modo per non distogliere l’attenzione pubblica dalla Cop26 ora che i leader del Pianeta sono tornati a casa.
Cop27: una conferenza per salvare il pianeta?
Sharm el-Sheikh è una piccola città dell’Egitto, il Paese delle piramidi e dei faraoni. A Sharm el-Sheikh c’è un mare trasparente con la barriera corallina e tanti pesciolini colorati e in estate fa davvero caldissimo. Nelle ultime due settimane, Sharm el-Sheikh brulicava di gente ma non erano turisti.
Dal 6 al 18 novembre si è tenuta la Cop27, cioè la 27esima conferenza sui cambiamenti climatici. Sono arrivate oltre 40.000 persone da 196 Paesi, più di tutti gli abitanti di Sharm el-Sheikh! C’erano presidenti e politici ma anche persone comuni il cui lavoro ha un impatto, buono o cattivo, sul clima.
Questa grossa conferenza viene organizzata ogni anno in un continente diverso, a turno, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scopo è che tutti i Paesi del mondo si incontrino e scambino idee e informazioni sul clima e su come proteggerlo.
Ci sono Stati grandissimi che inquinano tantissimo - come gli Stati Uniti, la Cina, la Germania - e altri piccolissimi che inquinano pochissimo ma che pagano carissimo l’inquinamento degli altri. La Cop27 serve - o piuttosto, servirebbe - a trovare delle soluzioni tutti insieme in modo da ridurre l’inquinamento e l’ingiustizia climatica.
Da un po’ di tempo a questa parte, le conferenze sui cambiamenti climatici sono sempre più attese e importanti. Tra i ghiacciai che si sciolgono, i mari che si alzano, le temperature impazzite e tutti i disastri naturali che abbiamo provocato, bisogna trovare delle soluzioni in fretta, coraggiosamente e tutti insieme.
Queste due settimane sono state utili, ma tante sembrano anche le promesse al vento. E tu e io sappiamo che le promesse al vento puzzano come le bugie. Innanzitutto, la Cop27 si è svolta in Egitto, che è un Paese bellissimo con le piramidi e le barriere coralline ma è anche governato da un signore, Abdel Fattah al-Sisi che non rispetta chi non la pensa come lui. Imprigiona e fa molto male a chi protesta, impedisce alla stampa di scrivere liberamente. Se le cose stanno così, è difficile mettersi d’accordo se non si può parlare sinceramente.
La conferenza, poi, è stata sponsorizzata dalla Coca-Cola, che è un’azienda che inquina un sacco con tutte le sue bottiglie di plastica. I presidenti dei Paesi più grandi sono arrivati in Egitto a bordo dei loro jet privati, che sono degli aerei che inquinano tantissimo. Insomma, stiamo cercando di salvare il pianeta per davvero o solo per finta?
Per fortuna, non c’erano solo presidenti con i jet e grosse aziende plasticose ma anche tantissimi civili, cioè cittadini normali che lavorano a difesa dell’ambiente. Sono loro che, da sempre, fanno gli sforzi più grandi. È però chiaro che alle prossime conferenze - l’anno prossimo la Cop28 si terrà a Dubai, la città piena di grattacieli nel deserto - servirà anche il coraggio dei grandi. E i soldi dei più grandi.
I Paesi ricchi hanno inquinato per tutti e hanno rovinato anche i paesi che non inquinavano. Adesso bisogna che paghino per tutto quello che hanno fatto e che aiutino i Paesi in difficoltà a riprendersi perché non si sono messi nei guai da soli. I Paesi della Cop27 saranno pure 196, ma il pianeta è uno solo. E ha fretta e bisogno di stare meglio.
Cop27: la cura per il Pianeta malato è ancora lontana?
Immaginiamola così: la Terra si è ammalata di crisi climatica e i popoli del mondo, riuniti alla Cop27, per ora hanno deciso di curarla con antidolorifici (fondo perdite e danni) anziché un vaccino (lotta concreta alle emissioni).
La difficoltà di stabilire "come è andata questa Cop27?" sta tutta dal punto di vista con cui la si osserva. Sappiamo bene che il mondo è diviso economicamente mentre la salute del Pianeta, in cui tutto è connesso, ha lo stesso tragico problema del surriscaldamento. Se dunque osserviamo i risultati finali della Conferenza delle parti sul clima di Sharm El-Sheikh indossando gli occhiali del futuro del Pianeta, allora c'è poco da festeggiare: si è mantenuto l'impegno di contenere le temperature entro +1,5 gradi (che comunque probabilmente sforeremo) ma le azioni intraprese per abbassare le emissioni sono insufficienti.
I Paesi economicamente più sviluppati non hanno infatti preso un impegno concreto per uscire davvero dall'era dei combustibili fossili, dall'oil and gas per intenderci. Anzi, quelli ospitanti come l'Egitto hanno perfino guadagnato nuovi contratti e assicurazioni di poter ancora sfruttare il gas. Se però guardiamo alle conclusioni della Cop27 indossando i panni dei paesi più poveri e vulnerabili – conclusioni arrivate in ritardo dopo giorni e notti di drammatici negoziati – allora c'è una lieve speranza: il fatto che sia stato raggiunto un primo accordo per inserire negli impegni la questione loss and damage, un fondo per risarcire i Paesi meno abbienti e martoriati dalla crisi del clima, è uno spartiacque, un riconoscimento concreto delle differenze, dell'impatto delle emissioni, della necessità di aiuti. Un primo passo di qualcosa che appare ancora lontano mentre il tempo stringe.
Loss and damage
Per la prima volta infatti l'assemblea plenaria ha deciso per l'istituzione di un fondo per i ristori delle perdite e dei danni del cambiamento climatico. Non era scontato: la pressione degli attivisti e dei leader dei Paesi meno abbienti ha portato a casa questo successo su cui si è giocata buona parte della conferenza. Non sono state definite ancora questioni chiare su "chi paga e chi riceve", ma si è dato il via al processo che passerà per l'istituzione di un Comitato transitorio il quale dovrà preparare un progetto da presentare alla prossima Cop28 nel 2023 per l'avvio operativo del fondo.
Interessante è notare che la maggioranza dei membri di questo Comitato (14 su 24) saranno rappresentati di Paesi insulari e africani, tra quelli più concretamente oggi impattati dalla crisi. In questa fase transitoria hanno la chance di arrivare a proporre, alla prossima Cop28 a Dubai, uno strumento fattibile per far funzionare il fondo su perdite e danni. Non è cosa da poco, dato che finora non si era mai affrontata la questione, ma per avere concrete speranze servirebbero posizioni più nette (anche economicamente) delle grandi potenze, come la Cina.
Dalla battaglia sul loss and damage sono poi nate nuove valutazioni ed esigenze che saranno oggetto già il prossimo anno di possibili rivoluzioni: la più importante è la necessità di rivedere e ridiscutere – forse dalla prossima primavera – il ruolo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario internazionale, con la possibilità che si dia il via alla riforma del sistema finanziario globale per mobilitare fondi e volumi necessari al clima.
Interessante sarà capire come si svilupperà la proposta Alleanza Bridgetown avanzata dalle Barbados di Mia Mottley, appoggiata dalla Francia. Chiave è anche un altro concetto: in questo contesto rientrerà sempre di più anche la questione dei migranti climatici che, avvertono i paesi più colpiti, di questo passo potrebbero diventare 1 miliardo entro metà secolo.
Mitigazione
Se ci sono stati passi avanti per mantenere i pilastri dell'Accordo di Parigi, altri sono stati fatti indietro sulla "mitigazione", impegni e azioni per ridurre le emissioni climalteranti. Sappiamo che le emissioni legate ai combustibili fossili sono la prima fonte del surriscaldamento della Terra: eppure non si è arrivati a definire l'addio concreto a questa fonte inquinante.
A perdere è dunque il futuro del Pianeta, mentre a vincere è il presente: le pressioni legate alla crisi energetica e i conflitti non hanno permesso un road map chiara per liberarci dal fossile e al contrario hanno rimarcato l'intenzione di voler puntare a esempio sul gas come energia di transizione, agevolando ancora accordi economici fra grandi potenze e a esempio Africa (vedi Egitto), tutte basate sul gas.
Sì, si è parlato e inserito anche un passaggio relativo alle energie rinnovabili, ma appare poca cosa rispetto a quanto sarebbe servito per una rivoluzione basata sull'energia pulita, mentre per ora ci limitiamo a rimarcare solo una idea di futuro con "energie a basse emissioni". Preoccupa poi il fatto che non ci siano stati passi avanti rispetto al vertice scozzese dello scorso anno: si continua a parlare di phase down dal carbone senza però definire il phase out
Finanza
Sebbene sia avanzata l'idea di un fondo loss and damage, sui famosi finanziamenti da 100 miliardi di dollari l'anno (dai Paesi più ricchi a quelli più colpiti) necessari per aiutare gli stati vulnerabili nemmeno alla Cop27 sono arrivate certezze. Sì, alcuni singoli Stati hanno fatto promesse di risorse "milionarie", ma si è ancora lontanissimi da quanto servirebbe: almeno 4.000 miliardi di dollari per tentare – anche con adeguamenti tecnologici – di restare in linea verso le zero emissioni nel 2050. Miliardi che, propongono delegazioni di paesi meno abbienti, potrebbero iniziare ad arrivare se solo si cominciassero a tassare gli extraprofitti (ad esempio del 10%) delle aziende di oil and gas nel mondo.
Ipotesi che non rientra minimamente nell'accordo dopo quasi 2 settimane in cui i padiglioni di Sharm El-Sheikh, per paradosso, hanno invece visto la presenza di oltre 600 lobbisti dell'oil and gas, il 25% in più rispetto alla conferenza del 2021 a Glasgow.
Anche in questa chiave, o perlomeno in quella della finanza necessaria per stabilire fondi, ci si aspettavano risposte dai vari piani nazionali dei Paesi (NDC): soltanto 33 su 200 sono però stati presentati, rimandando ancora una volta "al futuro"
Italia
In tutto questo che partita ha giocato l'Italia? Di sicuro in panchina (o forse tribuna), dal punto di vista di proposte, decisioni o impegno. L'Italia dei vertici di governo si è messa in coda all'Ue, senza mai giocare davvero (a differenza di Francia, Germania o altri), ma semplicemente facendo presenza: la toccata e fuga di Giorgia Meloni dopo il bilaterale con Al-Sisi per parlare anche di accordi commerciali, oppure le poche ore passate a Cop del ministro dell'Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sono apparse come un segnale di distanza all'interno degli sforzi necessari per la lotta al surriscaldamento. Va detto però che è comprensibile, visto il nuovo ruolo assunto da sole poche settimane, una certa "lontananza" per esempio da parte del ministro.
Di positivo si registra comunque l'istituzione del Fondo italiano per il clima (840 milioni all'anno per 5 anni), il ruolo attento e costante dell'inviato speciale per il clima, Alessandro Modiano, e lo sforzo con cui think tank, associazioni o delegati vari hanno affrontato con costanza e determinazione le trattative della Cop27 (su tutti Ecco e Italian Climate Network)
Biodiversità
Infine, se da una parte ci sono stati applausi e persino grida di gioia per l'intervento del neo presidente del Brasile Lula che ha promesso di difendere in ogni modo le foreste dell'Amazzonia, dall'altra sulla crisi della biodiversità e della natura nel testo finale della Cop27 mancano purtroppo specifici riferimenti su come affrontarla.
La speranza è che arrivino indicazioni precise e vincolanti da Cop15 di Montréal dei prossimi giorni, dedicata alla biodiversità: senza paletti chiari per proteggere, conservare, ripristinare e utilizzare in maniera consapevole natura e ecosistemi naturali, il futuro sarà sempre più nero.
Gli antidolorifici potrebbero distrarci per un po' dal problema, ma poi senza cura reale per la febbre del Pianeta rischieremo di accorgerci all'improvviso che sarà davvero troppo tardi.
Cop27: la lotta al climate change riparte dai giovani?
Gli scorsi 15 e 16 ottobre si è svolta Q-Hack4.0 Call4Earth - Youth Hackathon for COP27, l'iniziativa organizzata da Unicef Italia in partnership con International Association for Impact Assessment Italia e in collaborazione con Earth Day Italia.
Nel corso dell'evento, che ha visto la partecipazione di 100 giovani, sono stati elaborati sei progetti che hanno poi composto una pubblicazione presentata in occasione della Cop27, con l'obiettivo di ispirare le scelte dei rappresentanti e decisori politici che riuniti a Sharm-el-Sheikh in merito ai negoziati sul clima.
I giovani negli ultimi anni attraverso manifestazioni e diversi esempi di impegno attivo hanno lottato per fornire un contributo alla costruzione di un nuovo pensiero globale e per chiedere giustizia climatica ma le loro voci non sono state udite e le idee hanno finito per essere ignorate e non inserite nelle normative, nelle politiche globali e nei programmi per contrastare i cambiamenti climatici.
Questa pubblicazione vuole provare a ristabilire un dialogo tra giovani e governanti, permettendo anche alle nuove generazioni di partecipare attivamente al dibattito sul clima, soprattutto alla luce del fatto che saranno loro le ereditiere di un mondo che va salvato.
I progetti presentati dai giovani del gruppo Younicef riguardano la transizione energetica attraverso l’installazione di impianti geotermici (Le geo-cronache di Narni); l’incentivazione del sistema geotermico e della mobilità sostenibile (Mantua Green); un sistema di trasporti alternativo (E-boats “Salpiamo Mantova”); la messa in posa del verde pubblico (Verde sospeso); il passaggio dal metano libero all’energia da biogas per alimentare la depurazione (Depuriamo il mare) e il monitoraggio e riduzione delle emissioni di metano da allevamenti intensivi (Medicus curat, natura sanat).
All’interno della pubblicazione si trovano anche altri progetti inviati in vista di Cop27 a una sessione di Call4Earth realizzata in collaborazione con la rivista Donna moderna. Tra questi un pannello fotovoltaico pieghevole e portatile realizzato dalla startup green tech Levante, un contenitore di rifiuti intelligente opera della sturtup Ganiga e una piattaforma creativa per la circolarità tessile di Resrcle.
Presenti anche la tubina eolica verticale e intelligente della startup Gevi, il superfood nato dagli scarti dell’uva di Vitigna, l’app Conoscere la zona della città con l’aria pulita di CleanxCast, un dispositivo per monitorare e misurare la differenziata in ufficio di ReLearn e la piattaforma per la gestione forestale condivisa di Bluebiloba.
Economia circolare
Economia circolare: a che punto siamo?
Il Circular Economy Network (la rete italiana per la transizione verso un’economia circolare) ha pubblicato in collaborazione con l’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il quarto Rapporto sull’economia circolare in Italia. «La sfida - si legge nel documento - è disaccoppiare crescita e consumo di risorse»: ma a che punto siamo?
Attualmente, a livello globale, dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso, siamo davanti a un rialzo dei prezzi di alcune materie prime. Secondo i dati del report, tra il 2018 e il 2020 il tasso di circolarità è sceso dal 9,1% all’8,6%: «Questo andamento negativo dipende dall’aumento dei consumi che, negli ultimi 5 anni, sono cresciuti di oltre l’8%, a fronte di un incremento del riutilizzo di appena il 3%». A cercare di invertire la rotta, Italia e Francia che si posizionano entrambe al primo posto nella top 5 delle principali economie circolari europee (seguite da Spagna, Polonia e Germania).
Nonostante la classifica, negli ultimi cinque anni l’Italia non ha registrato quel disaccoppiamento tra PIL e consumo di materiali di cui parlavamo prima, indice di una buona performance di circolarità economica. I dati italiani, quindi, risultano buoni solo se comparati con le tendenze complessive: «in un contesto generale negativo - riporta l’analisi - l’Italia è riuscita a contenere i danni e a migliorare alcuni indicatori di circolarità meglio di altri Paesi».
Nel 2020, in nessuno dei cinque Stati considerati è stato registrato un incremento della produttività delle risorse ma, mentre in Europa per ogni kg di risorse consumate sono stati generati 2,1 euro di PIL, l’Italia ne ha registrati 3,5 (quindi il 60% in più rispetto alla media europea).
«Questo andamento viene confermato anche dal tasso di utilizzo circolare di materia» spiega il Circular Economy Network. La media europea raggiunta nel 2020 è stata del 12,8% mentre in Italia del 21,6%, valore secondo solamente a quello della Francia (22,2%) precisa il report, ma comunque superiore di quasi ben 10 punti rispetto a quello della Germania (13,4%, terza classificata). Questo dato è il risultato di un trend in crescita in Italia da anni, che è partito dall’11,6% nel 2011 per arrivare al 21,6% nel 2020.
Anche riguardo al consumo di energia rinnovabile, l’Italia si colloca in seconda posizione con il 18,2%, preceduto solo dal 18,4% della Spagna. Comunque un buon risultato se consideriamo il dato europeo, 19,7% (raggiunto grazie a un trend crescente del 5% circa tra il 2010 e il 2019).
Focalizzando l’attenzione sui rifiuti, nel 2018 il nostro Paese ne ha prodotti 173 milioni di tonnellate, raggiungendo quasi il risultato migliore tra i cinque Stati (406 per la Germania, 343 per la Francia, 175 per la Polonia e 138 per la Spagna). Parallelamente, la percentuale del riciclo ha raggiunto quasi il 68%, contro la media europea del 35%.
Passando ai fattori negativi, possiamo menzionare il consumo di suolo, l’ecoinnovazione e la riparazione dei beni. Riguardo al primo punto, e considerando che nel 2018 in Europa il 4,2% del territorio risultava coperto da superficie artificiale, l’Italia invece raggiungeva il 7,1%. Anche sul fronte ecoinnovazione i risultati non sono buoni, essendosi classificata «dal punto di vista degli investimenti al tredicesimo posto nell’Ue». Infine la riparazione dei beni, dove nel 2019 si contavano oltre 23.000 aziende (per la riparazione di beni sia elettronici che personali), un settore nel quale abbiamo perso circa il 20% delle aziende rispetto al 2010.
«L’Italia, dunque, occupa una buona posizione in Europa sul fronte dell’economia circolare - si legge nelle conclusioni del report - ma le sue performance non le consentono al momento di raggiungere gli obiettivi che il quadro economico attuale richiede». Come agire quindi?
La soluzione potrebbe trovarsi nel Piano di azione per l’economia circolare (approvato dal Parlamento europeo nel 2021), che pone particolare attenzione alla progettazione ecocompatibile dei prodotti e alla circolarità dei processi produttivi. Il Piano punta ad arrivare entro il 2030 a un tasso di utilizzo circolare dei materiali di almeno il 30% e a ridurre del 50% la produzione di rifiuti entro il 2040.
«La conversione verso modelli di produzione e di consumo circolari è sempre più una necessità, non solo per garantire la sostenibilità dal punto di vista ecologico, ma per la solidità della ripresa economica, la stabilità dello sviluppo e la competitività delle imprese», spiega il rapporto. In Italia, in Europa e nel mondo.
Quanto è circolare l’economia globale?
Cinquecento miliardi di tonnellate. È la quantità di risorse consumata globalmente nell’arco degli ultimi 6 anni, tra la COP21 di Parigi nel 2015 e la COP26 di Glasgow. Il calcolo lo ha fatto il think-tank Circle Economy che, come ormai ogni gennaio dal 2018, ha presentato il nuovo Circularity Gap Report. Il documento, che fotografa lo sviluppo dell’economia circolare nel mondo, non porta buone notizie: tuttora più del 90% delle risorse estratte e consumate non ritorna nei cicli produttivi, ma diventa rifiuto. L’economia mondiale è oggi circolare solo per l’8,6%. E non sta migliorando.
I 50 anni dei Limiti dello sviluppo: a che punto siamo?
Il 2022 segna un anniversario importante: esattamente 50 anni fa il Club di Roma pubblicava il primo “Rapporto sui limiti dello sviluppo”, lanciando un chiaro monito circa il rischio di collasso di un’economia e una società basate sulla crescita infinita. Monito che è purtroppo rimasto in buona parte inascoltato, visto che da allora il consumo annuale di risorse è quadruplicato, passando dai 28 miliardi di tonnellate del 1972 agli oltre 100 miliardi di tonnellate attuali. Intanto l’economia circolare ha cominciato ad affacciarsi sulla scena globale, prima come suggestiva visione, poi come concreta possibilità di cambiare il sistema, per arrivare, oggi, a essere un concetto quasi mainstream. La strada perché diventi la norma è tuttavia ancora lunga, come sottolinea il Circularity Gap Report.
Ma il momento storico sembra favorevole: “Sulla scia della COP26, - scrivono gli autori nell’introduzione - l’interesse della sfera pubblica e di quella economica per l’azione climatica è alto” e gli strumenti dell’economia circolare possono rivelarsi fondamentali nella lotta al riscaldamento globale. Nonostante, infatti, il tema sia quasi sempre assente ai meeting per il clima, sono proprio i processi di estrazione, lavorazione, consumo e smaltimento dei materiali a emettere la maggior parte dei gas a effetto serra: ben il 70%. Riducendo drasticamente lo sfruttamento di materie prime vergini, l’economia circolare, come si legge nel report, potrebbe allora tagliare le emissioni di carbonio addirittura del 39%, riportando il mondo sulla strada per il contenimento delle temperature a +1,5°C.
21 soluzioni e un tool digitale
Non avendo buone notizie da offrire sul fronte del miglioramento del tasso di circolarità globale, il team di Circle Economy ha pensato allora di proporre un po’ di soluzioni concrete: 21 per l’esattezza. Dopo aver fornito una panoramica di quanto consumiamo e quanto poco risparmiamo, ripariamo, condividiamo, riutilizziamo e ricicliamo, il report suddivide metodicamente il sistema economico in 7 aree che corrispondono alle necessità e ai desideri della società: casa, alimentazione, mobilità, prodotti di consumo, servizi, salute, comunicazione. Per ognuna individua quindi dei possibili interventi in direzione di una maggiore circolarità ed efficienza, secondo 4 principi di base: usare meno risorse, farle durare più a lungo, rigenerarle, riciclarle. “L’economia circolare diventa così lo strumento per soddisfare i bisogni della società globale senza oltrepassare i limiti del Pianeta” ha spiegato in conferenza stampa Laxmi Adrianna Haigh, co-autrice del report insieme a Marc de Wit.
Basta anche solo un rapido sguardo alle 21 soluzioni proposte, per accorgersi che quelle con un potenziale maggiore nella riduzione di emissioni e di consumo di risorse riguardano soprattutto due settori: l’edilizia e i trasporti. Allungare la vita utile dei veicoli, passare a modelli di mobilità condivisa, utilizzare materiali edilizi circolari e soprattutto ridurre il consumo di suolo abitando case più piccole ed efficienti sono in assoluto le soluzioni più efficaci e con l’impatto positivo più importante per l’ambiente. Ma i suggerimenti spaziano naturalmente a ogni settore, dal design dei prodotti all’agricoltura fino alla dieta quotidiana. Come ha ricordato durante la presentazione Anders Wijkman, presidente onorario del Club di Roma e Chair di Climate-KIC, “troppe persone sono ancora convinte di poter risolvere la crisi ambientale semplicemente aspettando l’arrivo di qualche nuova tecnologia verde. Ma non basta, quello che serve subito è una trasformazione del nostro stile di vita”.
“Una trasformazione circolare che deve avvenire a livello globale – ha sottolineato Matthew Fraser, responsabile della Circularity Gap Reporting Initiative – Per questo con Circle Economy abbiamo deciso di creare un tool digitale per aiutare le imprese, le città e le nazioni nella transizione circolare”. Il nuovo strumento, che sarà presentato ufficialmente in aprile, risponde all’esigenza sempre più sentita di metriche per valutare l’economia circolare, i suoi effettivi impatti, i vantaggi che porta non solo all’ambiente ma anche alla società. Si chiama Ganbatte, esortazione giapponese che corrisponde a “Forza! Rimbocchiamoci le maniche!” ed è un vero e proprio programma di azione che sarà a disposizione delle aziende, delle amministrazioni e dei governi per esplorare le soluzioni già esistenti, misurare le proprie performance e quindi rimboccarsi le maniche.
Agendo su più livelli, la visione di Circle Economy mira appunto a raggiungere uno sviluppo globale dell’economia circolare. Ma quali sono i maggiori ostacoli da superare?
Ostacoli e prospettive per un’economia circolare globale
Secondo Anders Wijkman il maggior freno è tuttora il sistema: “Il Circularity Gap Report dimostra che siamo ancora molto lineari. Ed è il sistema a decidere che le cose funzionino così. Finché le materie prime vergini saranno più economiche dei materiali riciclati, l’economia circolare non potrà mai decollare”.
Per Elisa Tonda, capo della Consumption and Production Unit dell’UNEP, un grosso limite sta nella scarsa integrazione fra le varie iniziative: “Nel mio lavoro vedo molti progetti validi ma isolati o settoriali, che non vengono integrati nei programmi governativi. Ci sono inoltre troppi impegni volontari e poche risoluzioni vincolanti”.
Per Walter Stahel, il padre morale dell’economia circolare, bisogna stare attenti anche alle buone intenzioni: “è necessario evitare le tecnologie ad alta intensità di risorse. Per fare un esempio, i veicoli elettrici sono in media il 50% più pesanti di quelli tradizionali. Dobbiamo imparare a uscire dagli schemi e pensare a tecnologie completamente diverse”.
Per quanto riguarda le prospettive future per l’economia circolare, Stahel le condensa in una parola: sufficienza. “Più ancora che sull’efficienza, dobbiamo puntare alla sufficienza – spiega – Invece di produrre più cose, dobbiamo ottimizzare al massimo l’utilizzo di quelle esistenti. L’economia deve trovare strategie per guadagnare con meno prodotti”. Per Elisa Tonda, infine, sarà fondamentale anche cambiare il modo in cui si guarda all’economia circolare: “La transizione circolare deve essere inclusa nei discorsi sul clima, sulla perdita di biodiversità, sull’inquinamento. Bisogna imparare a guardarla per quello che è: un tema cross-settoriale”.
Testo a cura di Materia Rinnovabile
Come possiamo rendere l’industria circolare?
Studiare il panorama industriale attuale, basato sui combustibili fossili, e immaginare scenari per un futuro basato sulla bioeconomia circolare.
È questo l’obiettivo di Sustrack, un progetto triennale dell'Università Unitelma Sapienza di Roma, finanziato dalla Commissione europea.
Dopo una fase preparatoria iniziale, le sue attività sono in partenza. In particolare, i ricercatori proveranno a identificare e a stilare una lista di raccomandazioni e temi prioritari, da sottoporre alla politica, per indirizzare la transizione verso sistemi di produzione bio-based e circolari. Si tratta di uno scenario nel quale tutte le risorse biologiche, come piante e animali, vengono sfruttate o riutilizzate in maniera efficiente, per fabbricare beni e fornire servizi, minimizzando l’impatto ambientale.
La bioeconomia circolare, secondo gli esperti, può essere il traino verso un nuovo modello economico più sostenibile.
Lo rendono necessario, da una parte. l’avanzare sempre più rapido della crisi climatica, con fenomeni che incidono su agricoltura, attività produttive e legate alle forniture di energia, come la siccità o le alluvioni.
Dall’altra, eventi come la guerra in Ucraina, che ha rivoluzionato i piani per l’approvvigionamento di gas e petrolio di tutti gli Stati europei.
Per ideare politiche di trasformazione e innovazione che funzionino, serve però un’ampia conoscenza dei principali settori industriali, dal chimico al tessile. Ciò permetterà di indirizzare meglio eventuali investimenti e creare nuovi mercati green, pur con “la capacità di assumersi rischi”, come si legge nella nota di presentazione del progetto.
Proprio a questo scopo entra in gioco il team di Sustrack, che eseguirà una valutazione critica degli impatti dell'attuale economia lineare.
La sfida è identificare sia i vantaggi che i limiti di un sistema basato sull’utilizzo dei fossili, nonché il “potenziale di miglioramento associato ai sistemi circolari a base biologica”, affermano i ricercatori in un comunicato stampa.
L’obiettivo è dare “contributi significativi all'identificazione delle priorità politiche e delle agende industriali” italiane.
Il progetto farà tesoro delle esperienze precedenti dei progetti STAR-ProBio, BioMonitor e Star4BBI, sempre finanziati da Bruxelles. Collabora inoltre diversi partner scientifici che si occupano di economia circolare.
In uno sforzo congiunto con l'European Bioeconomy Network (EuBioNet), è stato infatti segnalato come il promotore del gruppo di lavoro in "standardizzazione, certificazione, etichettatura e monitoraggio".
Attualmente Sustrack si sta concentrando sui limiti ambientali, economici e sociali dell'economia lineare, ad alta intensità di anidride carbonica, tramite quattro case study: il settore edile, tessile, chimico e della plastica.
Infatti questi rami della produzione industriale sono tra i più inquinanti e interventi governativi per limitare le loro emissioni, i loro consumi energetici e idrici potrebbero penalizzarli. Nel prossimo futuro saranno però anche quelli che potranno beneficiare dei vantaggi della bioeconomia circolare, diventando anche più sostenibili.
«Il passaggio da sistemi lineari a base fossile a sistemi circolari e a base biologica rappresenta un'opportunità e un percorso idoneo per il raggiungimento di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - afferma Piergiuseppe Morone, professore e ricercatore presso l'Università Unitelma Sapienza di Roma e coordinatore del progetto Sustrack - I sistemi circolari a base biologica rappresentano una grande occasione per conciliare una crescita sostenibile a lungo termine con la protezione dell'ambiente attraverso l'uso prudente delle risorse rinnovabili per scopi industriali».
«Questa transizione necessaria – ammette - è un processo complesso, che non richiede semplicemente tecnologie innovative dal lato dell'offerta, ma anche trasformazioni sociali basate su un processo multi-attore».
Della stessa opinione è anche Gülşah Yilan, responsabile di Sustrack: «Miriamo a sostenere i responsabili politici e le industrie nei loro sforzi per sviluppare percorsi sostenibili per sostituire i sistemi a base fossile e ad alta intensità di carbonio con sistemi circolari a base biologica».
Quanto possono crescere le PMI con un’economia circolare?
Nel quarto trimestre l’Italia è cresciuta: Lewis Cooper, analizzando gli ultimi dati dell'indagine sull’Italia, ha parlato di ottime prestazioni. Insomma, non siamo andati così male secondo l’economista dell’IHS Market PMI: l’indice registrato a dicembre è stato del 62,8%. È diciotto mesi che le piccole medie imprese italiane crescono.
“Il manifatturiero italiano ha chiuso il trimestre finale del 2021 con un'altra ottima prestazione”, ha dichiarato Cooper. La produzione e i nuovi ordini hanno continuato infatti a crescere, nonostante i problemi legati alla carenza di materiali e il crescente costo di approvvigionamento, legato ai trasporti.
Tutto bene quindi? Certo che no, perché le attese da parte delle imprese sono caute dovute proprio al mix di pandemia, pressione sui prezzi e difficoltà della distribuzione.
E tuttavia, tra le PMI che hanno avviato la svolta green, la quota di imprese che ritiene di poter raggiungere i livelli di produttività pre-Covid già nel 2022 è alta. Non a caso, chi è verde, in questo momento, sta meglio, in tutti i sensi.
Lo afferma anche il rapporto GreenItaly realizzato da Fondazione Symbola (in collaborazione con Il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere): dopo la crisi del 2020, il 14% delle imprese che ha investito in processi e prodotti a maggior risparmio energetico, idrico e/o minor impatto ambientale, prevede un incremento di fatturato. Ed effetti positivi anche sul mercato del lavoro: il 6% delle imprese green-oriented prevede incrementi nell’occupazione, il 12% un miglioramento nell’export, superando di tre punti percentuali la quota di imprese che non investe nella transizione ecologica.
Greenitaly ha incoronato l’Italia come leader nell’economia circolare con un riciclo sulla totalità dei rifiuti - urbani e speciali - del 79,4% (i dati si riferiscono al 2018). Nonostante un percepito negativo, siamo sopra la media europea (49%) e a quella degli altri grandi Paesi come Germania (69%), Francia (66%) e Regno Unito (57%); il risparmio annuale nel 2018 è stato pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 63 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 nelle emissioni grazie alla sostituzione di materia seconda nell’economia.
E sono sempre di più le imprese che investono risorse per migliorare il profilo ambientale di processi, prodotti e servizi. Nel quinquennio 2016-2020, il 31,9% delle aziende nell’industria e nei servizi (441.415 imprese) ha investito in tecnologie e prodotti green, valore che sale al 36,3% nella manifattura (84.810 imprese). Positivo anche il bilancio sotto il profilo dell’occupazione: a fine dello scorso anno gli occupati che svolgevano attività che richiedono competenze green erano pari a 3.141.400, mentre i contratti relativi a questa tipologia di professionisti hanno rappresentato il 35,7% dei nuovi previsti nell’anno - tra le aree più richieste, progettazione, R&S e logistica.
Nella graduatoria dei Paesi dell’Unione europea per indici di eco-efficienza ed eco-tendenza, nel 2019 l’Italia si è posizionata al 4° posto per eco-efficienza, il modello di management che incoraggia le aziende a diventare più responsabili nei confronti dell’ambiente, unendo gli obiettivi di eccellenza economica dell'impresa con quelli di eccellenza ambientale - l’eco-tendenza è invece la capacità di un Sistema Produttivo di migliorare la propria eco-efficienza in un arco di tempo prestabilito rispetto a quanto fatto complessivamente nell’Unione europea; l’indice è calcolato come rapporto tra il valore dell’eco-impatto nell’anno corrente e l’analogo valore nell’anno base.
L’elaborazione dei dati Eurostat mostra una forte crescita dell’eco-efficienza in Italia a partire dalla crisi economica del 2008 fino al 2013, periodo di forti investimenti nelle energie rinnovabili e del rilancio dell’efficienza energetica per recuperare il PIL perso in precedenza. La crisi del debito e le conseguenti politiche di austerity hanno però avuto effetti anche sulle scelte green delle imprese italiane. Dal 2013 il trend dell’eco-efficienza ha avuto una contrazione che riporta nel 2019 l’indicatore quasi al livello di inizio periodo. Andamento simile anche in Spagna, in controtendenza invece la Germania che dal 2013 al 2015 ha segnato un minimo relativo di eco-efficienza per poi passare a un trend crescente.
Tornando a esaminare la performance nazionale, rispetto al 2008, nel 2019 le emissioni di agenti inquinanti, i consumi energetici e la produzione di rifiuti in Italia sono sì diminuiti, ma meno rispetto alla media UE: -31,2% di emissioni in Italia contro -35,2% media UE; -19,1% di energia consumata in Italia contro -22,2% media UE; -5,9% di rifiuti prodotti in Italia contro -9,7% media UE.
Greenitaly 2021 sottolinea come a trainare i progressi del nostro Paese siano stati i miglioramenti in termini di impiego di materie prime, con performance migliori rispetto alla media UE (-44,1% Italia e -33,0% media UE di materie prime utilizzate nel 2019 rispetto al 2008). Si registrano difficoltà a tenere il passo negli altri ambiti di analisi, in particolare nel ridurre l’ammontare di rifiuti prodotti dove i miglioramenti fatti dal Paese sono deboli rispetto alle performance medie conseguite dagli altri membri UE.
Cos’è la Strategia nazionale per l’economia circolare?
Nella giornata del 24 giugno, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato i decreti per l’adozione della Strategia nazionale per l'economia circolare e l’approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, due riforme strutturali previste all’interno del Pnrr.
La Strategia aggiorna i principi del documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico”, pubblicato nel 2017 per l’attuazione della più ampia Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal governo italiano il 2 ottobre dello stesso anno.
Tra le misure previste un sistema digitale per migliorare la tracciabilità dei rifiuti, incentivi fiscali per supportare l’utilizzo di materiali derivanti dalle filiere del riciclo (Materie prime seconde), una revisione del sistema di tassazione che promuova il riciclo a fronte dello smaltimento in discarica, la riforma dei sistemi di Responsabilità estesa del produttore e il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti, come la legislazione “End of Waste” e i Criteri Ambientali Minimi.
La Strategia, inoltre, si legge nella sintesi del documento, «costituisce uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e definisce una roadmap di azioni e di target misurabili da qui al 2035».
Nel 2021, secondo i dati pubblicati a inizio settimana da Conai (Consorzio nazionale degli imballaggi), l’Italia ha avviato a riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul mercato, pari a 10 milioni e 550.000 tonnellate. Un risultato in leggera crescita rispetto al 2020 e al di sopra del target al 65% fissato dall’Europa entro il 2025.
Un valore che supera l’82% se alle cifre dell’avvio a riciclo sommario quelle del recupero energetico. «Più di 8 imballaggi su 10 oggi evitano la discarica. Siamo primi fra i grandi Paesi europei, secondo i dati Eurostat, per riciclo pro-capite, e la stragrande maggioranza dell’avvio a riciclo avviene sul territorio nazionale», ha commentato il presidente di Conai Luca Ruini.
Se si considera il totale dei rifiuti urbani, come riportato dai dati Ispra per il 2020, il riciclaggio si attesta al 54,4%, valore comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico. L’Italia è vicina, quindi, all’obiettivo europeo del 55% entro il 2025, quota destinata a salire al 60% entro il 2030. Ancora critico il comparto della plastica, con il 48,7% della frazione riciclata. Una percentuale che scende al 41,1% se si applica il nuovo metodo di calcolo europeo in vigore dal 2020, che considera solo i rifiuti immessi a tutti gli effetti nel processo di riciclaggio ed elimina le eventuali perdite che potrebbero verificarsi nel corso della filiera.
Quello delle materie plastiche è oggi l’unico settore merceologico a non aver ancora raggiunto gli obiettivi minimi fissati dall’Europa nel cosiddetto Pacchetto Rifiuti, che prevede il 50% di riciclaggio al 2025 e il 55% entro il 2030.
In questo contesto si inserisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome in un arco temporale di 6 anni da qui al 2028.
«Troppo spesso il tema dei rifiuti è stato trattato in modo ideologico», ha dichiarato la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, che ha ricordato come l’Italia «continua a pagare delle sanzioni pesantissime: troppi rifiuti, più di 1,3 milioni di tonnellate, finiscono fuori Regione o all'estero a causa dell'assenza di una rete integrata di impianti funzionale».
«Grazie al Pnrr e a una corretta pianificazione», ha concluso Gava, «abbiamo finalmente l’occasione di promuovere e costruire nuovi impianti, moderni e sicuri, tecnologicamente avanzati, per il trattamento dei rifiuti dove serve».
Cos’è la bioeconomia circolare tra Italia e Francia?
A fine marzo l’Italia ha firmato un protocollo d’intesa tra l’associazione francese Bioeconomy for Change e Spring, il cluster italiano della bioeconomia circolare nato nel 2014 e oggi parte della cabina di regia nazionale sul tema.
Il memorandum, si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri, «ha lo scopo di rinforzare la collaborazione tra i due ecosistemi nazionali a favore della ricerca, dell’industrializzazione e della commercializzazione di idee innovative biobased».
Il protocollo conferma inoltre la collaborazione tra i due Paesi europei sancita dal Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre 2021, che prevede una cooperazione bilaterale rafforzata in aree come la politica economica e migratoria, la sicurezza e la difesa, l’istruzione, lo sviluppo sociale, l’industria aerospaziale, la ricerca e l’innovazione.
Per quanto riguarda in particolare l’ambiente, il testo del Trattato recita che le parti firmatarie sono «determinate a combattere il cambiamento climatico e a preservare la biodiversità», si dichiarano «convinte che i progressi economico, sociale e ambientale siano indissociabili» e «consapevoli che la sicurezza e la prosperità delle nostre società richiedano un’azione urgente per salvaguardare il nostro Pianeta».
«La bioeconomia circolare costituisce uno dei pilastri della transizione verde», ha commentato l’ambasciatrice Teresa Castaldo in merito al protocollo d’intesa. «Le collaborazioni che avvieranno direttamente gli associati alle due organizzazioni», ha aggiunto, «possono diventare un modello di riferimento in altri settori di cruciale importanza per lo sviluppo sostenibile».
Ma cosa si intende con l’espressione “bioeconomia circolare”? Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, la bioeconomia «concerne tutti i settori e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, compresi i rifiuti organici)», ovvero comprende «tutti i settori della produzione primaria che utilizzano e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura), e tutti i settori economici e industriali che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, energia e servizi».
L’impatto della bioeconomia circolare è ritenuto di fondamentale importanza nel processo di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Accordo di Parigi e ribaditi dal Green Deal europeo all’interno del Piano d’azione per l’economia circolare, che il 30 marzo ha presentato un nuovo pacchetto di proposte sui prodotti sostenibili.
Secondo l’ultimo rapporto realizzato dalla Direzione centro studi di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Assobiotec, nel 2020 la bioeconomia in Italia ha generato un valore di produzione pari a 317 miliardi di euro, terzo Paese in Europa dopo Germania e Francia, dando lavoro a circa 2 milioni di persone in particolare nella filiera agro-alimentare, che copre circa il 70% degli occupati, seguita dal sistema moda (10,3%) e dalla filiera del legno-arredo (9,1%).
Il protocollo d’intesa siglato presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, fa sapere la Farnesina, prevede inoltre l’istituzione di un gruppo di lavoro per la determinazione di aree tematiche prioritarie, come quella relativa alle plastiche.
Oggi l’associazione Bioeconomy for Change riunisce più di 450 membri tra cooperative, aziende, università, autorità pubbliche e fondi di investimento. Il cluster Spring, invece, conta sull’adesione di oltre 120 soggetti e dal 2017 è parte del Gruppo di coordinamento nazionale per la bioeconomia, attivo nell’ambito del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Riparare gli oggetti sarà un dovere?
In Ue, gettare via prodotti che potrebbero essere riparati causa ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti, 30 milioni di tonnellate di risorse sprecate e 261 milioni di emissioni di gas a effetto serra.
Per cercare di ridurre i rifiuti e promuovere la riparazione come scelta di consumo più sostenibile, la Commissione europea ha adottato una nuova proposta sul “diritto alla riparazione”. L'idea è istituire una serie di norme comuni che facilitino il recupero di dispositivi tecnicamente riparabili secondo gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal, con un beneficio anche per le tasche dei consumatori. Riparare anziché sostituire un prodotto ancora funzionale, secondo le stime presentate a sostegno di questa misura, comporterebbe per i cittadini europei un risparmio di circa 12 miliardi di euro all’anno.
«La riparazione è essenziale per porre fine al modello "prendi, produci, rompi e getta" così dannoso per il nostro Pianeta, la nostra salute e la nostra economia. Non c'è motivo per cui un filo difettoso o un ventilatore rotto debbano costringerci ad acquistare un prodotto completamente nuovo. L'anno scorso abbiamo proposto norme per garantire che i prodotti siano progettati per essere riparabili. Oggi proponiamo di fare della riparazione un'opzione facile e interessante per i consumatori», ha detto Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, in occasione della presentazione della proposta.
Secondo quanto emerso dagli studi affrontati dalla Commissione, l’accesso alla riparazione è però spesso considerato difficile dai consumatori. Per questo, la Commissione vuole introdurre maggiori garanzie legali, chiedendo ai venditori di offrire a chi compra il servizio di riparazione dei dispositivi, tranne nei casi in cui questa opzione è più costosa della loro sostituzione.
I produttori avranno anche l'obbligo di informare i consumatori riguardo i prodotti per i quali sono tenuti a fornire la riparazione, che sarà resa più accessibile anche attraverso strumenti che vanno oltre la garanzia legale. Tra questi, la Commissione vuole creare una piattaforma online per la riparazione che consenta di mettere in contatto gli acquirenti con i riparatori e i venditori di beni soggetti a ricondizionamento presenti sul territorio.
La proposta, che ora deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, prevede anche la diffusione di un modulo europeo che i consumatori potranno richiedere a qualsiasi riparatore per ricevere informazioni relative alla trasparenza delle condizioni di riparazione e del suo prezzo. Il criterio di riferimento sarà una nuova norma di qualità europea per i servizi di riparazione che dovrebbe aiutare i consumatori a individuare i riparatori che si impegnano a offrire una qualità di servizio superiore.
Il “diritto alla riparazione facile” intende integrare e rafforzare la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e spingere i produttori a sviluppare soluzioni sempre più sostenibili che riguardino l’intero ciclo di vita di un prodotto, come indicato anche dal piano d'azione per l'economia circolare.
Nella stessa direzione va la direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile: “durabilità, riutilizzabilità, possibilità di upgrading e riparabilità del prodotto” sono solo alcuni dei requisiti stabiliti dall’Ue per quasi tutte le categorie di beni fisici ammessi nel mercato europeo.
Gli italiani conoscono il riutilizzo dei materiali?
Ci risiamo. Come per la questione della cosiddetta plastica biodegradabile - filone nel quale l’Italia ha investito senza farsi domande, salvo poi sentirsi dire dall’Europa che non era in alcun modo una soluzione, perché la vera soluzione per liberarsi dalla plastica è liberarsi dal monouso – allo stesso modo oggi lo scontro tra Italia e la Commissione europea è tra il riciclo e il riutilizzo. Ancor prima che due pratiche diverse, due visioni filosofiche e modi di pensare opposti.
Gli italiani non sanno cosa sia il riuso
L’Italia, da sempre, ha scelto la prima strada: raccolta differenziata, riciclo dei rifiuti, con livelli molto alti rispetto alla media europea, arrivando al 73,3% degli imballaggi riciclati (ma la situazione nel Paese è assolutamente eterogenea).
Peccato che l’Europa, appunto, abbia indicato un’altra strada, sotto la spinta, forse, dei Paesi frugali del nord, che il riciclo lo fanno poco. Ovvero il riutilizzo dei materiali, per ridurre il packaging, quello che sta soffocando il Pianeta, del 15% entro il 2040. Un obiettivo perfettamente raggiungibile e che significa, semplicemente, che le persone vanno educate a usare un contenitore e poi restituirli. Che sia una bottiglia d’acqua come una zuccheriera al bar.
L’obiettivo è quello contrastare il fenomeno da anni fuori controllo del monouso e la convinzione che se tutto non è perfettamente imballato, sterilizzato, personalizzato allora non può essere usato.
Per esempio, la decisione sempre della Commissione di vietare il monouso nel settore degli alberghi è sacrosanta. Siamo talmente assuefatti ad avere i nostri flaconcini personalizzati che ormai quasi ci scoccia se nella stanza troviamo invece un unico dispenser di sapone toccato da chissà da quali altre mani. E non ci rendiamo conto non solo che per lo più i flaconcini monouso restano inutilizzati da noi per primi, ma creano una quantità di rifiuti di plastica inimmaginabile.
Ma siamo talmente analfabeti dal punto di vista del riutilizzo che ci scoccia pure prendere lo zucchero da una zuccheriera comune oppure usare una confezione di ketchup aperta, cosa che dovremo fare visto che sempre l'Ue ha vietato bustine di zucchero e di maionese e ketchup.
Per riciclare serve energia
Come al solito, a difendere il riciclo e insieme il monouso si sono alzate le voci di Confindustria e degli industriali del packaging ed è sicuro che il nuovo governo, e il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica starà dalla loro parte. Certo, è ovvio che se si riduce il monouso ci saranno industrie che dovranno fare un passo indietro, eventualmente riconvertirsi. Per questo, infatti, si parla di “transizione” ecologica.
E no, non si può dire che tanto la plastica, così come tutto il resto, si ricicla perché riciclare è un processo costoso, che richiede energia, e dunque produce CO2, altro che far del bene all’ambiente. Sempre che poi il riciclo venga fatto correttamente quando spesso - parlo a esempio della mia città, Roma – di fatto una quantità enorme di materiali riciclabili finiscono in discarica.
L’economia circolare parte dal riuso
È altrettanto sbagliato sostenere che la decisione della Commissione metta in discussione l’economia circolare.
Riciclare è un bel verbo, ma nel lessico dell’economia circolare ancora prima di esso esiste il riuso. E solo dopo che si è riutilizzato e che il contenitore è stato buttato subentra appunto il riciclo. La gerarchia va pensata così, non con il riciclo come prima istanza.
Di nuovo lo si vede a Roma, dove il problema sta nell’enorme quantità di rifiuti, causata dagli imballaggi, che impedisce la differenziata e dunque rende difficile il riciclo. La strada sta nella riduzione dei rifiuti, perché la loro massa è ormai incontrollata.
Anche qui, si scontrano due visioni filosofiche diverse: chi sostiene che non si debbano cambiare abitudini, ma solo tecnologie, e che quindi la tecnologia ci consente di continuare a fare esattamente come prima. E chi sostiene che per contrastare la crisi climatica occorra cambiare abitudini e atteggiamenti. Se non la volete chiamare decrescita, chiamatela semplicemente una nuova attitudine. Nel caso del riuso, non certo particolarmente dolorosa.
Covid e cibo da asporto ci hanno legato al monouso
Purtroppo il Covid ha diffuso ancor di più la mentalità del monouso, convincendoci che non è possibile condividere nulla pena, appunto, il contagio. Ma ciò che non viene mai detto è che il virus è legato alla devastazione ambientale, quella devastazione a cui la plastica e la quantità inimmaginabile di contenitori contribuisce.
Oltre al Covid, un altro aspetto ci sta ancora più legando alla dittatura del monouso: la diffusione veramente incontrollata del cibo da asporto. Che produce quantità di contenitori di plastica che si potrebbero risparmiare.
In parte, tra l’altro, i due approcci possono anche essere complementari. Quando parliamo, di acciaio, di carta, è ovvio che il riciclo è fondamentale, ma se parliamo di bottiglie di plastica e contenitori di ogni sorta no. È fondamentale, ripeto, che anche in Italia cominci a diffondersi la mentalità del riutilizzo, come – per fare un altro esempio - l’utilizzo di prodotti alla spina, detersivi compresi. Un modo di agire e consumare che le grandi aziende avversano, e lo si vede, perché a differenza che in Francia, i prodotti alla spina non esistono al supermercato, sarebbero una sorta di eresia: perché, parliamoci chiaro, quando le aziende vendono grandi spray di plastica dura per detergere o grossi flaconi di sapone per lavatrice o bagnoschiuma il contenitore diventa un ulteriore prodotto da vendere insieme al contenuto. Che dopo pochi giorni finisce, appunto, nella pattumiera, pronto per essere riciclato quando avrebbe potuto, semplicemente, essere riutilizzato.
Un problema, come al solito, culturale
In fondo, è sempre un fattore culturale: il monouso riflette il nostro individualismo, il fatto che ci concepiamo come monadi chiuse e consumiamo appunto in modo individualistico, soggettivo. Il riuso ci parla di condivisione, di un modo di vivere comune, dove una cosa un giorno la uso io, poi, lavata, il giorno dopo la usi tu. Un modo di agire da sempre praticato dall’umanità e che noi siamo stati capaci di cancellare, rendendolo qualcosa di bizzarro se non addirittura pericoloso.
Ma non c’è, dubbio, questa è la strada, pratica e concettuale. Il governo si opporrà, Confindustria pure, ma non possiamo diminuire la quantità di materia artificiale dispersa nel mondo senza toccare il monouso o diminuire i prodotti da riciclare. Semplicemente, non c’è un’altra alternativa. D'altronde, se non sappiamo neanche rinunciare a una bustina di zucchero chiusa, come fermeremo l'Apocalisse climatica?
La raccolta della plastica quanto riduce le emissioni di CO2?
Nonostante il processo sia migliorato sensibilmente negli ultimi anni, con raccolta porta a porta, sacchetti e bidoni forniti dai comuni, manuali e liste che guidano passo a passo i cittadini su dove buttare cosa, fare la differenziata viene ancora percepita da molti come una scocciatura.
In realtà, differenziare i rifiuti e consentire così il riciclo dei materiali, e in particolare della plastica, non è solo un’azione che ci consente di non contravvenire la legge e di evitare multe salate, ma è un vero e proprio atto di civiltà nei confronti del pianeta e delle generazioni che verranno dopo di noi.
La plastica è uno dei materiali più protagonisti della nostra vita quotidiana.
Basta fare un giro al supermercato, praticamente tutto è incartato in imballaggi di plastica, dall’insalata al balsamo per capelli. Per quanto ci si sforzi di vivere una vita consapevole ed ecologica comprando alimenti sfusi, prodotti di bellezza solidi e il pane dal panettiere dietro l’angolo la plastica sembra non darci tregua.
L’unica via di uscita per evitare che questo accumulo distrugga l’ambiente, rovinando l’equilibrio di interi ecosistemi e inquinando oceani, fiumi e laghi è il riciclo. E perché la plastica possa essere riciclata è necessario fare la differenziata.
Secondo il Rapporto di Sostenibilità 2021 di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero della plastica, in Italia nel 2021 la raccolta differenziata urbana ha prodotto quasi 1,5 tonnellate di imballaggi in plastica, il 3% in più rispetto all’anno precedente.
Di queste, eliminati gli scarti dovuti a materiali errati, Corepla ha recuperato ben 1,2 milioni tonnellate e ne ha avviati a riciclo 722.218 t (il 10% in più rispetto al 2020); 314.964 t sono state invece destinate al recupero energetico.
Questo ha consentito il risparmio di 520.000 tonnellate di materia prima vergine (corrispondente a 2 miliardi di bottiglie pet da un litro). Sono stati evitati 34,5 milioni di m3 di discarica, 879.000 tonnellate di CO2 equivalente, il corrispettivo di oltre mille voli tra Roma e Tokyo e la produzione di quasi 11.000 GWh di energia primaria.
Ai risparmi va poi aggiunto quello che si è guadagnato, ovvero 42 GWh di energia elettrica e 86GWh di energia termica.
Un semplice gesto come la differenziazione dei rifiuti può quindi portare a enormi benefici economici, ambientali e sociali che sono già tangibili oggi, e non qualcosa di astratto o proiettato nel futuro.
Come abbiamo detto oggi in Italia vengono differenziate 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, circa 25 kg per abitante.
Un bel traguardo se consideriamo che nel 1998 la quantità pro capita era appena 1,9 kg.
Sono anche scomparse negli anni le differenze tra Nord e Sud.
Al primo posto tra le regioni si colloca la Sardegna con 34 kg per abitante seguita dall’Umbria (32,2) e la Valle d’Aosta (30,9).
La Sicilia che fino a poco tempo fa differenziava solo 4 kg di rifiuti plastici per abitante oggi è appena sotto la media nazionale con 23,7 kb/ab mentre la Campania la supera con 25,3 kg/ab. Agli ultimi posti ci sono il Molise con 13, 9, Basilicata e Campania con 19,9 e il Trentino Alto-Adige con 19,4 kg/ab.
L’azione di Corepla si inserisce nel contesto dell’Agenda 2030, adottata nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e che definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 tra cui la promozione di consumo e produzione responsabili, la creazione di città e comunità sostenibili, la lotta al cambiamento climatico e la promozione di energia pulita e accessibile.
Durante il convegno di presentazione del Rapporto si è dunque anche parlato di futuro, e il presidente di Corepla Giorgio Quagliolo, ha dichiarato di voler portare la quota di rifiuti avviati al riciclo dal 54,8% attuale al 65,9% entro il 2026.
E quello che non si potrà riciclare dovrà essere destinato, con tecnologie sempre più sofisticate, alla produzione di energia.
Grazie allo sviluppo di modelli innovativi che consentono il recupero energetico Corepla è riuscita a trasformare in energia e calore, 314.964 t di materiale plastico non riciclabile.
Si tratta del cosiddetto Plasmix, imballaggi che derivano dalla selezione meccanica della raccolta differenziata e che a causa della loro eterogeneità o delle condizioni in cui si presentano non possono essere riciclati con le tecnologie a oggi disponibili.
Tuttavia, grazie al loro potere calorifico molto simile a quello dei combustibili fossili tradizionali, risultano ottimali nei processi di combustione e co-combustione, in particolare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche.
Secondo studi recenti presentati dalla stessa Corepla sostituendo una tonnellata di carbone con una di combustibile solido secondario (Css, ovvero materiale plastico) si arriva ad avere un beneficio compreso tra 584 e 1289 kg di emissioni di CO2 evitate.
Utilizzando il Css nei cementifici si potrebbe avere una diminuzione fino a 6,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
Basti pensare che il recupero energetico del Plasmix nel 2020 è stato pari a quello di un impianto fotovoltaico grande come 24 campi da calcio.
Purtroppo, come spiega Quagliolo, l’utilizzo del Css in Italia non ha ancora preso abbastanza piede per avere risultati soddisfacenti.
Attualmente, il tasso di sostituzione calorica dei cementifici nel nostro Paese è del 20%, molto più basso della media europea che si attesta al 50% e quasi nullo rispetto a quello di Paesi come l’Austria che viaggia a quota 80%.
Per il rammarico del presidente della Corepla infatti ben 116.000 tonnellate di Css sono state mandate oltre confine nel 2020, materiale che avrebbe potuto essere utilizzato con profitto in Italia.
Il tema dell’utilizzo del Css, ancora troppo poco conosciuto, potrebbe portare a un notevole efficientamento energetico dell’Italia, oltre che contribuire a liberarci almeno in parte della dipendenza da combustibili fossili che tanto spaventa in questo periodo.
Cosa sono i Raee e perché rappresentano una miniera da sfruttare per l’economia circolare?
Una miniera di rifiuti utili da sfruttare. Metalli, terre rare, materiali vari che fanno parte delle apparecchiature elettroniche oggi sono una risorsa, anche per dipendere meno da altri Paesi, ma in Italia siamo ancora indietro rispetto all'obiettivo necessario fissato dall'Europa per potere avere benefici concreti dall'economia circolare di questo settore.
Ogni anno nel nostro Paese si raccolgono infatti 385 mila tonnellate di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, circa 6 kg per abitante, ma dovremmo arrivare secondo i target europei almeno a 600 mila tonnellate, 11 chili l'anno per persona.
In sostanza, come hanno ricordato gli operatori del settore in un recente convegno a Roma, dobbiamo raddoppiare la raccolta e le quantità da gestire. In questo modo potremo dare una risposta concreta alla carenza di molte materie prime.
Secondo Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee, nel nostro Paese abbiamo un «potenziale enorme se consideriamo che da 100 Kg di Raee si ricavano oltre 90 Kg di materie prime seconde. Se riuscissimo, dunque, a raccogliere le oltre 600mila tonnellate, come ci chiede la comunità europea, potremmo mettere sul mercato 550mila tonnellate di materie prime seconde».
Si parla di ferro, alluminio, rame, ma anche cobalto, palladio e litio utili per esempio nell'industria elettronica e oggi sempre più richiesti, tutte «materie che noi al momento importiamo dipendendo da regimi che oggi sono poco disposti a concedere qualcosa. Dobbiamo provare ad affrancarci. I Raee da soli non bastano a cambiare la situazione ma sarebbero un passo importante nella direzione giusta», precisa Arienti.
Nel convegno romano i principali attori della filiera hanno lanciato così un appello al governo, con 32 proposte, per cercare di aumentare la raccolta, così come la vigilanza e il controllo e al tempo stesso diminuire i flussi illegali di Raee.
Danilo Bonato, direttore generale di Erion Compliance Organization, ha ricordato per esempio come «noi importiamo circa 40 miliardi di metalli e minerali per 70 milioni di tonnellate all'anno e molti di questi arrivano proprio da Paesi come la Cina, ma anche la Russia e l'Ucraina. Questa crisi globale ci sta mettendo davvero in difficoltà. È una situazione di forte rischio paese che ha una dipendenza eccessiva dalle materie prime critiche che arrivano da Paesi dotati di risorse minerarie. Ecco che allora diventa un imperativo categorico darsi da fare e aumentare la capacità di riciclare i nostri rifiuti tecnologici che contengono molte di quelle materie prime che servono ad alimentare le nostre industrie di punta, l'aerospaziale, la difesa, le rinnovabili, l'elettronica, l'automotive».
Oltre al fatto che riciclare più materiali permetterebbe di risparmiare un importante livello di emissioni climalteranti, in una Italia che consuma ogni anno circa 500 milioni di tonnellate di materie prime, di cui oltre la metà arrivano dall’estero, un investimento sull'economia circolare legata ai Raee dovrebbe dunque essere una mossa strategica e doverosa per il futuro.
Il riciclo creativo della carta è sempre una buona idea?
Un materiale che davvero non manca mai in ogni casa è la carta, che spesso sprechiamo senza neanche pensarci.
Appallottolare un foglio o buttare via il cartone della pizza sono gesti consueti ma a cui dovremmo dare più attenzione attraverso il riciclo.
La carta è un materiale riciclabile poiché la cellulosa che contiene può essere sottoposta a ripetuti cicli di lavorazione.
La carta recuperata può essere trattata e riutilizzata come materia secondaria per la produzione di nuova carta (il 80% viene trasformato così).
Oltre al riciclo chiamiamolo “urbano” c’è anche un altro che comporta più fantasia ed è il riciclo creativo. Qui non si butta via niente ma si riutilizza con opere anche di bricolage domestico ispirato al riutilizzo degli oggetti che non servono. Le possibilità sono davvero tante. Scopriamole insieme.
Perché riciclare la carta
Secondo alcuni dati il 30% dei rifiuti prodotti in Italia è composto da carta e cartone.
Capire l’importanza della differenziata, in particolare il corretto recupero della carta, risulta quindi necessario per un buon smaltimento dei rifiuti.
La raccolta differenziata è fondamentale oggi per assicurare un futuro al nostro pianeta.
Tra i tanti materiali che si possono riciclare, la carta è uno dei più importanti.
Il perché riciclare la carta è legato a molti fattori: aiuta il nostro pianeta a consumare meno risorse boschive e idriche, permettendo così la conservazione della natura, soprattutto in un Paese che, come il nostro, risulta molto fragile da questo punto di vista.
Mantenere dei polmoni verdi come i boschi significa infatti migliore qualità dell’aria e soprattutto prevenzione contro le catastrofi di tipo alluvionale.
Importante far capire alle aziende, ma anche ai singoli cittadini, quanto è importante valorizzare il mercato di prodotti realizzati con il riciclo della carta.
Un altro motivo del perché riciclare la carta sta nel fatto che questo materiale ha un ciclo di riciclo pressoché infinito.
Guardando come viene effettuato il recupero della carta, vediamo che oltre il 60% di quest’ultima viene riutilizzata nel processo di riciclaggio, un’altra parte viene bruciata per produrre energia e solo una piccola parte finisce nella discarica. I prodotti che possono essere riciclati sono molti dai quotidiani, quaderni di scuola, libri, sacchetti di carta come quelli del pane a esempio, scatole e contenitori di bevande.
Il riciclo creativo della carta
Ci sono altri modi anche per riutilizzare questi oggetti e dargli una nuova vita, uno di questi è il riciclo creativo della carta.
Ad esempio, la carta può essere fatta a pezzi per diventare materiale pacciamante e proteggere le radici delle piante in vaso, oppure per proteggere i bicchieri di vetro nelle spedizioni. Il cartone può essere ritagliato per creare stampini per dolci e i fogli di carta di ogni genere possono essere ritagliati per realizzare degli stancil decorativi e se ridotti in fiocchi e posti in blocchi a formare un doppio strato, possono essere usati anche come utili pannelli isolanti.
Il riciclo creativo della carta intrecciata, poi aiuta anche a costruire dei cestini utilizzando carta sottile senza patinatura.
Se volete cominciare un azione di riciclo creativo di carta in casa vostra dovrete munirvi di alcuni oggetti che vi serviranno nei lavori. Possiamo andare nel nostro armadio, nella parte femminile e rimediare dei semplici collant, un paio di vecchie calze da donna che serviranno come setaccio per la carta, poi una gruccia metallica che vi servirà per creare un telaio per il setaccio. In mancanza della gruccia potete usare del semplice ferro filato. Andate in cucina poi e controllate che il vostro frullatore sia funzionante, vi servirà per sminuzzare ulteriormente la carta e una bacinella che servirà per accogliere la carta da riciclare. Nello studio procuratevi delle forbici colla vinilica, servirà a dare vita alla nuova carta riciclata fatta in casa.
Riciclo creativo carta di giornale
La prima cosa che si può fare con il riciclo creativo della carta di giornale è molto semplice, creare una carta per ricoprire le scatole e volendo anche una originale carta da regalo. Per rivestire le scatole che possono essere delle scarpe, degli armadi o altro basta davvero poco, molta creatività, giornali, scatole, colla vinilica, forbici, un pennello per dare il colore che preferite.
Le pagine dei quotidiani possono anche mantenere in ordine il guardaroba. Si possono avvolgere i maglioni di lana prima di conservarli in modo da evitare le tarme o inserirli in scarpe o borse per far mantenere la forma nei periodi in cui non le adoperate.
La carta da giornale è anche un ottimo isolante termico, potete rivestire la cuccia o la cesta dei vostri amici animali in modo da essere sicuri che stiano sempre al caldo. Con la carta di giornale si può pulire l’acciaio perché non graffia o danneggia le superfici, basterà bagnare il foglio con una miscela di acqua e aceto e passarlo direttamente sulla superficie da pulire.
Tutte le casalinghe sanno poi che i quotidiani sono perfetti per asciugare i vetri ma anche gli specchi senza lasciar aloni.
Parlando sempre dalla parte delle casalinghe i fogli di giornale sono perfetti per avvolgere i vasetti delle conserve fatte in casa e chiuderli poi intorno al tappo con una corda, per ottenere un look vintage molto originale.
Il riciclo creativo della carta di giornale serve molto in cucina ed è un trucco anche per combattere i cattivi odori che possono formarsi nel frigorifero. Basta ricoprire l’interno del cassetto della frutta con il giornale, in modo che assorba gli odori. Oppure potete avvolgerci la frutta ancora troppo matura in frigo, dopo qualche giorno non lo sarà più.
Riciclare la carta con bambini
Riciclare la carta con bambini è una delle attività più creative e divertenti per insegnare il riutilizzo degli oggetti e dei materiali. I lavoretti con carta di giornale per bambini e adulti son molti, basta avere un po’ di creatività, pazienza e abilità.
Con questi ingredienti si possono creare stupende rose rosse di carta di giornale, o bellissimi e originali fiori di carta, si può tagliare la carta a forma di petali e incollarli poi su un filo metallico, precedentemente rivestito con carta crespa verde. Per le vostre bambine poi potrete creare delle collane o bracciali unici fatti con la carta. Per creare ogni perla di carta, arrotolare su sé stessa una piccola striscia di carta, per poi fermare l’estremità con la colla vinilica.
Una volta fatto il numero di palline che preferite, basta infilare in filo di nylon e una volta scelta la lunghezza, annodare i due estremi del fino insieme.
Se usate un piccolo elastico, la vostra creazione farà anche da ferma capelli. Interessante è anche il riciclo della carta a scuola, un ottimo modo per cominciare un’educazione alla tutela dell’ambiente già in tenerissima età.
Quanto cibo viene sprecato In Italia?
Italiani buongustai (e questo si sapeva), ma anche attenti alla sostenibilità del cibo e in particolare agli sprechi. È ciò che emerge dal Food Sustainability Index 2021, che mette l’Italia sul podio mondiale nella lotta allo spreco alimentare. Il report, presentato lo scorso 25 gennaio, è frutto della collaborazione nata nel 2016 tra la Fondazione Barilla e l’Economist Impact. Giunto alla sua quarta edizione, l’indice è arrivato ad analizzare il nesso cibo-salute-ambiente in ben 78 Paesi, che corrispondono a oltre il 92% della popolazione mondiale e del Pil globale.
Un'analisi in 78 Paesi
La sostenibilità delle filiere alimentari è al centro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, così come degli impegni per l’azione climatica, la mitigazione e l’adattamento. “Il Covid-19 – si legge nell’introduzione del report – ha inoltre portato alla luce l’importanza di prevenire le epidemie zoonotiche abbracciando il cosiddetto approccio One Health e rafforzando la resilienza dei sistemi di approvvigionamento alimentare”. Insomma, avere dei dati e delle indicazioni su come si sta muovendo il mondo per rendere più sostenibili e più resilienti i suoi sistemi alimentari è fondamentale. Perciò questa quarta edizione del Food Sustainability Index allarga la sua analisi a 78 Paesi (era partito da 25 nel 2016) che ospitano più del 92% della popolazione del Pianeta, contribuendo per la stessa percentuale al Pil globale.
Siamo ancora indietro sull’agricoltura green
Il sistema cibo è analizzato, secondo 38 indicatori, in 3 aree principali: le sfide nutrizionali, l’agricoltura sostenibile e la lotta allo spreco alimentare. È su quest’ultima che l’Italia si è particolarmente distinta nel 2021, ottenendo performance seconde solo al Canada e guadagnandosi il podio per quanto riguarda le azioni intraprese nella lotta allo spreco alimentare. Nel complesso, la filiera produttiva italiana perde “solo” il 2% del cibo (anche grazie a una maggiore attenzione verso l'economia circolare del comparto agrifood). Mentre si stima che lo spreco alimentare pro capite annuo, a livello domestico, sia di circa 67 Kg, che nella ristorazione ammonti a circa 26 Kg e che nella distribuzione sia di circa 4 Kg pro capite l’anno: il dato più basso registrato tra i 78 Paesi analizzati dall’indice.
“Nella lotta allo spreco alimentare, che a livello globale riguarda un terzo del cibo prodotto, possiamo essere presi come riferimento dal resto del mondo” ha dichiarato Marta Antonelli, Direttrice della Ricerca della Fondazione Barilla. Quanto alle altre 2 aree analizzate, se sui temi nutrizionali l’Italia dà punti a molti nel promuovere una dieta sana e sostenibile, non si può dire lo stesso in ambito di sistemi agricoli, in particolare per quanto riguarda il consumo idrico. Come molti paesi del Mediterraneo, infatti, in Italia la “pressione sulle risorse di acqua di superficie e di falda per la produzione alimentare” è piuttosto alta. Servono politiche per promuovere un’irrigazione sostenibile e in questo settore i margini di miglioramento sono piuttosto ampi.
La situazione nel resto del mondo
Secondo il più recente report dell’Unep, oggi nel mondo si spreca quasi un miliardo di tonnellate di cibo all’anno. Nonostante la gravità del problema, solo il 28% dei Paesi analizzati dal Food Sustainability Index dimostra di avere una strategia dedicata al tema. Le migliori politiche in atto sono quelle di Francia, Italia, Stati Uniti, Germania e Argentina. Anche per quanto riguarda la sostenibilità dei sistemi agricoli c’è ancora molto da fare, soprattutto se si guarda al nesso, fin troppo sottovalutato, tra agricoltura e cambiamento climatico: meno del 50% di tutti i Paesi analizzati ha inserito il clima all’interno delle politiche agricole. In questo campo i Paesi migliori sono Finlandia, Estonia, Austria, Tanzania e Svezia.
Infine, quando si parla di nutrizione e attenzione alla dieta e ai suoi effetti sulla salute e la qualità della vita, i migliori sono Giappone, Svezia, Danimarca, Francia e Cina. “Questa – sottolinea il report - è probabilmente l’area che, più di altri, mette in luce le differenze che ancora caratterizzano i Paesi ad alto e basso reddito: infatti, 19 dei 20 Paesi con i migliori risultati sono Paesi ad alto reddito, in cui le diete sane e sostenibili sono economicamente accessibili alla popolazione. Tuttavia, solo 7 di questi 19 Paesi includono l’aspetto della sostenibilità della dieta nelle linee guida alimentari nazionali”.
“I risultati dell'Indice di sostenibilità alimentare 2021 evidenziano che i Paesi di tutto il mondo hanno ancora molto da fare per affrontare le sfide chiave dei sistemi alimentari”, sottolinea Martin Koehring, Senior Manager dell’Economist Impact. “La nostra ricerca mostra che gli sforzi per affrontare la sostenibilità alimentare si affiancano agli sforzi per affrontare altri obiettivi chiave, sociali ed economici, come lo sviluppo umano, lo sviluppo sostenibile, l'uguaglianza di genere, la spesa sanitaria e il sostegno all'innovazione”.
A cura di Materia Rinnovabile
Come ridare vita a un paio di scarpe grazie al riciclo?
Da scarpa vecchia a scarpa nuova. Ogni anno nel mondo vengono prodotti 24 miliardi di calzature: le usiamo per qualche tempo e poi via, nella maggior parte dei casi - dato che sono composte da tanti e diversi materiali non sempre semplici da riciclare - finiscono direttamente in discarica.
Poca circolarità e poco riciclo per uno dei prodotti più venduti nel mondo dell'abbigliamento: ma che accadrebbe se le scarpe diventassero protagoniste dell'economia circolare e del loro riuso?
Un'azienda italiana, anche grazie a fondi europei Life, sta provando a dare una risposta.
Il calzaturificio Scarpa di Asolo, specializzato in scarpe da trekking e outdoor, ha infatti deciso di provare a gestire diversamente il fine vita dei propri prodotti.
Grazie al progetto Re-Shoes l'azienda si sta impegnando per raccogliere dai consumatori in Italia, Germania e Austria almeno 15.000 paia di scarpe usate, quelle del suo modello più noto (Mojito).
Una volta raccolte, queste calzature saranno avviate a un nuovo processo in cui si prevede di utilizzare tra il 50% e il 70% dei materiali della vecchia scarpa per quella nuova.
Questo riciclo comporterà, secondo l'azienda, "una riduzione rispetto ai processi standard del 52,4% di gas serra, del 50% di sostanze chimiche, del 65% di consumo di acqua, del 54,5% di energia".
Tra i sistemi per il recupero delle calzature ci sarà "la dissoluzione selettiva della pelle per idrolisi e il liquido ottenuto verrà poi utilizzato per conciare della nuova pelle senza l’aggiunta di sostanze chimiche". Inoltre, fanno sapere da Asolo, "la produzione di pelle riciclata si baserà sul processo Evolo che attualmente permette di raggiungere fino al 20% di contenuto riciclato a livello industriale, con la concreta possibilità di aumentare la quantità fino al 50%".
Una delle parti recuperabili grazie al nuovo processo saranno poi anche gli scarti di gomma, che attualmente sono destinati ai termovalorizzatori.
L'intero progetto Re-Shoes, di 2.6 milioni di euro e reso possibile grazie a un finanziamento del programma Life Ue, si svilupperà in poco meno di quattro anni con l'obiettivo appunto di mettere in commercio un nuovo modello di calzatura dell'azienda ma realizzato grazie a raccolta e riciclo, diminuendo così lo smaltimento e l'uso di materie prime vergini.
«La quantità di rifiuti generati dai prodotti usati è una delle principali sfide dell’industria calzaturiera: le scarpe, infatti, sono complesse da riciclare, perché sono composte da un mix di materiali diversi molto difficili da separare. Con questo ambizioso progetto prendiamo un impegno, quello di dare un contributo per invertire la rotta. Un impegno che si traduce in una continua sperimentazione di materiali totalmente riciclabili ed ecologici senza intaccare performance e durabilità dei prodotti», chiosa Sandro Parisotto, presidente di Scarpa.
Anche la moda deve essere circolare?
L’industria della moda è un settore dinamico, globale e in crescita, complice la inarrestabile diffusione del fast fashion. Ma tutti questi prodotti, una volta gettati via perché non più utilizzati, impattano sull’ambiente: meno dell’1% del materiale tessile viene riciclato. Servono quindi nuovi modelli di business per una moda circolare (come il second hand o il noleggio di abiti) ma, più di tutto, serve un cambiamento radicale nel sistema di riciclo.
Cobat, la più grande piattaforma di servizi per l'economia circolare in Italia, controllata dal gruppo Innovatec, leader italiano nel settore della Clean Technology, ha deciso di dare il suo contributo. Grazie al suo impegno quotidiano, Cobat garantisce sia un servizio di gestione dei prodotti al fine vita che la consulenza e la formazione per le imprese che vogliono puntare sullo sviluppo sostenibile.
Tenendo a mente questi principi, è nato Cobat Tessile, il nuovo consorzio italiano per la raccolta, il trattamento e l’avvio al riciclo dei prodotti tessili non più utilizzabili. L’obiettivo è aiutare le aziende aderenti a praticare un’attività di sviluppo sostenibile con benefici per l’ambiente e per il sistema economico nazionale, riducendo gli sprechi e producendo nuove materie prime. Tutto seguendo i valori di sostenibilità, trasparenza e efficienza.
Tra le proposte messe in campo, il consorzio offre servizi integrati e personalizzati riguardo la gestione ambientale, con particolare attenzione al controllo del fine vita dei prodotti tessili e al loro riuso. Inoltre, punta alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie per il corretto recupero delle materie prime da immettere nel mercato, al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici. Un punto importantissimo se consideriamo che nel 2015 l’industria tessile europea ha utilizzato 79 miliardi di metri cubi di acqua: si stima che per fabbricare una sola maglia di cotone occorrano 2.700 litri di acqua dolce (un volume pari a quanto una persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo).
«La costituzione di Cobat Tessile risponde alle nuove sfide che la società si pone - ha spiegato il presidente Maurizio Sarti - L’obiettivo è diffondere l’importanza della condivisione della conoscenza a tutti gli attori della filiera, per offrire a tutte le imprese italiane, interessate al fine vita dei prodotti tessili, servizi integrati sempre più competitivi e sostenibili a livello ambientale, economico e sociale».
Il futuro della moda deve essere green, e lo sarà anche grazie all’approvazione da parte della Commissione Europea della Strategia per il Tessile Sostenibile e Circolare. Un documento necessario se consideriamo che la produzione tessile globale è quasi raddoppiata tra il 2000 e il 2015, mentre si ipotizza che il consumo di abbigliamento e calzature aumenterà del 63% entro il 2030.
«Nell'Ue il consumo dei prodotti tessili, la maggior parte dei quali importati, rappresenta oggi in media il quarto maggiore elemento negativo che impatta sull'ambiente e sui cambiamenti climatici», riporta il documento. Per avere qualche dato alla mano, si stima che ogni anno in Europa vengano scartate circa 5,8 milioni di tonnellate di tessuti (più o meno 11 kg per persona).
Il problema è che molto spesso nella produzione tessile non ci si focalizza sul riuso, sulla riparazione e sul riciclo dei prodotti, incrementando così il commercio del fast fashion: perché, se i vestiti devono durare poco, che almeno abbiano costi bassi.
Con questa nuova Strategia si ambisce a realizzare entro il 2030 prodotti tessili per il mercato europeo utilizzando prevalentemente fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e realizzati nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente. Ma come?
Innanzitutto con l’introduzione di requisiti obbligatori per una progettazione ecocompatibile, con un focus sulla durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità. Inoltre, attivandosi per fermare la distruzione dei capi invenduti o restituiti: la Commissione vuole infatti imporre alle aziende un obbligo di trasparenza relativamente al numero di prodotti scartati e distrutti, e alla loro preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o l'incenerimento.
Ma, più di tutto, serve creare un sistema per la raccolta e il riciclo dei prodotti tessili, così da rendere i produttori responsabili per i rifiuti che producono. A tal proposito in Italia è stato istituito l’obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal primo gennaio 2022 (in generale, per gli Stati Membri europei l’obbligo è da imporre entro il 2025). Ma il nostro Paese sembra non essere ancora pronto: mancano infatti direttive e linee guida precise da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
La moda green di Gucci: che cos’è il Circular Hub per il lusso circolare?
Non più solo l’esperimento di qualche collezione, ma un vero e proprio progetto per “lanciare l’industria del futuro”. Gucci, con il supporto del gruppo francese Kering, aprirà in Italia il primo hub per il lusso circolare. L'obiettivo sarà trasformare l’intera filiera dell’alta moda per accelerare la sua transizione verso la sostenibilità.
Si punterà al riutilizzo delle materie prime di scarto, anche per il packaging, e alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi di realizzazione e trasporto dei capi, in accordo sia con gli obiettivi del Pnrr che con le regolamentazioni europee per la riduzione delle emissioni al 2030.
Il primo Circular Hub sarà avviato in Toscana, negli stabilimenti ArtLab di Scandicci per la ricerca, a Firenze, e di Campi Bisenzio per la logistica. Una piattaforma di open innovation permetterà di ideare e condividere soluzioni circolari nella rete con oltre 700 fornitori diretti, 3.500 subfornitori di Gucci in Italia, coinvolgendo, in una seconda fase, anche gli altri clienti di Kering. L’ambizione è infatti quella di lanciare un nuovo modello produttivo, all’insegna della sostenibilità
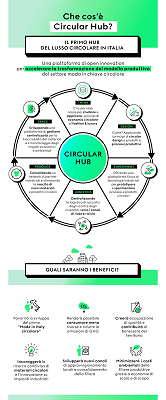
Il progetto è sostenuto dagli Accordi per l’Innovazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le sue attività si concentreranno principalmente in 5 aree.
1. Ricerca e sviluppo: gli esperti di Kering Material Innovation Lab (MIL) di Milano collaboreranno con i tecnici di prodotto per abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori dei centri d'avanguardia di artigianato industriale e di sperimentazione di Gucci di Scandicci e di Novara, in Piemonte. Parteciperanno anche altri partner e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che fornirà un supporto scientifico.
L’obiettivo sarà studiare tecnologie innovative e digitali, per migliorare la qualità dei prodotti, con una maggiore durabilità, riparabilità e riciclabilità, nell’ottica dell’economia circolare. Si tenterà inoltre di ottimizzare i processi di trasformazione e di lavorazione delle materie prime per ridurre l’impatto del settore moda sull’ambiente.
2. Logistica: Gucci e Kering cercheranno di incentivare le aziende delle filiere a tracciare i prodotti e restituire gli scarti all’azienda, per inserirli nei processi recupero e rigenerazione.
3. Partnership industriali: oltre lo studio dei ricercatori, ci sarà anche il miglioramento tecnologico degli impianti di produzione e riciclo dei materiali. Saranno sviluppati nuovi canali di approvvigionamento locali e di consolidamento della filiera per favorire lo sviluppo del primo Made in Italy circolare.
4. Condivisione del valore: i brevetti, le tecniche e il know-how del nuovo Circular Hub di Gucci saranno messi successivamente a disposizione di altre aziende. Il principio di open innovation prevede infatti di coinvolgere un numero sempre maggiore di fornitori e partner industriali.
5. Esg: il progetto punta a trasformare le performance di impatto ambientale del Gruppo Kering e di Gucci, per un minor consumo di risorse, per la riduzione delle emissioni di gas serra - fino al 60% grazie al riutilizzo degli scarti produttivi solo della pelletteria - e la creazione di occupazione di qualità.
«L’industria della moda ha oggi la responsabilità di stimolare azioni concrete e trovare soluzioni in grado di accelerare il cambiamento, ripensando anche alle modalità produttive e all’impiego delle risorse. La creazione del Circular Hub è un importante traguardo e nasce proprio per perseguire quest’obiettivo. È motivo di orgoglio per me che l’Hub nasca in Italia, sede di alcuni dei più importanti e rinomati poli produttivi e del know-how del Gruppo - ha commentato Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability and Institutional Affairs Officer di Kering - La collaborazione con Gucci ha dato vita al nuovo Circular Hub e ciò è testimonianza non solo di una forte comunità di obiettivi all’interno del Gruppo ma anche di un esempio ambizioso che, nella logica dell’open source, vuole essere un invito aperto ad altre realtà a unirsi in questo percorso».
«La circolarità ci offre una visione che coinvolge l'intero ciclo produttivo: è una grande sfida per rendere ancora più forte e competitivo il Made in Italy - ha affermato Antonella Centra, Executive Vice President, General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci - Oggi con Circular Hub abbiamo la responsabilità e soprattutto l'opportunità di creare la strada per l'industria del lusso del futuro. Condividendo i medesimi obiettivi e mettendo a fattore comune risorse, know-how e sinergie, la piattaforma rappresenta uno strumento concreto per abilitare l’intera catena di fornitura e specialmente le piccole e medie imprese, cuore pulsante del nostro Paese, rendendole parte attiva del percorso di innovazione costante che rende unico il saper fare italiano nel mondo».
Il progetto è complementare alle attività del Consorzio Re.Crea - coordinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per gestire i rifiuti e promuovere l’innovazione del riciclo - del quale Gucci è socio promotore. La Maison è inoltre partner strategico della Ellen MacArthur Foundation, per accelerare il percorso virtuoso verso la circolarità.

