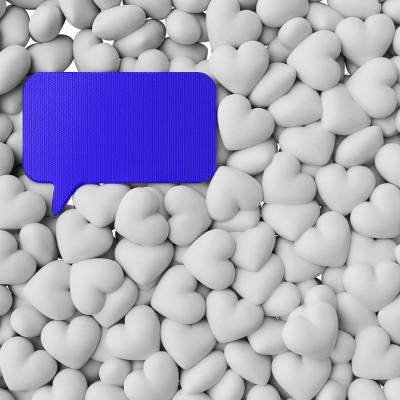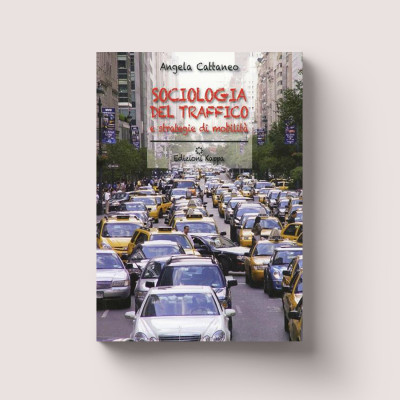Io phubbo, tu phubbi, egli phubba

Il nostro dizionario si rinnova su base quotidiana per la necessità di integrare fenomeni veloci e improvvisi, che spesso lo sono al punto da lasciarci senza parole. Così mi immagino la frustrazione accumulata da chi per mesi, se non anni, ha maturato un fastidio derivato dall’abitudine di parenti, familiari e amici di ignorare le persone per il telefono. Una tensione psicologica alimentata dalla difficoltà nell’esprimere quella mancanza, soprattutto visto che, a essere onesti, molte delle persone che subiscono questa indifferenza digitale sono i primi a metterla in campo a loro volta.
Oggi, però, sono armata di una nuova parola che dà un nome e un’entità al problema. Ignorare le persone a favore del cellulare è un atto definito phubbing e, sebbene il termine sia in circolo da un po’, i suoi effetti sono abbastanza sconosciuti. La ricerca pubblicata da Psychological Reports e condotta in Turchia ha scoperto che le persone che si ritrovano a essere ignorate per lo smartphone da coloro con cui intrattengono un rapporto amoroso, sono meno soddisfatti dalla relazione in sé e la considerano di scarsa qualità.
Verrebbe da dire che qualsiasi persona ignorata sviluppi una normale reazione emotiva di insoddisfazione, se non di rabbia. Probabilmente capita anche a chi viene ignorato per la televisione o per altri dispositivi che consentono l’intrattenimento individuale. Ciò che rende preoccupante sia il risultato dello studio che l’atto in sé, è la versatilità del phubbing.
Lo smartphone, infatti, non ha bisogno di uno spazio specifico o di un contesto per essere usato e la dipendenza dallo schermo non ha limiti. L’individuo che ignora gli altri con lo sguardo incollato sul dispositivo rischia di farlo con amiche e amici, parenti, partner, colleghe e colleghi di lavoro, compagni di squadra e persino con sé stesso. Anzi, il più delle volte il telefono diventa la soluzione immediata al senso di vuoto generato dal silenzio della solitudine. La noia è stata interamente assorbita dalla possibilità di riempire il tempo con “qualcosa”, la cui qualità o il cui contenuto non è rilevante: ciò che conta è la sua presenza.
Così, il tedio e la lentezza svaniscono dalle nostre vite, che iniziano a smettere di essere vissute e sono semplicemente trascorse in attesa del prossimo stimolo vincente. Un video con un attacco particolarmente carino, un’immagine, un’informazione virale o il semplice atto di scrollare un’offerta virtualmente infinita.
I social media sono diventati l’equivalente ipercontemporaneo dei centri commerciali. Si entra inizialmente mossi da uno scopo preciso, un profilo da guardare, una foto da recuperare o condividere, un augurio da esprimere, ma si finisce a osservare tutte le “vetrine” in attesa di qualcosa che catturi davvero l’interesse. Un prodotto riesce a fare breccia (con fatica visto il crescente sovraccarico di stimoli e proposte) e cattura l’utente, spingendolo a soffermarsi, riflettere e, se il prodotto è veramente di interesse, a ricondividerlo, lasciare un like o un commento. Come in un negozio, con la differenza che l’azione che conferma l’apprezzamento della merce non è necessariamente positiva. L’equivalente di un sacchetto contenente l’oggetto è la reazione, quale che sia.
Una risata e una smorfia disgustata hanno lo stesso valore: è infatti la loro presenza, che l’algoritmo percepisce in termini di secondi impiegati nella visione (magari ripetuta) di un contenuto. Queste reazioni, per quanto veloci, lasciano traccia sul noi esterno; sul viso chino sullo smartphone ne appare il segno e chi si trova nella stanza in “nostra compagnia” può leggerlo, ma non per questo prendervi parte. Anzi, rischia solo di sentirsi ulteriormente tagliato fuori.
Nell’allontanare gli affetti scaviamo fossati profondi tra noi e il resto del mondo, finendo per sposare un isolamento digitale gremito di emozioni virtuali. Lo stress del cellulare però non conosce limiti, soprattutto perché il phubbing non viaggia mai da solo.
Molte persone sviluppano una relazione morbosa con il proprio smartphone: a lui va il primo pensiero da svegli ed è con la sua luce fredda stretta tra le dita che ci si addormenta. Il fenomeno della dipendenza da telefono è altamente diffuso (secondo il rapporto Eures parliamo di un’incidenza pari all’82% dei giovani) e tollerato. Infatti, avere il cellulare sempre a portata di mano è considerato normale.
Non stupisce perciò che la dipendenza sia accompagnata dalla nomofobia, ovvero dalla paura incontrollata di trovarsi sconnessi o senza smartphone. Una paura che sfocia agilmente in problemi di ansia, soprattutto quando si ibrida con altre preoccupazioni come la FOMO, la paura di perdersi qualcosa e di essere tagliati fuori.
Il comportamento di compensazione, quello che aiuta a gestire l’ansia ma che di fatto rimane disfunzionale in quanto la alimenta, è l’intensificazione del legame. Il telefono viene accudito, messo in carica, possibilmente accanto al letto, viene interpellato in qualsiasi momento, mentre si mangia, mentre si guarda un film o si sta passando quel tempo destinato alle compagne o ai compagni di vita.
Le dita sviluppano calli, le batterie degli smartphone ribollono e le applicazioni offrono aggiornamenti sempre più pesanti, così tanto invadenti da dichiarare la necessità di sostituire il telefono prima ancora del tempo. Nel mentre, siamo immobili e connessi, tacitamente sovraeccitati da un oggetto che ci connette a tutto, tranne che a chi sta nella stanza è insieme a noi.
Di fatto, siamo disposti a ignorare tutti e tutto, ma non gli schermi. Quelli mai. Sono diventati la nostra relazione preferita, ricca di stimoli passivi, adattabili e in grado di rinforzare sempre ciò che pensiamo, nel bene e nel male. Verrebbe da paragonarli allo specchio d’acqua in cui Narciso si è perso, ma non sarebbe esatto: Narciso si è perso nell’immagine di sé, mentre noi stiamo andando oltre. Ci stiamo smarrendo nell’idea di come vorremmo essere percepiti e nell’abisso di un iperpresenza digitale che è talmente ricca da essere di fatto vuota.
Gli smartphone non ci mostrano il lato migliore di noi stessi, ma ci educano a credere di poterlo generare con un contenuto, con un’interazione. Esistiamo nell’idea di essere visualizzati, non più in quella di essere percepiti; ci illudiamo di poter moltiplicare le interazioni digitali, recidendo quelle analogiche e complesse e ci crogioliamo nel rinforzo positivo con cui gli schermi ci avvolgono, sedando la consapevolezza della solitudine crescente che ci circonda. Finiamo con il phubbare anche noi stessi.