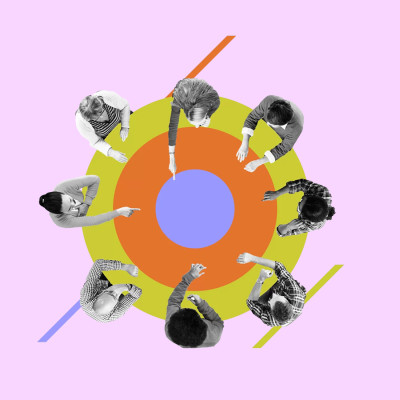“Sorella, io ti credo”: la violenza di genere e la vittimizzazione secondaria

Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla #unite #rompiamoilsilenzio
“È questo che indossava quando è successo?”
“Sì, ma…”
“Lei sembra provocatoriamente benestante”.
“Guardi, non vedo cosa possa entrarci il mio modo di vestire con…”
“È un po’ come un invito a farlo, no? Come se lo stesse pubblicizzando”.
“Avevi bevuto?”
“Sì, perché in tal caso avresti potuto inviare dei segnali confusi. Illudere qualcuno con un bel vestito e un bel telefono e poi all’ultimo minuto dire ‘non voglio essere derubato’”.
“Mi ha puntato un coltello alla gola e ha preteso i miei averi!”
“E lei glieli ha semplicemente dati?”
“Ha gridato?”
“Come può qualcuno sapere che lei non sta gradendo consegnare i suoi averi se non ha reso chiare le sue intenzioni?”
“Aveva un coltello! Ero molto spaventato”.
“E noi siamo molto comprensive. Ma temo che dovrà accettare alcune responsabilità”.
Era il 2017 e un video ci ricordava quanto potesse apparire ridicolo questo interrogatorio in caso di una denuncia per furto. Eppure, non c’era niente da ridere. Non c’è ancora niente da ridere. Perché sono passati 7 anni ma quel dialogo è fin troppo realistico nei casi di violenza di genere. Una violenza che non finisce quando il colpevole smette, ma che continua a colpire donne e ragazze anche nei luoghi e negli spazi che dovrebbero tutelarle.
Nei commissariati e nelle caserme, nelle aule di tribunale, sui giornali e in tv, le donne che denunciano o condividono le loro storie di violenza vengono trasformate da vittime (un termine che, ricordiamolo, non serve a definirle nella loro interezza di esseri umani ma a indicare una persona che ha subito un reato e merita giustizia) a indagate. Si chiede loro di rendere conto delle proprie azioni (o della mancanza di azioni), dei loro comportamenti, del loro abbigliamento, del loro rapporto con il proprio corpo e del loro modo di rapportarsi agli altri. Si chiede loro di dimostrare, ogni oltre ragionevole dubbio, di non essersela cercata, invece di indagare sulle accuse.
«Ma nessuno di noi avvocati - e qui parlo come avvocato - si sognerebbe d’impostare una difesa per rapina così come s’imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali sicuri da difendere, ebbene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori “Vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere un po’ è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!” […] perché se invece che quattro oggetti d’oro, l’oggetto del reato è una donna in carne e ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un’imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale».
Tina Lagostena Bassi ha pronunciato queste parole nel 1978, durante l’arringa di quello che è diventato celebre l’anno successivo come Processo per stupro. Cos’è cambiato da allora?
Non si mette in dubbio la storia di chi denuncia un furto. Che non significa emettere un verdetto di colpevolezza sulla base delle sue parole, ma partire dal presupposto che la storia che sta raccontando possa essere vera, invece che dal contrario. Un lusso che alle vittime di violenza non è quasi mai riservato. A loro si chiede di rivivere i momenti drammatici, ancora e ancora, con il solo scopo di spostare la responsabilità da chi quella violenza ha commesso a chi l’ha subita. Si chiede loro di giustificarsi e mostrare non tanto (o non solo) che quella violenza ci sia effettivamente stata ma soprattutto di essere davvero meritevoli dello status di “vittima”.
Questo fenomeno ha un nome: vittimizzazione secondaria. Che è quello che subiscono le donne quando sono forzate ad attraversare di nuovo la violenza o ne subiscono forme diverse (da quella istituzionale a quella mediatica) soprattutto nel momento in cui rendono pubblica la loro esperienza, denunciandola. Colpevolizzazione, minimizzazione, giustificazione: questo è il trattamento riservato a chi osa parlare. Non solo dalle forze dell’ordine, avvocati e magistrati dalle agenzie che dovrebbero tutelarle, ma anche dai media.
«Sminuire la portata della violenza, cercare la causa della violenza, di cui le donne sono vittime, in tratti di personalità, nel suo comportamento e/o nella sua psicologia, in particolari comportamenti delle donne o caratteristiche morali di queste ultime»: così Sabrina Frasca, responsabile area sviluppo dell’associazione Differenza Donna, ha descritto la vittimizzazione secondaria.
“Cosa indossavi?”, “Eri ubriaca?”, “Hai gridato?”, “Perché hai aspettato così tanto per denunciare?”, “Se ci sono i jeans non può esserci stupro”, “Cinque secondi sono pochi perché sia una molestia”, “Se la molestia è durata più di 10 secondi è perché non ti sei opposta”; “Ubriache fradice al party in spiaggia, due 15enni violentate dall’amichetto”, “se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.
“Perché non ha usato i denti?”, “Perché non ha urlato?”, “Perché non te ne sei andata prima?”, “Perché sei tornata con lui?”, “Uccise per un ‘no’”, “L’errore di lei? Ricalca quello commesso da tante altre donne uccise per mano del marito: l’amore ingenuo, il cedere alla richiesta di rinunciare al proprio lavoro, la vergogna e il terrore di ribellarsi”. “«Lei lo lascia, lui la violenta e manda le foto agli amici. Lei lo aveva lasciato e lui ha iniziato a perseguitarla”, “Lei lo lascia e lui la riempie di chiamate e messaggi”.
Questi sono solo alcuni dell’infinito campionario di esempi tratti da interrogatori, sentenze, articoli di giornale. Molti sono stati analizzati nel progetto Step dell’Università degli Studi della Tuscia e Differenza Donna per “indagare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario e sulla stampa”.
A livello psicologico questo può generare un processo di amplificazione a causa del quale la donna sarà probabilmente ancora più convinta di “meritare” quello che sta subendo e proverà un senso di “ineluttabilità” della violenza, nella convinzione di non avere possibilità di fuoriuscita, oltre a un’amplificazione dei sentimenti (già presenti) di colpa, vergogna, impotenza. Questo, come già denunciava Lagostena Bassi ormai 45 anni fa, può avere un effetto anche sulla possibilità delle donne di denunciare la violenza: secondo la Corte di Cassazione, infatti, la vittimizzazione secondaria “è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa”.
“La Corte ha ritenuto che il linguaggio e le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello trasmettessero pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e potessero costituire un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente. La Corte era convinta che i procedimenti penali e le sanzioni giocassero un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso commenti colpevolizzanti e giudicanti capaci di scoraggiare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario”. Con queste parole la Corte Europea dei Diritti Umani ha sanzionato l’Italia già nel maggio del 2021. Ma le cose, ce lo ricordano fin troppo bene i casi di cronaca, non sono cambiate. Non abbastanza.
La vittimizzazione secondaria, però, colpisce in maniera particolarmente dura le donne che hanno figli, in particolare quelle che intraprendono un percorso legale, soprattutto a causa della mancanza di specifica formazione degli attori del processo (avvocati, pubblici ministeri, giudici, consulenti tecnici, ausiliari, addetti al servizio socio assistenziale).
“La sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne nell’ambito dei giudizi civili e minorili ha avuto come conseguenza il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente”, si legge nella relazione La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato.
Quello dell’affidamento diventa spesso un campo di una battaglia di cui a subire i colpi sono donne e bambini. Il mancato riconoscimento delle dinamiche della violenza di genere porta a ridurre i casi di violenza a semplice conflittualità tra ex riottosi, a considerare genitori affidabili uomini violenti, a insistere sulla bigenitorialità anche in situazioni estremamente problematiche. Eppure, continua la relazione, “uno stesso ordinamento non può tollerare che da una parte l’autore di violenze venga indagato e condannato per le condotte commesse e dall’altra venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità”.