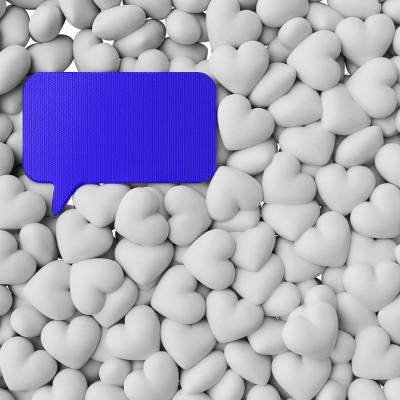La mediazione interculturale può salvare vite

«Credo di essere bravo nel mio lavoro, di riuscire a interpretare bene il ruolo di mediatore interculturale e questo mio ultimo intervento ne è forse la dimostrazione maggiore».
Ha ragione Maurice Eriaremhien, mediatore in forza al Cies, la Onlus che da oltre 40 anni è in prima linea sui fronti dell’inclusione, della cooperazione e del sostegno alla fascia adolescenziale.
La sua speciale esperienza di mediazione (di qualche settimana fa), infatti, ha tutte le caratteristiche di un’opera fuori dall’ordinario e si presenta come nuova frontiera di questo decisivo strumento di pace sociale che è la mediazione interculturale, sublimandolo e dimostrandone le infinte potenzialità.
Andiamo per gradi. A novembre il Cies è stato contattato da un’equipe medico-chirurgica dell’ospedale di Tor Vergata, Roma, che richiedeva la presenza di un mediatore in sala operatoria per un delicatissimo intervento a un giovane nigeriano. Non bastava, però, un professionista della mediazione connazionale: c’era bisogno di qualcuno proveniente dalla stessa zona del paziente, in grado di parlare la sua stessa lingua locale.
Il ragazzo, infatti, affetto da un tumore al cervello, avrebbe dovuto essere operato da sveglio e continuare a parlare nel suo idioma con il mediatore, oltre che essere monitorato per evitare che si danneggiasse l’area del linguaggio e il paziente perdesse l’uso della parola. I medici e gli infermieri, quindi, ricercavano qualcuno che stesse accanto al paziente durante l’operazione e continuasse a parlare verificando lo stato delle sue risposte ai vari input.
L’inglese, l’italiano o qualsiasi altra lingua non sarebbero stati sufficienti: bisognava comunicare nella parlata originaria del giovane, quella che aveva appreso fin dai primi giorni di vita. Un lavoro complessissimo: una cooperazione paziente-mediatore-equipe che esalta l’eccellenza medica italiana, attenta a fattori umani del paziente non solo fisico-sanitari.
Per documentare questo esperimento di professionalità e umanità (se non primo certamente unico nel suo genere) e farsene raccontare direttamente dal protagonista il senso, le emozioni, i risultati, La Svolta ha parlato con Maurice Eriaremhien.
«Quando ho conosciuto il paziente, un ragazzo che veniva proprio dalla mia città, mi sono reso conto subito che aveva bisogno di essere sostenuto a livello psicologico, era molto spaventato e qui in Italia non ha parenti. Doveva essere operato perché, dopo una serie di svenimenti improvvisi, aveva fatto accertamenti che evidenziarono un tumore. Bisognava intervenire al più presto».
Come ha reagito alla proposta di partecipare a un’operazione così delicata, diventando uno dei protagonisti principali?
In realtà all’inizio ho rifiutato. Non sono mai entrato in una sala operatoria e, soprattutto, avrei dovuto assistere dal vivo a un’ operazione alla testa. I medici mi dicevano: “Tranquillo, ci siamo noi, ti aiutiamo in tutto”, ma poi aggiungevano “devi essere molto attento perché se sbagli qualcosa tu, sbagliamo anche noi”. Insomma una responsabilità enorme, l’equipe medica doveva intervenire a seconda delle risposte che il paziente dava e bisognava stimolarlo utilizzando la lingua madre perché erano interessati i centri nevralgici del linguaggio. “Tu – mi spiegarono - devi comunicare e dirci se lui sta rispondendo bene, se non risponde a tono, allora dobbiamo fermarci”.
Insomma, l’intera operazione dipendeva da me, se sbagliavo qualcosa, loro andavano a toccare parti che non andavano toccate. Psicologicamente non ero pronto, per due notti non ho chiuso occhio. Poi mi sono detto “Se non la faccio io questa cosa, chi la fa?”. C’era anche il rischio che se non si fosse trovato qualcuno all’altezza, il ragazzo avrebbe rifiutato l’operazione per paura e io mi sarei sentito in colpa per tutta la vita. E allora ho detto “Ok, ci sono”. Allora abbiamo dato il via a un percorso di preparazione, uno studio di qualche settimana, dovevo seguire il ragazzo, parlare con lui in inglese, italiano e Ishan. Doveva abbinare parole a immagini e selezionare le parole con cui era totalmente a suo agio.
Come è andato l’intervento?
È andato bene, l’operazione è iniziata alle 8:00 e finito alle 14:30, a volte si sentiva stanco e mi chiedeva di riposare un po’, altre volte non mi rispondeva e io dovevo immediatamente fermare i medici. Ero agitatissimo, ma il ragazzo ha risposto bene e quando si è svegliato abbiamo fatto una video-chiamata al fratello che stava a Londra. Ora si tratta di attendere gli esiti delle varie analisi nella speranza che continui a procedere bene. Prima di Natale sono andato a trovarlo in ospedale, ero molto emozionato, ci siamo abbracciati e commossi, era molto felice di vedermi. Psicologicamente, oltre che umanamente, per me è stato molto importante vedere che stava bene perché ho sempre avuto paura che gli succedesse qualcosa e sebbene sono certo di aver fatto bene il mio lavoro, non avrei saputo come reagire.
I medici erano soddisfatti di questo esperimento?
Moltissimo, loro stessi avevano fiducia che la cosa potesse andare, ma non così bene. È stata una collaborazione tra professionisti. Mi chiedevano di continuo, “Stai bene Maurice? Sicuro?” Perché gli sembrava strano che appena concluso un lavoro così impegnativo io stessi bene. Credo che per la contentezza non sentissi nessuna stanchezza. Non ho bevuto neanche un sorso d’acqua durante l’intervento, ero concentrato, come fossi in trance.
È stato un momento altissimo per la sua carriera…
Sì, il frutto di tanti anni in prima linea. Noi mediatori siamo a contatto con umanità complesse, che vivono grandi difficoltà. Ho lavorato nei Cpr (Centri di Permanenza per il Rimpatrio, luoghi dove vengono concentrati migranti, giudicati spazi di detenzione inumana e sotto i riflettori di vari organismi, ndr), in carcere e a volte mi chiedo: “Ma non c’è qualcosa di più semplice, almeno una volta tanto…” (ride, ndr), però si vede che questa è la mia vita.
La figura del mediatore interculturale non è ancora riconosciuta ufficialmente nel nostro Paese; non è incredibile che un lavoro così altamente professionalizzante quanto fondamentale nella società sia ancora in un limbo lavorativo?
Le sono sincero, proprio prima di quella chiamata stavo cercando di abbandonare questo lavoro, dopo anni di applicazione e impegno, non trovo ancora un impiego stabile. La partecipazione a quell’operazione mi ha rimotivato in un certo senso e mi ha anche fatto capire che ci sono altre possibilità di lavoro all’interno di questa professione. Cercherò di resistere ma come diceva lei è veramente incredibile: alcuni di noi hanno una laurea, tutti abbiamo fatto studi, corsi, lavoriamo sul campo e il nostro ruolo non è stato ancora riconosciuto come professione dallo Stato. Non dimentichiamo che noi lavoriamo al servizio dello Stato, per il Ministero degli Interni, della Salute, negli ospedali, e nessuno ci riconosce come figura ufficiale. Molti non ce la fanno più anche perché, essendo a loro volta immigrati, devono mostrare reddito e lavoro stabile per rinnovare il permesso di soggiorno, e magari cominciano a pensare di trovare lavoro nel campo delle pulizie o come meccanico (per carità lavori degni) per avere un po’ di stabilità.
«La figura del mediatore interculturale è fondamentale per la nostra società – spiega a La Svolta Marta Bernardini, responsabile del settore Mediazione Interculturale della Cies Onlus – nei nostri lunghi anni di esperienza siamo entrati in contatto con tante situazioni complesse e difficili che senza la presenza di gente preparata, motivata non avrebbero speranza di successo. L’intervento del nostro Maurice è molto particolare e speciale nel suo genere, ma ha messo in luce i principi e i valori profondi della professione di mediatore nel suo complesso: l’importanza degli elementi culturali nella comunicazione, di mediare sia i linguaggi verbali e che quelli culturali, la crucialità del codice deontologico nei suoi principi di neutralità, empatia, la necessità di creare un rapporto di fiducia con l’utente, la forza del lavoro di gruppo».
«Le nostre coordinatrici hanno seguito Maurice per tutto il percorso di mediazione e insieme a lui abbiamo vissuto questa storia, aiutandolo a superare le sue comprensibili paure e supportandolo nei momenti più complessi. Senza i tantissimi anni di lavoro e l’esperienza maturati nel campo a contatto con i mediatori che formiamo, questo intervento non sarebbe stato possibile», ha concluso Bernardini.