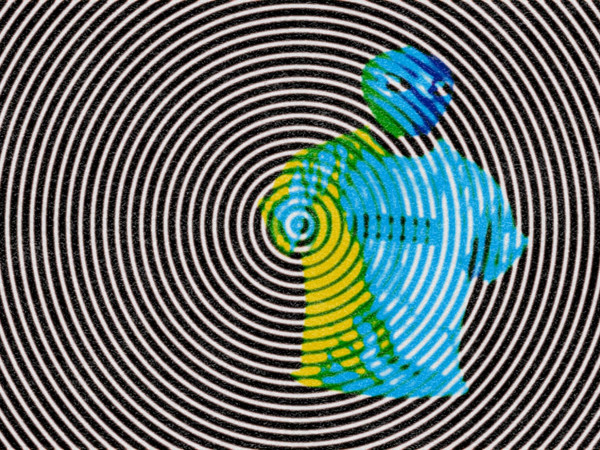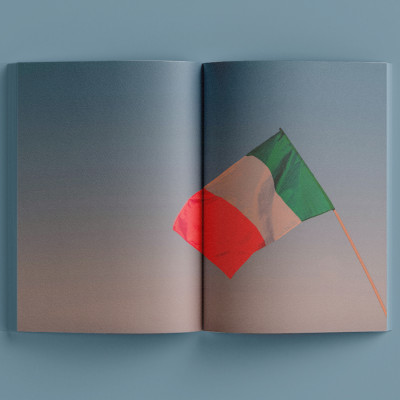Sui social nessunə è Wikipedia

Ho una piccola collezione che riposa nel telefono. Messaggi maleducati, sgarbati e aggressivi, ricevuti dopo aver condiviso qualcosa su un social media che si sommano in un garbuglio di negatività. “Sì, però le statistiche vanno capite […]”, “Da te non mi aspettavo questo, sei una delusione […], “Leggiti questo articolo va […], “Ti spiego[…]”, “Per dio![…]”. Queste sono solo alcuni degli incipit con cui mi sono confrontata aprendo la sezione messaggi di Instagram.
Ormai so che ogni volta che un contenuto, che sia una storia o un video, viene pubblicato qualcunə avrà qualcosa da ridire. Non solo, so che avrà qualcosa da ridire e che vorrà farmelo sapere in un modo che non mi lascerà spazio di scegliere se prendere parte o meno alla chat. Troverò parole perentorie che non potrò fare a meno di scorgere nell’anteprima, insulti più o meno velati, esasperazione, rabbia, persino accuse per cose che, a conti fatti, potrei non aver mai detto.
Il mio desiderio di affrontare o meno una conversazione di qualsiasi natura, quello che potremmo definire consenso, non è contemplato. Io devo prendere parte al discorso uno a uno, che mi piaccia o no. Non ci sono formule di cortesia né considerazione dell’infinita sfera di eventualità che potrebbero starsi verificando, rendendo la persona a cui si scrive più o meno incline a prendere parte allo scambio. Non c’è un diritto a sottrarsi, anzi, c’è la pretesa scontata della presenza dell’interlocutorə.
Il bisogno di esprimere la propria opinione viene elevato quasi fosse l’enunciazione di un fatto, va detto e ribadito a ogni costo perché percepito come giusto e vero. Al di là di tutto. Il tutto umano, infatti, è ciò che viene cancellato.
Non c’è uno sguardo, nel senso che troppo spesso la reazione precede il completamento della visione o della fruizione del contenuto e al contempo non c’è la consapevolezza che su molte cose si possono avere posizioni differenti. L’unico sguardo concepito è il proprio che deve essere imposto e affermato. Il desiderio dell’utente diventa quello di ritrovarsi sempre e comunque nell’altrə, che questo sia solo una superficie compatta e riflettente. La volontà di leggere solo espressioni omogenee del proprio modo di pensare è predominante nelle interazioni social. Le persone, però, sono inevitabilmente diverse e quando la differenza diventa palese, subentra il bisogno profondo di porvi rimedio. Di inserire una correzione.

E così, l’opinione dell’utente diventa l’evidenza empirica di cui bisogna prendere coscienza, in fretta e senza recriminare. La reazione dellə ricevente è predeterminata, deve essere sempre prontə a fare ammenda, a correggersi e a dare ragione all’altrə. Qualsiasi reazione diversa diventa innesco per uno scontro. Anzi, anche il solo palesare l’assenza di gentilezza o la presenza di aggressività non è tollerato.
Anche perché, a ben rifletterci, qual è lo scopo di tali messaggi? Il confronto prevede la predisposizione delle parti di considerare l’altro e la sua posizione e convenire a nuove sintesi, che possono anche comprendere il rimanere in rispettoso disaccordo. Queste interazioni, però, nulla hanno del confronto, sono veri e propri input di correzione. Senza rispetto e senza distanza, senza lasciare all’interlocutorə lo spazio per dettare anche ləi i codici comunicativi, ciò che viene cercato non è un confronto ma nulla più che una modifica. Netta e senza rimostranze. Quando ciò non avviene, si scatenano reazioni persino peggiori. Lo scopo allora si sublima, complice la rabbia, nel desiderio di mettere a tacere e di cancellare con una pretesa di passività assoluta.
Su Instagram, ho capito di non avere diritto alle mie emozioni, alla rabbia e al desiderio di farmi valere per ciò che credo essere giusto. Ricordo una conversazione, in cui una persona insisteva nel volermi spiegare il senso del concetto di minoranza riportando in maniera ossessiva ciò che restituiva Google tra i primi risultati. Ho speso una buona mezz’ora per cercare di inserire elementi e concetti che avevo studiato, riferimenti a testi e articoli, ma non c’era verso. La conversazione si è chiusa con una serie di insulti a me e alla mia intelligenza.
Mi sono chiesta per lungo tempo perché mi sia sottoposta a quella conversazione, soprattutto considerando che era iniziata in maniera palesemente aggressiva, senza quel minimo di cordialità che presuppone rispetto e interesse verso l’altrə.
La risposta che mi sono data è che mi sentivo in dovere di farlo, mi sono sentita nella posizione di dover dimostrare e spiegare, completamente privata della possibilità di scegliere se sottopormi a quell’interazione, perché in effetti nessuno mi aveva chiesto se volessi parlare del tema o meno. Non sono stata considerata nella mia capacità decisionale o interezza, ridotta alla risposta che avrei dovuto, incontrovertibilmente, fornire. Un output, a seguito di un input.
Il problema, infatti, è che quando si scrive attraverso i dispositivi come gli smartphone e attraverso i social media, le altre persone cessano di essere percepite come individui. Dopotutto, teniamo fisicamente tutto ciò che possiamo percepire dell’altrə nel palmo di una mano e quasi ci sembra di possederla. Certamente non si ha più consapevolezza della sua estensione. Avere una cosa in mano dà l’impressione di poterne disporre, di avere il potere, inteso come forza e possibilità, di manipolarla e gestirla.
La persona diventa una rappresentazione ridicola di sé stessa, nulla di umano o lontanamente complesso. La sua vita privata, con tutte le sue complicate ramificazioni, non esiste a meno che non sia scritta nero su bianco. Essa non è solo ciò che percepiamo, ma ciò che decidiamo di percepire. Dall’altra persona pretendiamo solo un silenzio assenso. Un accordo costante che deve essere ripreso ogni qualvolta una nota dà cenni di star cambiando melodia.
Il digitale, in effetti, appare come una miglioria del reale: è virtualmente perfetto. Prende la realtà e le dà indicazioni specifiche, la incastra e la incanala in codici, la seleziona gettando via ciò che non gradisce. Allo stesso modo chi abita il digitale subisce questa semplificazione. L’imperfezione umana diventa sgradevole tanto quanto la complessità. I volti devono essere perfetti, i corpi conformi, le parole neutre, le foto immacolate, le vite grandiose.
E se ciò non è propriamente vero, è quantomeno ottimizzabile, con un filtro, un ritocco in Photoshop, una selezione delle foto delle ferie e la scelta di condividerle per un periodo più lungo di quello trascorso in vacanza. L’umore viene definito con hashtag che invita al pensiero positivo, all’esaltazione della perfezione della vita e delle sue piccole gioie, in quella che si rivela essere, nelle parole del filosofo Byung-Chul Han, una distopia della prestazione.
Il gioco di somme diventa la realtà, ciò che non è visibile non è contemplabile, ma nemmeno supponibile. Viene quindi meno quel dovere cortese di non dare per scontata l’altra persona, anzi, essa viene completamente definita sulla base di quell’infinitesimale quantità di dati disponibili. Il distacco dal reale analogico è assoluto, tant’è che spesso, ci si ritrova con le mani ingarbugliate dalla rabbia e il desiderio di incontrare quella persona così determinata a distruggere qualsiasi consapevolezza abbiamo di noi stessi, di guardarla negli occhi e vedere se anche di fronte alla carne, al rossore della rabbia o all’umidità delle lacrime, continuerebbe a parlare così come scrive.
Nella comunicazione analogica, litigare è infinitamente più semplice e sano, foss’anche solo perché possiamo intuire l’inizio del diverbio e sappiamo che ci sarà una fine. Nel digitale, il tempo si dilata, si amplia e la pervasività dell’astio arriva in qualsiasi momento della giornata senza apparente soluzione di continuità. In quel mondo di messaggi e notifiche, ci ritroviamo nelle mani parole senza voce, senza prossemica facciale, senza gestualità e senza conoscenza reciproca. Il tutto, in assenza di una qualsiasi introduzione che non sia un diretto accenno a quello che è stato sentenziato essere uno sbaglio.
Giudice e tribunale sono fusi, le prove sono le convinzioni personali e la condanna è capitale, assoluta. L’efficienza della comunicazione digitale diventa un disservizio, un vero e proprio vizio di forma che ci lascia soli con un muri di testo e tutto quel reale contestuale che chi scrive si rifiuta di immaginare ad appesantirci e ferirci. La violenza è palese, ma negata.
Osservando a distanza di tempo alcuni dei messaggi più avvilenti che ho ricevuto, ho letto chiaramente l’intento: dare una direttiva incontrovertibile. A essa avrebbe dovuto, secondo questa logica, conseguire una modifica, una revisione. Come fossi una pagina Wikipedia, mi sarei dovuta adattare all’impulso orizzontale senza avere modo di verificarlo, contestarlo o rifiutarlo. Avrei dovuto agire come un semplice recipiente, modificandomi in attesa della prossima revisione da parte di unə altrə utente.
L’opinione viene veicolata come fosse un’informazione nell’erronea convinzione che questa coincida con il sapere, con la scienza. Disarmante è poi la considerazione della scienza, percepita da questo esercito di ottimizzatori, come una mole di dati da estrapolare in funzione di ciò che conferma le proprie idee. La qualità delle fonti, la pluralità delle ricerche e la formazione di una scienza come somma di studi sono dimenticate, anzi rifiutate.
Peggio ancora, subentra la disumana pretesa di infallibilità. La convinzione che l’interlocutorə abbia commesso un errore è motivo sufficiente per distruggerlə. Che l’errore sia nell’interpretazione di lo denuncia o si sia realmente verificato poco importa, ciò che è rilevante per l’utente è la correzione. La pressione che la pretesa di infallibilità genera sulle persone che fanno attivismo o divulgazione sui social è impressionante e ne intacca la salute mentale tanto quanto la qualità divulgativa e la libertà di essere intellettualmente onestə.
La paura del rinforzo negativo cancella la possibilità di interagire in maniera sana con il social e chi lo abita. Può arrivare addirittura a causare il silenzio, la tacitazione completa e quindi la contrazione se non la progressiva distruzione dell’identità digitale dellə singolə.

Per fortuna, però, non siamo pagine di Wikipedia, siamo persone e come tali non solo abbiamo diritto a sbagliare (la scienza stessa procede per errori) ma abbiamo anche lo straordinario potere di ribattere e lottare per quello che riteniamo essere giusto. Recuperare la possibilità di porre un limite, di rifiutare ciò che palesemente giunge allo scopo di dolere, ed eventualmente anche la sicurezza di poter esprimere un po’ di rabbia sono tutti elementi fondamentali per costringere chi abita il social a riconoscere la nostra umanità.
Anche perché di “un vai a quel paese” non si muore, di violenza psicologica e depressione, invece sì. Non solo: come è vero che i social sono la proiezione di una selezione ottimizzata, anche io posso modificare la mia collezione. Tant’è che da un po’ di tempo a questa parte ho preso a scattare screenshot dei messaggi più belli che ricevo allo scopo di depotenziare quelli negativi. In fin dei conti, quelli positivi superano sempre in numero quelli distruttivi, questi hanno solo il potere di ferire e di apparire più grandi di ciò che sono per il dolore e lo sconforto che causano.
Giusto ieri mi sono fermata a leggere un messaggio in cui una signora di mezza età mi diceva che “grazie alle cose che insegni ieri ho tenuto testa a mio marito in una conversazione sulla politica…è stata la prima volta in 20 anni in cui non ho taciuto pensando che doveva saperne per forza di più di me”.
La differenza tra l’essere umano e il contenitore digitale sta anche in questo, non è un mezzo o uno strumento, ma una persona con una dignità e un pensiero personale, critico, deviato da ciò che accade o non accade intorno a ləi e mossə, il più delle volte, dal bisogno di comunicare. Di stare con ə altrə. E se i social diventano un mezzo di divisione e alienazione, allora bisogna iniziare a pensare che qualcosa nella loro struttura non sta funzionando, o meglio, non sta funzionando in un modo che sia costruttivo per le persone che li usano.
E sarebbe perciò opportuno recuperare l’umano, estrarlo e ricollocarlo al centro del discorso, perdendo quella sciocca convinzione che le persone siano solo ciò che grazie ai social crediamo di sapere di loro. Smettendo di convincerci di poter tenere ə altrə nel palmo d’una mano.