Viviamo nella crisi della cura
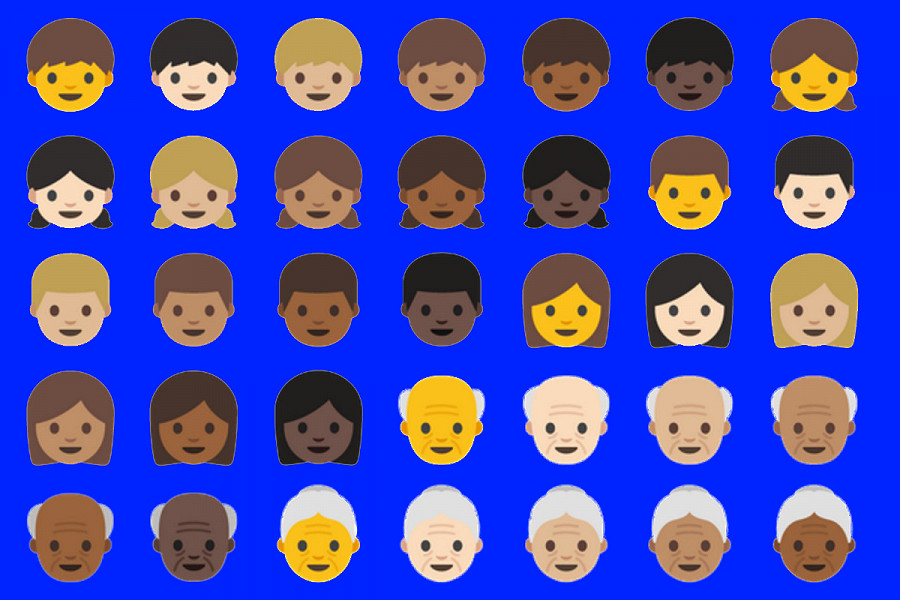
Dagli eventi di settimana scorsa abbiamo avuto la conferma che la nostra non è una società basata sulla cura. Mi riferisco all’omicidio di Akila Ogorchikwu che ci ha reso tuttə testimoni di cosa succede quando razzismo e sessismo si incrociano.
I fatti sono i più comuni, un uomo per proteggere la “sua” donna diventa aggressivo, se la minaccia - percepita - è una persona nera la violenza diventa velocemente fisica. Possesso, performance e razzismo si raggrumano.
Le persone intorno registrano e condividono, i giornali prendono i fermi immagine e li ingigantiscono, li pubblicano, usano parole che non sono il nome di Akila Ogochikwu per spersonalizzare il titolo e renderlo più accattivante. Si prendono una bella fetta di lettorə rabbiosə e razzistə omettendo l’identità, rigirandosi il nome tra le mani e trattenendolo in favore di epiteti profondamente discriminanti. Il sistema che abitiamo si mangia la vita delle persone discriminate a bocconi interi. Toglie i nomi, s’intasca le biografie, vende le immagini della morte senza preoccuparsi di quanto siano feroci queste azioni. Perché la ferocia è vincente, la ferocia viene premiata, al capitale razzista e sessista piacciono gli uomini-fiere.
Siamo nella crisi della cura, incapaci di prestare attenzione e sentimento persino negli eventi più drammatici. Stiamo seduti, la vita come una serie di Netflix, da scorrere in fretta senza dire nulla, senza alzare un dito per dissentire, per dire “basta, gli fate male”.
Non sorprende. Il capitale ci insegna che la cura non ha valore, è l’unica cosa che non vuole minimamente retribuire. Si appoggia felice al patriarcato per mantenere l’idea che la cura sia da orientare nelle mansioni determinate al femminile. Ruoli e stereotipi. Educazione e socializzazione insegnano l’empatia a un genere solo, istigando l’altro alla predazione. Così, la cura rimane nel femminile, nell’indesiderabile spettro della debolezza ed emotività delle donne. Sminuirla è essenziale, dandole valore si rischierebbe di aprire una finestra sulle mancanze del sistema. E sulla sua violenza.
La diffusione dei video, come pure il silenzio attonito, l’assenza di uno corpo che si frapponesse tra l’aggressore e la vittima, la mancanza di un cumulo di braccia che ne afferrasse le spalle e lo tirasse indietro, la presenza massiccia di titoli di giornale che feriscono la memoria dell’uomo quanto la gravità dell’aggressione, il rigurgito di richieste ad attivisti razzializzati perché ne parlino, senza avere l’accortezza di pensare che forse hanno bisogno di spazio, che quella è l’ennesima violenza da assorbire, l’ennesima minaccia da registrare, le opinioni furiose di chi “le nostre donne” e gli epiteti razzisti, la falsa attenzione di chi passa l’anno ad accendere micce e si accuccia in alto a osservare l’esplosione, tutte queste mancanze e azioni ci indicano che la nostra società non ha cura di niente ma soprattutto di nessunə.
La cura ci è dipinta come qualcosa di indecente, la guardiamo con spregio, come se tutta la nostra dignità venisse risucchiata, come se la sua sola presenza fosse una fonte inesauribile di contagio. E qui, forse, non ci sono errori.
La cura è contagiosa, sempre più del morbo e in maniera decisamente attiva. Prendersi cura ha un che di benefico che traspare e si propaga, sempre che gliene si dia l’occasione. Animi inariditi dalla competizione e dalla velocità non offrono tessuti perché il senso della cura possa maturarvi. E così, restiamo fermi, trincerati in quadrati invisibili e immateriali che ci separano irrimediabilmente. Gli smartphone, con i loro essere porte e contenitori, ne sono espressione. Ci rifugiamo in loro e ci perdiamo, tanto quanto abbiamo paura di prenderci cura dell’altrə. Di ascoltare cosa è successo, di osservare l’altro annoiarsi di noi, di sentire che le cose non vanno bene, che il mondo è in frantumi e che c’è un uomo a terra.
Abbiamo una paura terribile, perché non sappiamo cos’è la cura. La retribuiamo, a volte. Importandola da Paesi in cui creiamo voragini di assenze, da cui dreniamo mani e corpi e menti che si prendano cura deə anzianə perché altrimenti i servizi non bastano, ma la paghiamo poco e se possibile senza registrare la prestazione. Il nostro Stato non vigila, ma accetta. Perché se lui non vede e nessuno sente e le assistenze familiari rimangono nell’economia sommersa, allora forse non si leveranno mani che indicano un vuoto. Normativo, burocratico, retributivo e umano.
Lasciamo che la cura precipiti nel welfare invisibile, informale, rifiutandoci di avere attenzione nei confronti di chi lo abita, persone i cui diritti sono ristretti in cambio di stipendi. Alziamo il volume della televisione quando nella casa accanto le voci diventano furenti, bisbigliamo ma non chiediamo alla collega se le va di prendere un caffè per capire se davvero è solo caduta o se, invece.
Non ci premuriamo di tutte quelle persone senza dimora, passiamo loro accanto e strizziamo gli occhi per non vederle. Non ci fermiamo a controllare nulla che non sia riferito a noi. Viaggiamo nella vita in branchi di io, dimenticandoci che nell’economia delle cose siamo ben poca roba. Ci stringiamo in uno spazio così ridicolo espellendo il nostro essere umani, come se il corpo fosse tutto ciò che siamo.
Le altre persone, le chiamiamo altre per tenerle alla larga. E se muoiono in mare non ci disperiamo poi tanto, anche se tutto quello che volevano era arrivare e il mare e gli accordi con i Paesi sub sahariani gli hanno tolto questa possibilità. L’hanno recisa, dopo aver richiesto pagamenti in denaro e tempo.
Semplicemente non ce ne curiamo, non per un tempo maggiore di quello necessario a ingurgitare la mole di notizie dal mondo. Cura, che nemmeno capiamo ma a cui abbiamo così candidamente rinunciato. Abbiamo lasciato che l’idea della volontà generale ci seducesse trasformandosi in una scelta particolare determinata all’esterno, una chiave di lettura del vivere consociato assorbita e non attivamente ragionata.
Rousseau ci ha teso una piccola trappola, c’era l’occasione per pensare al bene come uno stato condiviso e non una proprietà di pochə, ci siamo risoltə con il benessere per pochissimə e il distacco alienato da ciò che ci rende così specificə: le altre persone. Sebbene ci sia un impegno costante - e politico - per negarlo, siamo esseri fatti per la condivisione, per la comunicazione, per il contatto, per la presenza di esistenze molteplici intorno a noi. Siamo fattə per la cura. Per avere quel riguardo spassionato e interessato, che sia attivo e pieno di spazio perché l’altro, umano e non umano, vi abiti e vi si riversi.
La cura, che non a caso è terapia e sollievo, è un lenitivo disinteressato e attento. Una cura che sia collettiva e non particolare, non viziata dal vincolo di proprietà e dal circolo di prossimità, che vada ben oltre quello che ci riguarda e ammetta attenzione per quello che riguarda anche gli altri, trovando qui il nostro interesse e il nostro ruolo. Una cura per non credere di essere solo rimedio ma imparare a leggere quali angolazioni del nostro vivere sono causa, sono bruciatura tumorale sulla pelle deə altrə.
Altrə, che sono le persone, gli animali e la Terra su cui rincorriamo il senso delle nostre brevi vite. Che singolarmente, in effetti, sono proprio minuscole, ma moltiplicate nella loro intensa connessione, viste nei loro intrecci sconfinati sono infinite. E quindi assistere, offrire sé stessə non tanto per qualcosa ma perché è giusto, perché essere preoccupatə per gli altrə è un motivo sufficiente, perché il bisogno dell’altra persona è sempre un motivo sufficiente.
Cura, che poi gli altrə avrebbero per noi, che non limiterebbe più il nostro esistere in pacchetti preconfezionati, ma che aprirebbe porte e portoni di quelle piazze chiuse dove sta il benessere, che non è il bene comune, e lo sparpaglierebbe, trasmutandolo in diritto.
La società della cura è qualcosa che sarebbe bello vedere, per cambiare le regole di questo gioco per assenze che uccide, uccide, uccide. Lo stesso Pianeta si scalda per la nostra instancabile e insensibile assenza di cura. Non curiamo le foreste, non curiamo gli oceani, non curiamo la fauna e i suoi ritmi, anzi, se possibile ce ne prendiamo un pezzetto: un trancio nel piatto per 6,60 euro ogni 100 g e un esemplare in una vasca di 1000 metri cubi. Mangiare e guardare, prendere.
La cura che non abbiamo ci sta uccidendo, alcunə prima di altrə.











