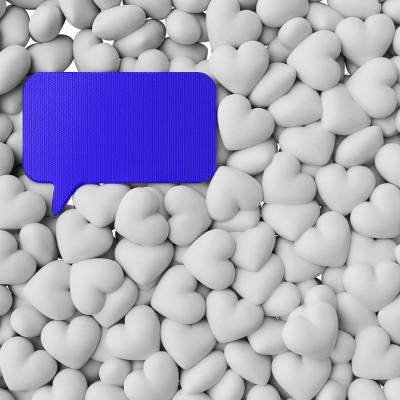Fast fashion: perché è necessario il salario minimo

Per poter produrre capi economici massimizzando i profitti, le aziende del fast fashion scelgono da tempo di produrre le proprie collezioni in Paesi dove la manodopera è impiegata al più basso costo possibile.
Il Bangladesh, con più di 3.500 fabbriche tessili, è attualmente il più grande produttore al mondo di abbigliamento dopo la Cina, mentre le persone che impiega in questo specifico settore sono tra le più povere del Paese. Le quasi 600.000 persone che lavorano nel confezionamento dei capi per H&M, a esempio, guadagnano in media 119 dollari al mese che, secondo la Global Living Wage Coalition, è una cifra ben al di sotto dei 194 dollari che sarebbero da considerare il salario minimo di sussistenza per poter sopravvivere nei sobborghi di Dhaka, città dove si concentra il maggior numero di fabbriche di abbigliamento.
In considerazione del fatto che l’industria tessile produce ben l’85% dei 55 miliardi di dollari di esportazioni annuali, posizionandosi come il settore chiave per l’economia del Paese, da tempo i lavoratori protestano affinché il loro salario venga proporzionato ai correnti costi di vita, aumentati a seguito dell’inflazione, che tra il 2022 e il 2023 è stata del 9%.
Con gli attuali livelli di reddito, i lavoratori sono letteralmente esausti: non hanno risparmi né soldi a sufficienza per poter provvedere alle proprie esigenze di vita primaria. Il malcontento è cresciuto quindi in maniera rapida, esplodendo a Ottobre con proteste che hanno portato anche alla distruzione di fabbriche e macchinari.
Nonostante i marchi di moda occidentali dichiarino, da almeno un decennio, di volere un aumento dei salari per la manodopera cui appaltano la produzione del loro vestiario, questo non si è mai realizzato.
Le aziende affermano di non poter fare in modo che accada, perché nella maggior parte dei casi non possiedono le fabbriche nelle quali vengono fisicamente realizzati i capi e non possono, quindi, incidere in alcun modo sulla retribuzione dei lavoratori ivi impiegati.
Invece sono proprio i marchi che si riforniscono in Bangladesh a giocare un ruolo nel trattamento economico dei lavoratori locali. Essersi rifiutati di rilasciare dichiarazioni e aver ignorato le proteste o le richieste dei sindacati è un segnale chiaro di disinteresse che legittima una condizione repressiva e antidemocratica, nonostante i lavoratori vivano condizioni inumane e rischino letteralmente la vita nel mero tentativo di uscire da una condizione di povertà e sfruttamento.
Il modello economico attuato dalle aziende occidentali, dedite da decenni alla delocalizzazione della produzione del vestiario, non può che essere definito predatorio. Le proteste, represse dal governo in maniera violenza, sono la conseguenza non solo dell’estremo impoverimento degli operai ma della loro perdita di fiducia nella creazione di un canale di comunicazione efficace ed efficiente a tutela dei loro diritti.
Una delle scelte più sensate, per le aziende, sarebbe quella di imporre una volta per tutte dei livelli salariali specifici, ma questo significherebbe adeguare le pratiche commerciali a un costo del lavoro più alto di quello attuale, che si aggira attorno al 3% di quanto pagato al fornitore.
I marchi quindi si mostrano d’accordo sul fatto che i salari siano troppo bassi nei loro mercati di approvvigionamento, ma allo stesso tempo restano saldi nel non voler percorrere la strada dei livelli salariali minimi da imporre ai fornitori. Una scelta frutto di un mero interesse economico.
In un vano tentativo di mantenere intatta la propria reputazione, senza perdere l’attuale massimizzazione dei profitti, spingono affinché siano i lavoratori in questione a essere addestrati meglio nello svolgere negoziazioni più efficaci per se stessi. Quella di imporre un salario minimo sarebbe, a detta loro, una scelta miope che indebolisce il ruolo dei lavoratori e dei sindacati e sarebbe molto meglio far loro negoziare salari più alti attraverso l’utilizzo di accordi collettivi.
Peccato che solo una percentuale irrisoria delle fabbriche dei fornitori del fashion possieda, nella realtà, una qualche forma di contrattazione collettiva.
Il problema che si vuole ignorare è che il costo minimo della manodopera e lo sfruttamento sistemico dei lavoratori costituisce la base commerciale dell’intera industria del fast fashion.
Non è un caso quindi che il Bangladesh, maggior esportatore mondiale di vestiti, sia anche il Paese dove gli operai vengono pagati meno. Viene scelto di proposito dalle aziende perché con il suo trattamento dei lavoratori garantisce alle industrie il costo più basso della manodopera e il margine di profitto più alto.
Lo sfruttamento umano diviene, così, elemento fondante nella scelta dei fornitori da parte delle aziende, al fine di restare competitive nella lotta con marchi cinesi ultrarapidi e a prezzi stracciati.
Insistere affinché venga riconosciuto alla forza lavoro un salario più alto, adeguato ai costi di minima sussistenza, significherebbe perdere terreno contro aziende che non si muovono in maniera altrettanto etica.
Finché le lotte non travalicheranno i confini e diventeranno di interesse occidentale, garantendo una solidarietà internazionale a scapito delle logiche del mero profitto, difficilmente le condizioni dei lavoratori potranno migliorare realmente.