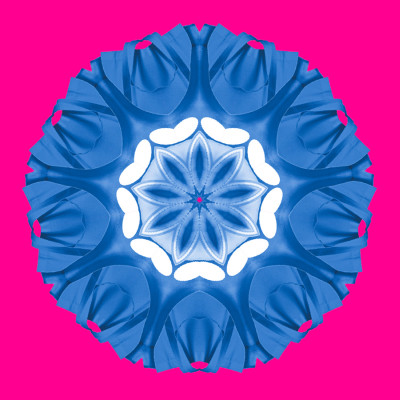Cos’è il carcere?

Forse qualcuno dirà che è ovvio, il carcere è una gabbia. Qualcun altro dirà che non è nemmeno così importante, basta che ci sia. Che faccia il suo dovere. Ma quale dovere? Di nuovo, un’ovvietà, tenere dentro di sé i malvagi, i cattivi, i mostri. Le bestie. Fagocitarli e trattenerli fino a che non sarà giusto che escano, sempre che sia giusto e chissà quando lo sarà.
Così, il carcere passa inosservato, come pure chi ci finisce dentro. Un’evidenza, ma più di tutto una certezza, il carcere. Anche se nessun* sa davvero cosa succeda là dentro, o almeno, chiunque non vi abbia avuto a che fare.
Il carcere è uno spazio di contenenti, di prigionia, in cui vengono trattenute le persone considerate criminali, ma in tutta onestà e osservando la statistica delle carceri italiane, dentro vi finiscono principalmente le persone socialmente considerate devianti. Devianza e crimine, due parole che vanno a braccetto anche quando non dovrebbero.
Crimine, delitto, atto che viola una legge. Devianza, qualsiasi comportamento fuori da quella che viene considerata norma. I crimini sono forme di devianza, ma spesso ogni devianza viene considerata crimine. Ed è così che si spiega la demografia carceraria italiana, composta da persone che hanno commesso reati, certo, ma anche da soggetti con patologie psichiatriche, senza fissa dimora, con status giuridici non riconosciuti e, principalmente, poveri.
Dopotutto se migrare per aver salva la vita o autodeterminarsi è un reato, agli occhi dell’ordinamento si rientra nella definizione di criminale, e quindi carcere.
Criminale, non persona che ha commesso reati. La prima condanna vera è questa, l’assimilazione identitaria della persona con il reato commesso. Non più soggetto, ma mostro, demone da rinchiudere, oggetto da spostare da una gabbia all’altra. Bestia, animale, perché ai non umani si può fare di tutto, anche spogliarli di diritti. Così come avviene con le persone incarcerate.
Di solito, quando parlo di carcere, arriva il momento degli “eh ma…” o degli anatemi con cui mi augurano di subire chissà cosa “e vediamo dopo che ne pensi”. Colgo quindi l’occasione per ricordare che dire a una persona che di mestiere analizza fenomeni sociali che certamente non ha pensato a quella specifica nicchia di reati, molto spesso, è un pregiudizio, perché è più probabile che ci abbia pensato. In aggiunta dire a tale persona, soprattutto quando è socializzata come donna, che le si augura di subire violenza è un’aggressione, ma soprattutto, il più delle volte è inutile.
Se una donna su tre - stando alla statistica che è sempre una sottostima visto che si basa sulle denunce e non tutte le persone riescono, vogliono, possono denunciare - ha subito una forma di violenza sessuale - e questa cosa l’affermano Oms e Istat, non io - allora è più probabile che sia già successo e che stia già dicendo quelle cose tenendone conto. E anche se non fosse, l’avvelenamento del pozzo - la fallacia che sminuisce autorità - rimane un errore logico. Non è che una persona che si identifica come donna non può parlare di abolizionismo carcerario a meno che non abbia subito violenza sessuale. È il nonsense di chi ripete una parabola di sistema e non vuole metterlo in discussione.
Perché è di questo che si tratta, mettere in discussione qualcosa che diamo per assodato. L’idea di criminale, di mostro, che di fatto è una persona che il più delle volte agisce sulla base di circostanze, anzi, per dirla con il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: «quelli dietro le sbarre per crimini gravi o associativi sono circa 13.000 su 53.000. Il resto sono percorsi che non hanno trovato risposte nel territorio e sono finiti in cella».
Perché sì, la gabbia è la risposta a tutto, soprattutto alla mancanza di servizi, ma anche all’assenza di volontà da parte del sistema di pensare a una gestione del crimine che sia educativa, riparativa e non semplicemente punitiva.
Infatti, che ci piaccia o meno ammetterlo, le statistiche dimostrano che il carcere, il più delle volte è un ambiente recidivante e non solo perché è uno spazio completamente separato dal tessuto sociale o per via delle pene accessorie che isolano ulteriormente le persone detenute - come la sospensione del diritto di voto - ma anche a causa dello stigma che accompagna le persone una volta uscite.
Scontata la pena, nella sua interezza o no, non finisce la punizione. Chi è stato in carcere subisce uno stigma proprio perché la società gli ha affibbiato una nuova identità “criminale”. Riprendere le maglie di una vita interrotta con un marchio cucito addosso non è semplice. La punizione rimane attiva sul lavoro, nelle relazioni e nelle interazioni. E l’ombra della detenzione si allunga, risucchiando chi non trova più i fili della vita di prima o chi si perde, incerto sui codici esterni e preferisce, tutto sommato, quelli che conosce già, interni alle istituzioni carcerarie.
Ora le carceri sperimentali cercano di modificare le condizioni detentive, ma davvero il massimo che riusciamo a fare è una modifica? Non possiamo immaginare qualcosa di più articolato e strutturale che agisca effettivamente ed efficacemente? Potremmo, in effetti. E non è una novità. Di abolizionismo carcerario si parla da tempo, Angela Davis proponeva un approccio multiplo, stratificato e sociale già vent’anni fa con il suo Aboliamo le prigioni?.
Le riflessioni, evidentemente, non mancano, come pure le evidenze che dicono sia necessario fare qualcosa a riguardo.
Antigone, un’associazione che attraverso rilevazioni interne alle strutture detentive produce rapporti sulle condizioni di chi abita il carcere, lo scorso anno ha lanciato l’allarme sovraffollamento, asserendo che nel 2023 “a fronte di 51.272 posti ufficialmente disponibili, al 30 novembre, i detenuti erano 60.116”. Una popolazione carceraria in crescita compressa in una serie di istituti molto spesso fatiscenti e obsoleti, in cui addirittura, come si evince sempre dal rapporto di Antigone, mancano i servizi base. “Considerando sempre le 76 schede elaborate, il 31,4 % delle carceri visitate è stato costruito prima del 1950. La maggior parte di questi addirittura prima del 1900. Nel 10,5% degli istituti visitati non tutte le celle erano riscaldate. Nel 60,5% c’erano celle dove non era garantita l’acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell’anno. Nel 53,9% degli istituti visitati c’erano celle senza doccia. Nel 34,2% degli istituti visitati non ci sono spazi per lavorazioni. Nel 25% non c’è una palestra, o non è funzionante. Nel 22,4% non c’è un campo sportivo, o non è funzionante”.
Per una parte dell’opinione pubblica le cose vanno bene così, e anzi, appare persino giusto che ci siano sofferenze e mancanze aggiuntive perché - come s’è detto prima - chi sta in carcere viene degradato al punto da ritenere che si meriti di tutto, dolore compreso. Sorvolando su quei nostalgici che invocano la pena di morte, punizioni corporali, castrazioni chimiche - e sorvolando pure sul fatto che spesso queste terrificanti proposte arrivano pure da chi risiede nei palazzi del potere e ama indulgere in questa becera demagogia qualunquista - è ora di rendersi conto che le carceri, più che di chi le attraversa, parlano della nostra società, di com’è fatta, dei suoi valori e della sua qualità.
Il fatto che solo nel 2003 ci siano stati 68 suicidi, di persone che mediamente avevano 40 anni (di cui 15 sotto i 30), dovrebbe suggerirci che al momento viviamo uno spazio sociale e istituzionale che si disinteressa di chi lo abita al punto da lasciarlo morire. Il 5 gennaio nel carcere di Montacuto si è ucciso Matteo Concetti, 25 anni, che soffriva di disturbo bipolare e che in carcere non riceveva le giuste cure e attenzioni. Concetti temeva l’isolamento, in cui era stato messo dopo un’aggressione a un agente del penitenziario, ed era chiaramente in uno stato di attivazione negativa dovuta a quell’ulteriore forma di detenzione. Il 5 gennaio 2024 ha deciso di impiccarsi. “ Nel 85,3% dei casi il suicidio avviene per impiccamento, nel 5,9% per asfissia con bombola da gas, nel 4,4% per sciopero fame. Nel frattempo nel corso del 2023, negli istituti visitati da Antigone si sono registrati in media ogni 100 detenuti 16,3 atti di autolesionismo, 2,3 tentati suicidi, 2,3 aggressioni ai danni del personale e 4,6 aggressioni ai danni di altre persone detenute” si legge in un report dell’associazione.
In carcere si soffre, chi per patologie pregresse inasprite dalla reclusione, chi per il semplice fatto di essere recluso e dimenticato. Sì, perché una volta chiusa la porta e segnato l’ingresso, la persona subisce un’opera di rimozione sociale. Chi le sta vicino sceglierà se frequentare gli spazi di incontro, spesso tetri, offrirà supporto economico quando possibile, cercherà di vivere integrando quell’assenza nella sua vita. Chi è dentro sentirà il mondo fermarsi e vi tornerà, sempre che non vi siano di mezzo ergastoli, scoprendo che davvero è andato avanti senza tenere uno spazio aperto, uno spiraglio per reinserirsi.
Le famiglie, in fin dei conti, non possono fare tutto da sole, ma si ritrovano abbandonate a sé stesse, con oneri esterni e interni alla vita carceraria. E alla fine la pena, che più che detentiva è punitiva, colpisce anche loro.
Dunque, a fronte di quest’ennesimo caso, delle evidenze e della realtà statistica, dobbiamo iniziare a ripensare il modo in cui vengono trattate le persone che hanno commesso un reato, come pure domandarci perché la risposta dello Stato a forme di esistenza considerate devianti sia la carcerazione. Perché la verità è che siamo già in ritardo e dobbiamo recuperare.
Che cos’è il carcere? Una gabbia, e come tutte le gabbie deve essere smantellata.