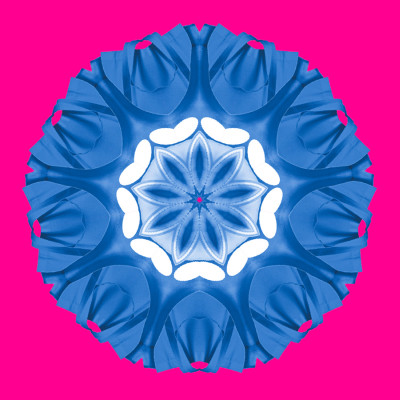Il Paese che non cresce

L’ultimo Rapporto INAPP 2023 Lavoro, formazione, welfare. Un percorso di crescita accidentato dipinge sin dal titolo, ancora una volta, un Paese in totale stallo. E mentre, come spesso facciamo, continuiamo a cercare all’esterno qualcuno a cui attribuire le colpe, la verità è che i dati parlano chiaro, ma siccome non ci piacciono, preferiamo far finta di non vederli.
Uno su tutti: tra il 1991 e il 2022, i salari reali sono cresciuti dell’1%. Magari si potrebbe pensare che sia avvenuto anche altrove, ma non è così: nei Paesi dell’area Ocse, in media, sono cresciuti del 32,5%. Già: il 32,5% contro l’1%.
E in tre momenti storici, anziché crescere come sarebbe stato naturale, si sono perfino ridotti.
Il primo è stato nel periodo compreso tra il 1991 e il 1995, quando si osserva una contrazione del 5%. Il secondo, a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008, ovvero tra il 2010 e il 2012, nel quale la decrescita è stata pari al 4,7%.
L’ultimo nell’anno della pandemia: con appena un anno, nel solo 2020, si è registrato un -4,8%. Nello stesso 2020 si amplia ulteriormente la distanza rispetto ai Paesi dell’area Ocse, rispetto alla media dei quali, il nostro Paese mostra un livello di salari reali inferiore del 33,6%. E se nel ranking dei Paesi Ocse sui salari medi annui reali del 1992, l’Italia si collocava in 9° posizione, nel 2022 è 22°.
Ma questo paese che non cresce è anche un paese che si pasce dei suoi squilibri. Il Rapporto contiene anche i dati rilevati nella V Indagine Inapp sulla Qualità del lavoro. Dati che dividono il Paese in due categorie di polarizzazione delle condizioni lavorative: da un lato, gli uomini qualificati che vivono nel Centro Nord ed hanno massime garanzie. Dall’altro, tutte le altre persone.
Particolarmente svantaggiate risultano essere le donne, le cui condizioni lavorative sono peggiori sotto tutti i punti di vista (retribuzioni, contratti, stabilità lavorativa, aspetti ergonomici, complessità del lavoro, possibilità di sviluppo e carriera, livelli di autonomia).
Un’altra polarizzazione? Quando si misura il livello di soddisfazione rispetto al proprio lavoro, le donne sono comunque più sodisfatte degli uomini (e mannaggia al patriarcato, perché la verità è che noi ci accontentiamo) e gli over 55 sono incredibilmente più soddisfatti dei giovani (e ne hanno davvero ogni motivo).
Siamo in chiusura d’anno. Questi dati, diciamoci la verità, non ci volevano.
Avremmo preferito leggere che tutto stava andando bene.
Ma c’è anche da dire che queste non sono novità. Sono alcuni dei fattori strutturali sui quai il nostro Paese si incaglia da tanto, tronfissimo tempo.
Un mercato del lavoro in continua sofferenza, un tasso di occupazione femminile sempre troppo basso, una quota sul totale di forme contrattuali atipiche che potremmo definire imbarazzante, le difficoltà crescenti dei lavoratori, che sognerebbero migliori condizioni sia di lavoro che retributive.
Non è tutto: la rincorsa troppo lenta delle trasformazioni, tra cui quella digitale, l’invecchiamento costante della forza lavoro, la prospettiva (non poi così distante) di una carenza strutturale di forza lavoro.
Cosa servirebbe? Per quanto personalmente viva con fastidio la retorica americana, bisognerebbe crederci.
Bisognerebbe partire da una valutazione non retorica dei punti di forza di questo Paese. Una valutazione con lo sguardo verso il futuro e non verso il passato. Una valutazione non nostalgica, ma che sappia guardare con lucidità a tutto quello che, a oggi, può rappresentare un fattore di crescita (sì, influencer compresi).