Innovazione: l’effetto Bruxelles non è perfetto
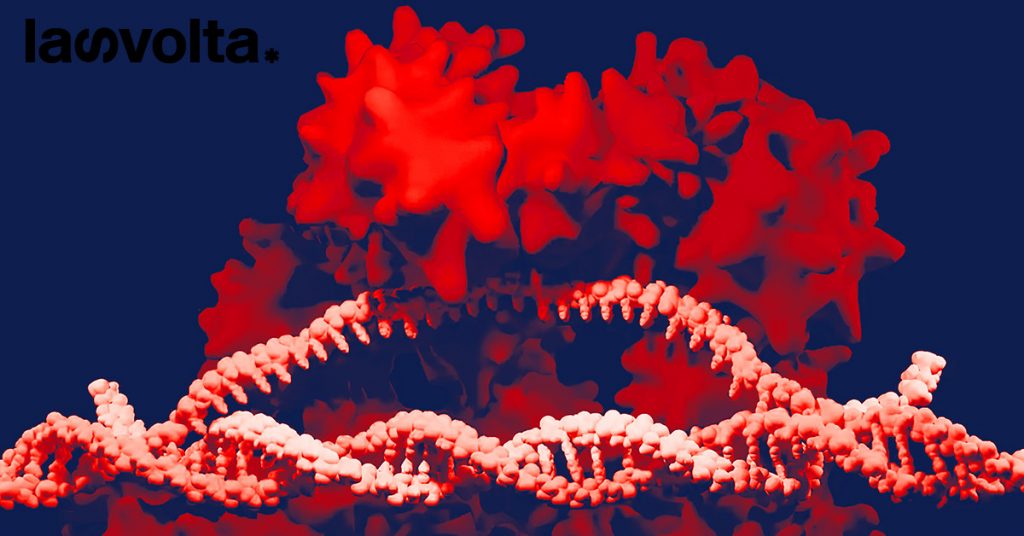
Per millenni,gli umani hanno modificato le specie viventi che allevano e coltivano. Hanno selezionato le varianti naturali più utili, le hanno incrociate con altre specie e hanno sviluppato la tecnica dell’innesto per aggiungere caratteristiche desiderabili alle piante usate in agricoltura. Negli ultimi decenni gli scienziati hanno anche creato organismi sintetici e sviluppato organismi transgenici, brevettandoli e vendendoli in molti mercati del mondo, mentre in altri, come l’Europa, sono vietati. Ma dal 2011 esiste unanuova tecnologia per modificare il patrimonio genetico, ilCrispr-Cas9, che non produce necessariamente organismi geneticamente modificati maconsente di selezionare con precisione varianti del genoma esistenti in naturae innestarle nelle piante conosciute: può essere visto comeun acceleratore delle tecniche tradizionalipiù che un sistema per creare nuove specie sintetiche. In Kenya, i laboratori locali stanno usando il Crispr-Cas9 perpreparare varianti di sorgo che resistono alle piante parassite e possono risolvere gravissime, ricorrenti carestie. Ne scrive Anjana Ahuja sulFinancial Times. Dall’Argentina agli Stati Uniti, queste tecniche sono ammesse e utilizzate. Nel Regno Unito la normativa si sta aprendo a queste possibilità. In Europa, dove le tecniche tradizionali per selezionare le specie da coltivare sono ovviamente ammesse dalla legge,le tecnologie transgeniche sono invece vietate. E la normativa sulle specie transgeniche, secondo la Corte Europea,non distingue come dovrebbe le tecniche più moderne. I governi dei 27 Paesi dell’Unione europea hanno recentissimamente votato un progetto di modifica del sistema normativo che dovrebbe consentire di distinguere meglio tra le tecnologie chemodificano il patrimonio genetico delle piante usate in agricoltura invece di trattarle tutte allo stesso modo: i divieti diventerebbero cioè più selettivi e consentirebbero l’uso del Crispr-Cas9 per accelerare i processi tradizionali di selezione delle specie coltivabili. È chiaro però chela trasformazione delle norme europee richiederà molto tempo, l’anno elettorale non consentirà di procedere speditamente, le lobby che si oppongono e le organizzazioni più ideologicamente contrarie avranno vita facile. Per ironia della sorte, il Crispr-Cas9 è talmentefacile da usare e poco costosoda poter essere usato anche nei Paesi meno ricchi, nei laboratori più frugali e nelle aziende più piccole: insomma, consenteun’architettura del sistema dell’innovazione nell’agricoltura meno concentrato nelle mani delle grandi multinazionaliche hanno finora governato il mercato delle sementi geneticamente modificate. Questo dovrebbe essere apprezzato da alcune grandi organizzazioni non governative e dalle associazioni di consumatori che di solito tentano dicontrastare il potere oligopolistico di alcune multinazionali. Ma perché sia apprezzato da queste organizzazioni la tecnica dovrebbe essere più conosciuta e le interpretazioni più ideologichedovrebbero essere superate da analisi scientificamente più aggiornate. Si potrebbe arrivare a una normativa che – come avviene con il recenteAI Act-distingue tra i livelli di rischio diversi delle tecnologie: vietando quelle troppo rischiose e regolamentando quelle che hanno un livello di rischio elevato ma contenibile con opportune attività di test, limitazione dell’uso e monitoraggio. Tutto questo è anche parte dellacompetizione tra sistemi economici. Alcune leggi sembrano troppo restrittive in certi luoghi e troppo lasche in altri. I sistemi fiscali di certi Paesi, notoriamente, sono pensati proprio per attrarre i ricchi, come Montecarlo, e le multinazionali, come l’Olanda e l’Irlanda, a scapito delle altre nazioni. Hanno ragione? La legittimità delle loro decisioni le rende anche giuste? Di certo non si può dire ideologicamente che le regole più lasche sono sempre le più giuste perchéfavoriscono l’innovazione delle imprese, così come non si può dire che sia vero il contrario. Un pragmatismo sarebbe di certo auspicabile. Ma come si possono modificare le norme dei diversi Paesi in modo che le decisioni pubbliche abbiano conseguenze equilibrate sull’attrazione dei capitali e dei talenti ma anche sullasostenibilità, il welfare, la giustizia sociale, l’innovazione? Ovviamente, non si possono imporre le stesse leggi a tutti i Paesi. Ma neppure si può abbandonare tutto alla conflittualità competitiva tra i Paesi. Specialmente quando questi appartengono a un’unità sovranazionale o federale. In Europa le contraddizioni tra sistemi fiscali sono eclatanti. Ma anche negli Stati Uniti ci sono regole contrastanti. Elon Musksi è lamentato delle norme del Delaware e suggerito ai suoi colleghi imprenditori di fare le loro aziende in Texas, che ha leggi più favorevoli. In effetti, un giudice del Delaware ha recentemente vietato allaTesladi concedere a Musk una retribuzione record di 55 miliardi di dollari (sic!) osservando che l’imprenditoreaveva avuto troppo potere nel prendere questa decisione. Se esistesse davvero un altro posto dove una scelta tanto squilibrata a favore del socio di riferimento e contro gli altri soci sarebbe ammessa di certo questo non la renderebbe più giusta. L’idea aprioristica che le norme meno restrittive sono sempre migliori perché favoriscono gli imprenditori non ha senso: significherebbe che gli unici interessi legittimi sono quelli degli imprenditori. D’altra parte non può essere giusto neppure affermare il contrario. In Europa e negli Stati Uniti, ovviamente, esistono modi per tentare di portare maggiore equilibrio nella competizione tra Stati. Anche se non sempre funzionano. A maggior ragione, unaconvergenza normativa è difficile a livello internazionale. Un movimento di pacificazione nella competizione tra sistemi normativi è stato avviato con l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Che ultimamente però appare meno incisiva. Riesce talvolta a impegnare tutti gli Stati – in teoria – a cercare una convergenza nelle policy per la sostenibilità o per ilcontrasto all’emergenza climatica, ma non sempre riesce a raggiungere i risultati voluti. Il segretario generale dell’Onu per esempio non fa che lamentare la mancanza di risultati sul piano dell’agenda 2030 e sul clima. E in tempi di guerra, poi, tutto questo diventa ancora più difficile. I Paesi più avanzati devono essere leader in tutto questo e aiutare gli altri a prendere la strada giusta. Ma i Paesi più avanzati non sono sempre quelli di una volta: ilKenya, talvolta, va preso a esempio. Anche se gli europei non sono abituati a farlo.L’innovazione normativa si fa apprendendo dai risultati ottenuti da tutti i Paesi.