Autismo: quando la diagnosi arriva da adulti
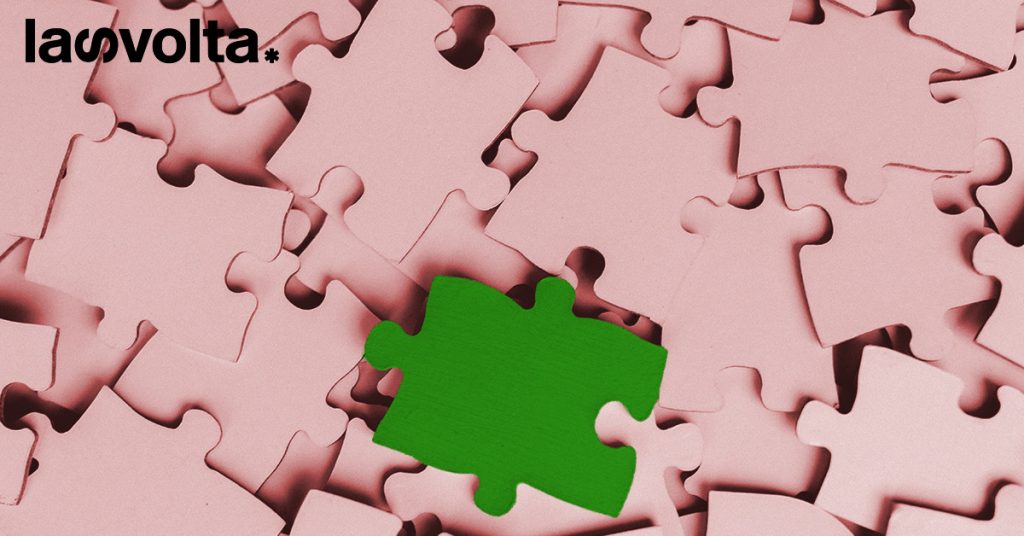
Il 2 aprile si celebra laGiornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone affette da DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento – e sensibilizzare alla comprensione e accettazione delle neurodiversità. L’Organizzazione Mondiale della Sanitàstimache nel mondocirca 1 bambino su 100 ne sia affetto, ma i numeri potrebbero essere molto più elevati perché “la prevalenza dell’autismo in molti Paesi a basso e medio reddito è sconosciuta”. Le caratteristiche di questo disturbo del neurosviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione “possono essere rilevate nella prima infanzia”, spiega l’Oms, “mal’autismo spesso non viene diagnosticato se non molto tempo dopo”. Di recente,un documentariodellaBbcha raccontato la storia della modella Christine McGuinness, a cui è stato diagnostico l’autismo all’età di 33 anni. Ma il suo caso non è una rarità. Il servizio di psicologia onlineUnobravo,in occasione di questa giornata, ha dedicato un ampio approfondimento al tema ancora poco trattato dell’autismo negli adulti. Spesso, si tende a pensare automaticamenteai bambini, «dimenticandosi chei disturbi dello spettro autistico sono una condizione che, nella maggior parte dei casi,accompagna l’individuo durante tutto il suo ciclo di vita», spiegaValeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical directordiUnobravo. Ricevere una diagnosi e intraprendere un percorso di terapia è importante a ogni età. Spesso ci si chiede se l’autismopossa manifestarsi in età adulta, la risposta è che, più che manifestarsi,può essere diagnosticato in età adulta, anche se solitamente i primi segnali ci sono già intorno ai 2-3 anni di vita. Può accadere, infatti, che «arrivino più in là rispetto al periodo precoce dello sviluppo o che, soprattutto nei casi di autismo lieve, passino in sordina e vengano, quindi, ignorati. – continua Perris -In età adulta non è semplice avviare un percorso di indagine diagnostica: spesso le caratteristiche sono diverse o meno evidenti, oppure l’individuo ha sviluppato capacità dimaskingche gli permettono di dare meno visibilità ai sintomi». Può accadere che alcuni elementi tipici della condizione autistica «vengano espressi esclusivamente in solitudine e risultino, per questo, poco visibili agli altri». Ilmasking, anche noto comemascheramentoomimetizzazione, si verifica quando una persona autistica si mette, appunto, una sorta di “maschera” per nascondere i propri tratti autistici. Qualche esempio: imita i gesti e le espressioni facciali delle persone attorno a sé, forza il contatto visivo, prova delle conversazioni prima di un’interazione, sopprime glistimming, quei movimenti ripetitivi come battere le mani o ripetere una parola o dei suoni. Oltre al masking, «molte persone autistiche adulte tendono a mettere in atto strategie compensatorie e meccanismi dicopingal fine di celare eventuali difficoltà in pubblico», spiega Perris. Si tratta dimeccanismi dissimulatoriche comportano anche sforzi enormi e possono essere fonte di grande stress. Può anche succedere che nell’adulto «i sintomi vengano confusi condiagnosi di altro tipo, comedisturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, dipendenza da sostanze, disturbo ossessivo compulsivo, psicosi, disturbi di personalità, bipolarismo, disturbi alimentari o depressione». Risulta più facile identificare l’autismo quando è accompagnato «da una grave disabilità intellettiva», mentre è più complesso individuarlo in chi presenta «livelli di funzionamento più elevati», continua Perris. Secondo l’analisi diUnobravo, però, ci sono anche dei benefici nella diagnosi in età adulta: «Può, a esempio, permettere al soggetto autistico di avereuna maggiore comprensione di se stesso e del proprio modo di rapportarsi al mondo, così come portarlo ad acquisire una prospettiva nuova sulla propria infanzia e a guardare alle esperienze passate sotto una luce diversa», spiega la dottoressa Perris. Per molti, avere una diagnosi formale può essere «un sollievo e un balsamo lenitivo per il senso di inadeguatezza esperito fino a quel momento». Ma ci sono anche deifalsi miti da sfatare, come la tesi per cuii soggetti autistici non amino socializzare e stiano a proprio agio solo in solitudine: «In realtà, spesso vorrebbero creare nuove relazioni, ma trovano delle difficoltà nel farlo». Questo avviene, in particolare, nel periodo dell’adolescenza, «ma studi recenti hanno messo in luce che solo una minima percentuale di adulti con DSA vive in modo indipendente o semi-indipendente, è sposato o in una relazione sentimentale e ha almeno un amico e un lavoro».La diagnosi è importante a qualsiasi etàproprio perché «può aiutare la persona a comprendere meglio le proprie difficoltà e, al contempo, imparare a sfruttare i propri punti di forza, qualità e abilità. Infine, essere consapevoli della propria condizione è indispensabile per poter individuare e richiedere il tipo di supporto esterno di cui si ha bisogno». La condizione autistica, comunque, «non è una malattia, ma un modo peculiare di vedere, sentire, vivere il mondo e soprattutto vivere gli altri. -conclude Perris – Per questo non esiste una cura o un’unica terapia che possa sposarsi alle caratteristiche uniche di ciascun individuo».