Crescita economica e ambiente: un binomio necessario
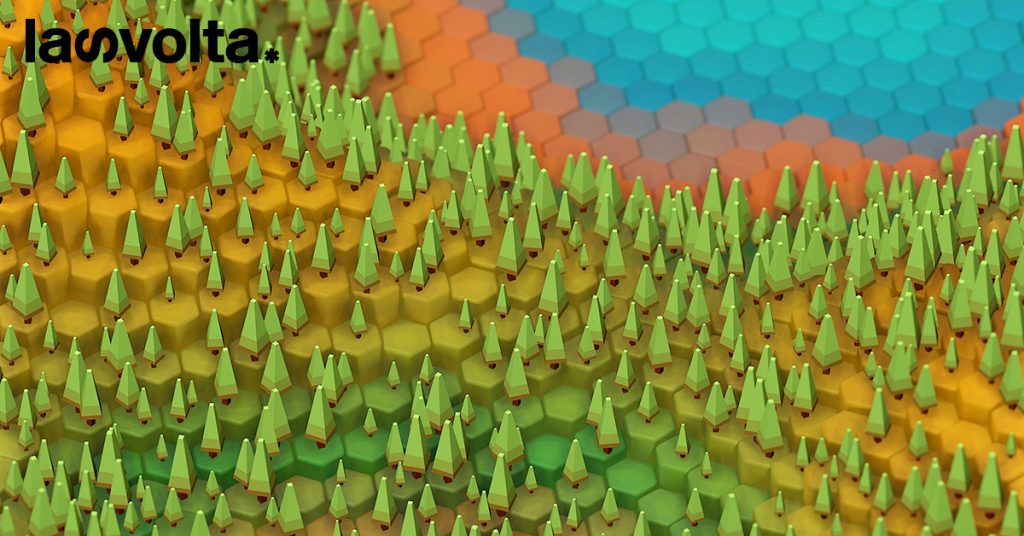
A partire dalla rivoluzione industriale lacrescita economica e il rispetto dell’ambiente hanno seguito binari opposti. La teoria fondamentale che ha sorretto l’industria capitalistica per anni è stata quella delloshareholder value, secondo cui l’impresa serve sostanzialmente a massimizzare il valore per gli azionisti, creare ricchezza per i suoi soci e proprietari anche a costo didover inquinare senza scrupoli. Una scuola di pensiero che ha favorito lo sviluppo dei mercati finanziari rendendoli piazze di vendita e acquisto sempre più rapidi, flessibili e inseriti in una prospettiva di investimenti a brevissimo termine. Un sistema di questo tipo conduce verso attività speculative spietate e rischiose, che si gonfiano in bolle sempre più ampie e fragili, pronte a scoppiare nel momento in cui la fiducia viene meno, travolgendo l’intero mercato finanziario e le economie dei singoli stati (la crisi dei subprime americani del 2007 ne è un esempio evidente). A questo impianto altamente oscillante e completamente dedito al profitto si contrappone la dottrina dellaCorporate social responsability, che teorizza una responsabilizzazione dell’imprenditore nei confronti dei terzi, un macrogruppo composto dallo Stato in cui la sua industria opera, nonché le comunità locali in cui si insedia l’impresa: tutti i soggetti che hanno interesse a che l’attività dell’impresa si svolga in maniera adeguata, corretta erispettosa del loro patrimonio ambientale. Questa teoria si pone alla base delle nuove discipline sviluppate a livello europeo, che si traducono in unfitto insieme di norme e regolamenti comunitarisorretti dal principio disostenibilitàdell’attività di impresa, declinata in termini di tutela dell’ambiente, diritti sociali, attenuazioni se non eliminazione delle disuguaglianze all’interno e all’esterno della governance societaria. Nonostante le ferite della crisi americana non si siano ancora bene rimarginate, nel 2015 viene adottata l’Agenda Onu per il 2030, che individua 17 finalità di sviluppo sostenibile che dovranno essere soprattutto dalle imprese private. Nello stesso anno molti stati si incontrano a Parigi per firmare un altro importantissimoaccordo, in cui gli aderenti si impegnano a ridurre – nel proprio sistema imprenditoriale – le emissioni di gas serra di origine antropica, nell’ambizioso obiettivo diabbatterle completamente entro il 2050. Si attiva così un vero e proprio piano d’azione di matrice europea che si articola in nuovi obblighi di trasparenza per tutte le grandi imprese, che dovranno periodicamente fornirerapporti sulla sostenibilitàdelle loro attività produttive in termini di impiego dell’energia, utilizzo di materie prime e uso del suolo, impatto sulla biodiversità. Oltre a ciò, si punta allo sviluppo dellafinanza sostenibile, per orientare i mercati e i loro avventori in scelte di investimento verso prodotti che rispettino i tre indicatori finanziari dell’Enviroment, Social e Governance sintetizzati nella fortunata sigla Esg inventata da James Gifford, attualeHead of sustainable & impact advisorydi Credit Suisse. Una regolamentazione così densa di norme e parametri da rispettare dovrebbe però essere affiancata da unconcreto piano di investimenti su scala mondiale, tale da riversare nella pratica tutte le milestone che compongono i vari accordi. Per stabilizzare il clima mondiale è necessario puntare su una produzione pulita di elettricità, allontanandoci quindi dalle emissioni di gas serra derivate dall’uso dei combustibili fossili. Il rischio però è che l’enorme quantità di obblighi burocratici da adempiere rallenti gli investimenti in produzione, fornitura e distribuzione di energia pulita, che secondo le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia(Iea)ammonterebbe a una spesa mondiale di circa260 miliardi di dollari l’anno. Un livello di investimento così alto sarà possibile solo con una adeguata semplificazione burocratica, oltre che a un ampio piano di incentivi che rendano i membri della clubNot in my backyardmaggiormente favorevoli ad avere parchi eolici nelle vicinanze delle loro abitazioni, attraverso significative riduzioni della bolletta. D’altronde investire nella ricerca, sviluppo e soprattutto costruzione di sistemi tecnologici di produzione pulita di energia rappresenta per gli stati unasset strategico su più livelli: non solo la decarbonizzazione delle imprese, ma anche la crescita del prodotto interno lordo nazionale e l’aumento di posti di lavoro. Lo sanno benei governi dell’America Latina, dove si trova oltre la metà dellitiomondiale, prezioso metallo alcalino utilizzato nelle batterie per i veicoli elettrici come automobili e biciclette, ma anche smartphone e computer. Attirati dalle oltre10 milioni di tonnellate presenti tra Cile e Argentina, delegazioni di Usa e Unione europea sono accorse per assicurarseli come nuovi partner commerciali – e quindi erodere la dipendenza con la Cina, che conta da sola oltre 1 milione di tonnellate di metalli hi-tech – ma anche diversificare le risorse necessarie alla transizione energetica. Motivo per cui molti governi dei paesicorteggiatihanno mostrato l’intenzione dinazionalizzare l’estrazione e la produzione di litioattraverso società statali e partecipazioni di maggioranza fra le principali società private operative in quel campo, le cui concessioni sono state ridotte da 50 a 30 anni. L’obiettivo è quello di applicare un controllo nazionale su un settore in fortissima crescita, in modo tale da aumentare le entrate e il Pil nazionale canalizzando i circa13 trilioni di dollariprevisti tra 2021 e 2040 ricavati da litio, rame, nichel e altri metalli fondamentali direttamente nelle casse dello Stato. L’ipotesi della nazionalizzazione mostra tuttavia diversi rischi, soprattutto quando attori politici instabili (e spesso coinvolti da colpi di stato) hanno fra le mani settori produttivi di fondamentale rilevanza mondiale come quello energetico. Fatto sta che l’arrivo della guerra in Ucraina ha messo in moto una serie di iniziative da parte degli stati maggiormente energivori, i cui governi hannopotenziato gli stanziamenti per finanziare la transizione verde, una vera ancora di salvezza dalla dipendenza energetica della Russia. Prezzi elevati e una nuova consapevolezza energetica ha già portato privati e imprese a consumare in maniera più intelligente, con un-2% di utilizzodi combustibili nell’economia mondiale, anche per via di un clima mite – sempre frutto del cambiamento climatico – che ha reso superfluo l’utilizzo dell’energia elettrica in inverno. TraInflation reduction acteGreen Deal,oltre 600 miliardi di dollariverranno stanziati per le imprese americane ed europee come sussidionello sviluppo di tecnologie verdi. La partita climatica si gioca sul campo della crescita economica, nella speranza che un aumento degli investimenti diano forma a un circolo virtuoso di generazione di energia rinnovabile e diminuzione generalizzata dei costi per cittadini e imprese.