Alimenti sostenibili: Lorenzo Biagiarelli, «In Italia sono tutti molto spaventati»
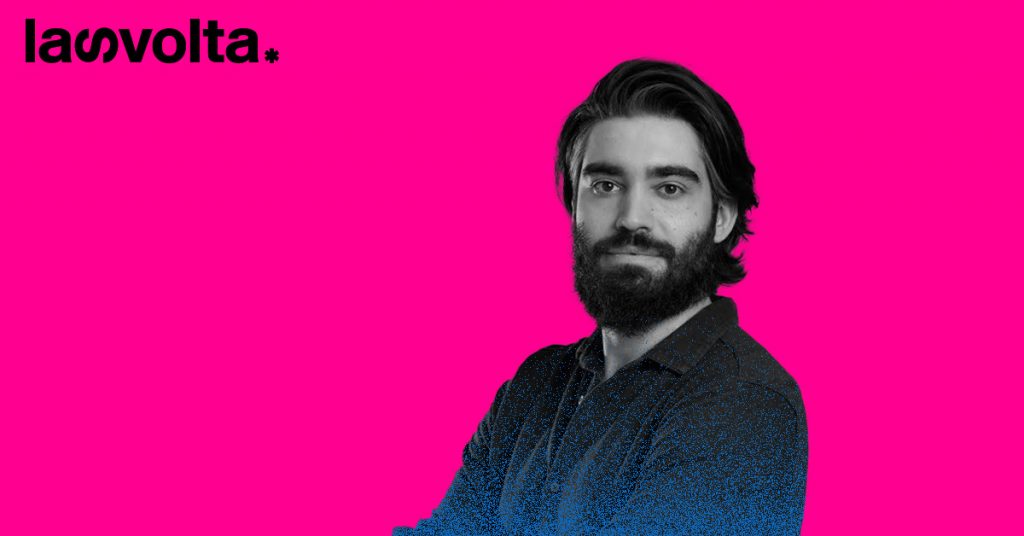
Classe 1990, originario di Cremona, inizia la sua carriera universitaria studiando Storia. Le sue passioni però sono altre e fremono dalla voglia di uscire allo scoperto. La musica prima, lacucinapoi. La sua notorietà arriva attraverso isocial, con i quali si afferma comefood bloggere, grazie ai numerosi viaggi, si crea un linguaggio tutto suo. Un’identità, per dirla come un social media manager. Le sue ricette diventano virali,cambiano col tempo e da onnivore diventano vegetariane, fino a trasformarsi invegane. Molto più di una decisione alimentare, una scelta etica presa dopo un viaggio in Corea che cambia la sua visione della vita. Una strada percorsa e descritta nelle 177 pagine delsuo libroHo mangiato troppa carne(CairoEditore)dove si intervallano epidemiologi, nutrizionisti e studiosi in merito alleconseguenze salutari e ambientali degli allevamenti intensivi.Ma non solo. Stiamo parlando diLorenzo Biagiarelliche, se fino a pochi giorni fa era conosciuto da “pochi” (o meglio, da una community di 230.000 follower), oggi si trova in cima ai titoli di giornale.Prima ancora che scoppiasse il caso mediatico,La Svoltaaveva intervistato Biagiarelli per parlare della necessità di una presa di coscienza sugliallevamenti, sulle condizioni degli animali che ci vivono e sul bisogno uncambiamento sociale.Un’inversione di rotta che deve partire da tutti noi. È sempre stato un amante della carne, sia come consumatore che come cuoco: come è nata la decisione di non mangiarne (né cucinarne) più? È iniziata per una somma di fattori, pratici ed etici. Quello scatenante è stato sicuramente l’asserzione di Selvaggia (la sua compagna, Selvaggia Lucarelli, giornalista,ndr) tornati dalla Corea: non mangio più carne. È nata quindi come ricerca di una nuova economia familiare. Poi, però, pensandoci a fondo quel viaggio aveva segnato anche me. Avevamo mangiato moltissima carne e da lì ho cominciato a riflettere su diversi aspetti, come per esempio che per loro sia legale mangiare il cane. Così mi sono chiesto se gli animali con cui siamo abituati a nutrirci in Italia fossero meno importanti. È stato un viaggio rivelatore.La Corea è un Paese che ti mostra palesemente l’esistenza di un problemache, se viene colto nella sua interezza, non si può ignorare. A quel punto l’ho tolta non solo dal mio menù, ma anche dalla mia dieta. Quanto impattano, a oggi, gli allevamenti intensivi sulla salute e sull’ambiente? È un problema matrioska dove il cuore è la condizione animale. Perché se la prima domanda da porci è se sia giusto ammazzarli per vivere, la seconda è se sia corretto farli vivere in quelle condizioni. La risposta, per entrambe, non può essere che no. Gli allevamenti intensivi impattano molto sull’ambiente: basti pensare che la Lombardia è la Regione con la qualità dell’aria peggiore d’Europa e anche durante il lockdown, con le macchine ferme, non è migliorata. Questo perché a riguardo contribuiscono molto di più gli allevamenti rispetto alle emissioni delle auto. Esiste quindi una problematica sia locale che globale legata al comparto zootecnico. E poi sì, incidono sulla salute perché mangiare così tanta carne ha conseguenze enormi sulle molte patologie, specie dell’apparato digerente. Inoltre c’è tutto il discorso degli antibiotici somministrati agli animali e che, inevitabilmente, arrivano anche a noi. Non per caso è uno dei più grandi problemi della salute pubblica. Secondo lei, a che punto siamo in Italia sulla presa di coscienza di questo problema? Abbiamo preso coscienza del fatto che gli allevamenti intensivi sono una cosa brutta e questo è un bene. Ma non abbiamo ancora realizzato che in Italia sono il modo in cui si produce regolarmente la carne. Mi spiego: come popolazione siamo abituati a dissociare le nostre eccellenze culinarie dagli allevamenti intensivi, come se i nostri piatti non fossero collegati a questi. Ma basterebbe pensare che all’anno vengono prodotte 10 milioni di cosce di maiale, e solo per una singola DOP, per capire che non è così. Per riuscire ad avere una vera presa di coscienza dovremmo riuscire a ricongiungere questi due estremi. Parliamo di spreco: i dati sono allarmanti, li ha descritti anche lei in diversi interventi (ci aggiriamo intorno a un terzo del cibo acquistato). Cosa si può fare contro questo fenomeno? Per citare una frase che diceva sempre mia nonna “Màia de meno”. Letteralmente? Mangia di meno. Noi mangiamo molto di più di quello che dovremmo, sia per la nostra salute, sia per mantenerci in forma. Assumiamo circa il 50% di calorie in più al giorno e questo si traduce in un eccesso di produzione e, dunque, un eccesso di spreco. Sono numeri: ogni anno vengono uccisi circa 80/90 miliardi di animali a scopo alimentare. Di questi, 18 miliardi muoiono prima ancora del macello, negli allevamenti. E questi ultimi non vengono nemmeno menzionati, perché si considera spreco qualcosa nel momento in cui diventa cibo. Il suo libro,Ho mangiato troppa carneè un viaggio fra luoghi, alimenti, e interventi di studiosi. Perché la scelta di non scrivere solo la sua testimonianza? Credo che oggi più che mai sia necessario far parlare chi sa le cose. E che i fatti li esponga chi li studia. Io non sono un epidemiologo e per esprimermi su temi come la salute avevo bisogno di un professionista specializzato in un campo il più ampio possibile. L’epidemiologo questo fa: si occupa delle patologie che comprendono una vasta fascia della popolazione, non si interroga solo su epidemie influenzali. Per questo ho chiamato Pier Luigi Lopalco che anche durante il Covid è sempre intervenuto con grande competenza e conoscenza. Poi, Gabriele Bernardini, un bravissimo biologo e nutrizionista. Tenevo molto alla sua opinione perché, fra le altre cose, non è vegano e volevo che emergesse solo il lato scientifico della questione e quindi ho cercato professionisti non di parte. Come Gianfranco Bologna, presidente comitato scientifico del WWF. Ho scelto esperti più autorevoli possibili, liberi da interessi e che raccontassero la storia che volevano raccontare. Questo perché molto spesso sapere i dati non equivale a saperli descrivere. Nel libro vengono citati due eventi: la sua visita all’allevamento Fenati e la rivolta dei clochard del 2016 contro lo chef Simone Salvini. Del primo, cosa ha provato entrando lì e riguardo al secondo, secondo lei, cosa significa? Sono entrambi un simbolo molto importante. La strage dei volatili all’allevamento fa interrogare e riflettere sul fatto che tutti gli animali sono uguali. Non ne esistono alcuni che devono morire e altri no. Su quello dello chef Salvini, invece, non mi sento di colpevolizzare i clochard. Loro sono l’ultimo anello di un sistema malato che fin dalla tenera età ti spinge a pensare che la carne sia il nutrimento migliore che tu possa avere. Credo che quel fatto sia proprio lo specchio di una società in cui tutti, dal nutrizionista al medico, la consigliano. I clochard in quel momento si sono visti togliere l’unica cosa che credevano ancora giusta e che li collegava alla condizione di essere umano. Ma allora vien da chiedersi, che mondo è diventato quello in cui se non c’è carne non c’è umanità? Come ha reagito il suo pubblico (social principalmente) alla notizia di non mangiare, né cucinare più carne? Come in tutte le cose, molti l’hanno capito e altri non seguono più la pagina. Mi ha un po’ stupito perché secondo me sono posizioni molto più ideologiche che fattuali, non credo che un onnivoro non possa seguire un vegano. Io non ho mai avuto un piano editoriale, ma semplicemente raccontavo (e racconto) ciò che facevo. Non vedo più molti commentatori storici, quello sì, ma c’è molta gente nuova. Forse c’è più contenuto. E fra queste ha notato differenze generazionali? Si dice che i giovani siano più attenti, è vero? Sì il pubblico si è abbassato molto anagraficamente ed è anche molto più femminile. Su questo parlano i dati, anche globali, non io: il 75% delle persone vegane sono donne. Per quanto invece riguarda il legame generazionale, non saprei, perché comunque i giovani sono anche quelli che riempiono il McDonald con il Crispy a 3€. Penso che per i ragazzi la carne sia semplicemente un fattore meno ideologico. Per loro non è più uno status symbol come poteva essere per i genitori. E su questo incide parecchio l’alimentazione e le abitudini, hanno una visione più libera in cui non per forza un alimento per essere buono deve avere carne o pesce all’interno. In che misura, una buona o una cattiva alimentazione impatta sul cambiamento climatico? Tantissimo. Basta considerare che per produrre alcune cose servono 15.000 litri d’acqua e per altre 50. Diciamo che il suo consumo fa parte del cambiamento climatico e di quello del nostro habitat. Oltre alle emissioni, tutto ciò che modifichiamo nel nostro ambiente si traduce in meno foreste che convertono anidride carbonica in ossigeno. Quello del cibo è un circolo che va considerato come tale. E quindi, non c’è in nessun modo una visione in cui mangiare verdura faccia peggio che mangiare carne. Colpisce molto la definizione che dà al consumo di carne: “dipendenza”. Perché la chiama così? Perché di fatto lo è. Non è una sostanza psicotropa, non dà assuefazione come il tabacco o l’alcol, ma è un consumo che è onnipervasivo. Lo fai senza pensarci e se quando ci pensi non lo fai comunque ti dà fastidio. Evitare di mettere il bacon in un piatto, o il guanciale nella carbonara, sono cose che fanno sentire male. Sotto sotto il consumo è condizionato da questa dipendenza che è frutto del sistema di tradizioni, valori, storia e cultura che cerco di raccontare nel libro, ma anche nella vita. La prima cosa da vincere è quindi riuscire a non considerarla più come un prolungamento naturale della forchetta sempre e a prescindere. Come cuoco, secondo lei, si può cambiare il concetto di mangiare carne? Come? Io penso che si possa cambiare il concetto di che cos’è tutto il cibo, a partire dagli chef. È vero che nel nostro Paese c’è ancora la predominanza della figura della nonna come terminale culinario rispetto ad altri. Ma è l’alta cucina che ci distingue ed è un tratto ormai diventato identitario per la nostra cultura. Questo ha una grande presa sulla stampa e sulla comunicazione. Gli chef hanno la responsabilità di cambiare l’alimentazione ancora prima che nelle case: perché in famiglia serve un lavoro quotidiano, più lungo, ma fuori può essere d’ispirazione. E quindi, è un traguardo raggiungibile, arrivare al momento in cui non mangeremo più carne come consuetudine? Sì, noi probabilmente non ci saremo più, ma non ci metterei la mano sul fuoco, i cambiamenti in questo momento sono molto repentini. Però accadrà perché per prima cosa ce lo chiede il mondo e poi perché le voci che raccontano cosa significhi consumare carne si stanno moltiplicando. Credo che sia più difficile pensarlo e immaginarlo ora, quello che sarà fra 50 anni. Sarà meno difficile viverlo, come tutte le evoluzioni. Abbiamo già abbandonato molte abitudini alimentari nel corso dei secoli e dei decenni, eliminare anche questa non è inverosimile. In questo periodo ha scoperto molti alimenti che che non conosceva, riuscirebbe a fare un esempio della sua nuova tavola? Beh, non sono stato un grande consumatore di Seitan, Tofu e Tempeh prima di questo cambiamento. O meglio li conoscevo, ma non praticavo la loro cottura su base quotidiana. Ora sono 3 delle cose sempre presenti nel mio frigorifero, assieme a condimenti che prima non utilizzavo. Prima c’era il burro, che è onnipervasivo e sta bene con tutto. Oggi cerco di non mangiarlo e quindi ho scoperto che si possono ricavare tantissimi sapori aggiungendo spezie, pepe bianco e l’olio d’oliva, per esempio. Un altro alimento sono i fagioli. Possono dire di aver iniziato seriamente a mangiare verdura, cosa che chiunque dovrebbe fare. Pensi che dovremmo assumerne un chilo, tra frutta e verdura, tutti i giorni e l’italiano medio non arriva a due etti. Cosa potremmo fare in Italia in merito, sia per contribuire alla presa di coscienza sia nel pratico al bene ambientale e della nostra salute? Trovare voci pubbliche. Perché il tema è arrivato ai media, in televisione e nei programmi, ma non ci sono personaggi famosi vegetariani o vegani. Forse 3 o 4. Uno è Jovanotti che però ha sempre detto di non voler fare proselitismo, anche se in realtà sarebbe molto utile. Ha fatto una scelta alimentare guidata dall’etica e se la ragione è etica la scelta non è solo alimentare. Il veganismo non è collegato esclusivamente a quello che si mangia o si indossa, ma al rapporto con il mondo, con le persone e gli animali. Servirebbe la voce di tutte quelle persone che potrebbero avere anche solo una piccola influenza, perché in Italia sono ancora tutti molto spaventati sul tema.