Cingolani immagina il futuro green dell’Italia
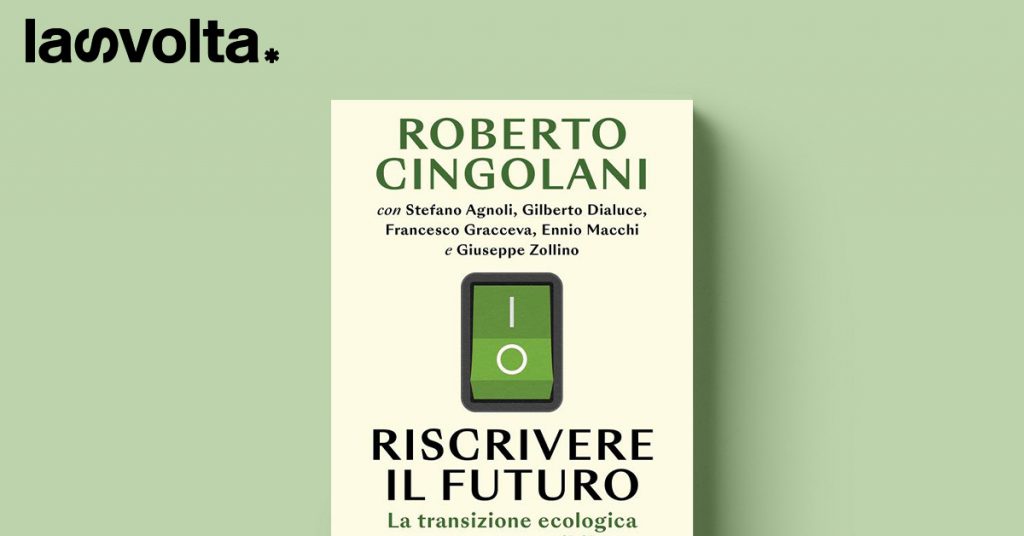
Per«riscrivere il futuro»ed evitare gli scenari peggiori dellacrisi climaticaserve rubare un po’ di speranza e ambizioni dagli«ideologi della transizione ecologica».Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione Ecologica e ora consigliere per l’energia del Governo Meloni, nel saggioRiscrivere il futuro. La transizione ecologica equa e accessibile,edito daSolferino,prova a tracciare lo stato dell’arte dell’energia in Italia e a immaginare futuri scenari per ladecarbonizzazione. Se la sua analisi dellacrisi climaticae delle cause scatenanti è lucida e puntuale, quando si tratta di descrivere le possibili soluzioni, la visione di Cingolani sembra peccare di poca ambizione. L’impressione è che le speranze riposte nello sviluppo di tecnologie comel’idrogeno verde o il biogas, condivise da gran parte del tessuto industriale italiano, non tengano il passo reale e devastante della crisi climatica, sempre più evidente, dopo fatti tragici come lealluvioni in Emilia Romagna. Il primo capitolo del saggio è un compendio semplice e completo sulla crisi climatica. L’autore spiega in maniera chiara la gravità e laportata dell’impatto dell’aumento delle temperature globali: dallo scioglimento deighiacciai, all’innalzamento del livello dei mari, fino alla perdita di biodiversità. Insiste più volte sulledisparitàcreate dal degrado ambientale, con attenzione alle questioni della giustizia climatica, delle differenze nelle emissioni tra i Paesi industrializzati e quelli meno abbienti e delle sfide presentate, a livello di inquinamento, dalla crescita economica degli Stati emergenti, comeCina e India. «Abitiamo un Pianeta dove si consumano ogni anno circa180.000 terawattoradi energia: cioè180 milioni di miliardi di wattogni ora. – scrive – I terrestri sono otto miliardi, ma non sarebbe realistico dividere i miliardi di watt consumati ogni ora per gli abitanti del pianeta». Anche il contributo deicombustibili fossili, ormai riconosciuto dalla maggioranza dellacomunità scientifica, viene espresso senza ambiguità, così come l’urgenza di agire, con misure di mitigazione e adattamento, su tali fenomeni. Nonostante questo però, l’autore sovrastima il tempo a disposizione dell’umanità per limitare il surriscaldamento globale.«Senei prossimi vent’anninon agiremo con continuità e determinazione assisteremo a un deterioramento devastante dell’ecosistema aprendo le porte a una catastrofe antropologica». La soglia di 1,5 ° dall’era preindustriale, raccomandata dall’Ipcc(Intergovernamental panel on climate change) per evitare eventi meteorologici incontrollabili, secondorecenti studipotrebbe essere superata nei prossimi anni.Gli interventi proposti da Cingolaniperòsembrano guardare solo agli ultimi traguardi posti dall’Unione Europea, per il 2050. Una transizione istantanea da un modello economico basato supetrolioe gas a uno con una forte presenza di rinnovabili è certamente difficile, soprattutto nel contesto di crisi creato dallaguerra in Ucraina.«Sarebbe come pensare che spegnendo una caldaia i caloriferi smettessero all’istante di emanare calore», dice l’autore. Nel descrivere lacomplessità del passaggio, che costringerebbe«fasce sociali, comunità e distretti locali a farsi carico di unatransizione ecologica che, se indiscriminata, risulterebbe iniqua», trascura leopportunitàche esso potrebbe comportarea livello di salute, benessere, ma anche dioccupazione. In particolare, sembra dimenticarsi delledisuguaglianze, sia nell’emissioni sia nell’impatto dell’emergenza ecologica, tra le varie popolazioni, che cita nel primo capitolo del saggio. Quando parla dei progressi green del nostro Paese,Cingolani si accontenta dello status quo e dei piccoli risultati, affidandosi un po’ troppo alle speranze nell’efficienza delle tecnologie ancora in via di sviluppo, come l’idrogeno verde. Secondo i dati raccolti daOpenpolis, Roma ha un ritardo consistente nel raggiungimento degli obiettivi delGreen Dealeuropeo, sull’elettrificazione del suo parco macchine e sull’implementare sistemi rinnovabili. L’ex ministro però commenta:«L’Italia, quasi in solitudine, è riuscita così anche a mantenere salda la rotta della transizione ambientale, affrancandosi dal gas russosenza ricorrere ad alternative energetiche obsolete e inquinanti.– ma ammette – Contemporaneamente ha riportato a regime per un periodo limitato le centrali elettriche a carbone funzionanti». Perché i suggerimenti, proposti nel saggio, per una giusta transizione, riescano a tenere il passo delle sfide della crisi climatica, all’autore servirebbe un po’ più di ambizione. La stessa che rimprovera aGreta Thunberge agliattivisti climatici, considerati ideologi, slegati dall’attualità, e attivi soprattutto sui social. Giustamente l’autore afferma che «la protesta – riferendosi a quella dei Fridays for future – ha valore solo se entro un tempo accettabile giunge aproposte concrete». Cingolani sembra però trascurare o sottostimare iprogetticoncreti, a livello locale e nazionale, su comunità energetiche, trasporti e altri temi ambientali,realizzati nel corso del tempo dai movimenti ambientalisti. L’azione più significativa in Italia è stata probabilmenteL’agenda climatica,presentata proprio dal gruppo di Thunberg, prima delle elezioni di settembre 2022. «Non esiste una bacchetta magica (o un «silver bullet») che possa risolvere i problemi energetici e ambientali in modo semplice e uguale per tutti. Non esiste cioè unasingola tecnologia o soluzione energeticache possa contemporaneamente soddisfare il fabbisogno di energia, le necessità socioeconomiche e le istanze ambientali» riconosce lucidamente l’autore. Continuare a sperimentare e a cercare nuovi metodi per decarbonizzare le nostre economie è doveroso. Però per riscrivere il futuro e dotarci di un mix energetico, allo stesso tempoefficiente o green, serve innanzitutto credere nelle potenzialità delle fonti che abbiamo a disposizione, in primiseolico e fotovoltaico, in modo da implementarle in maniera coerente con i nostri obiettivi.