E no, “così non schwa”
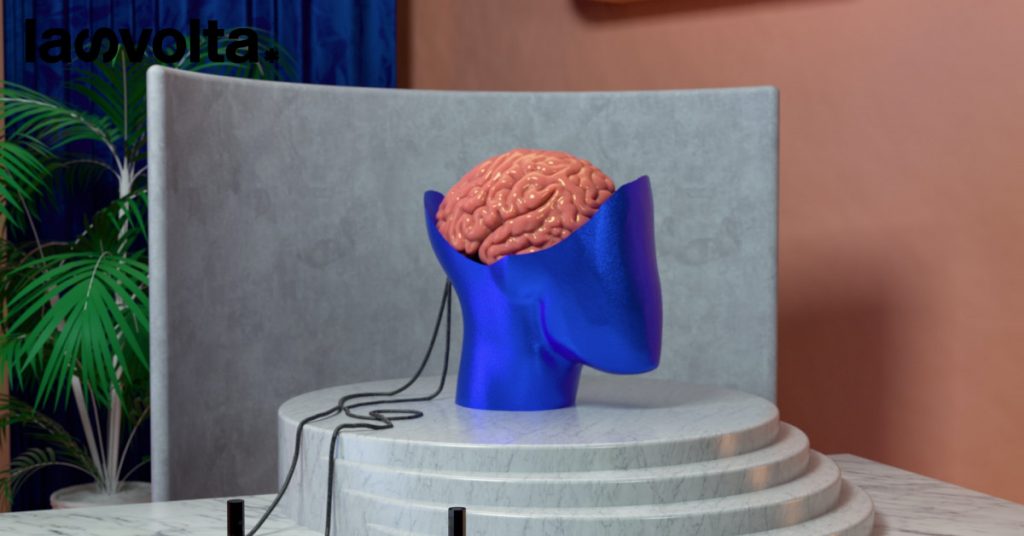
“A tutti”. Con questa dedica Andrea De Benedetti apre il suo libroCosí non schwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo(Einaudi Editore): non con “A tutti e tutte” o“A tuttə”.Così, già dalle primissime parole, è possibile capire dove la lettura condurrà lettori, lettrici e (forse più importante) lettorə. «Le lingue sono organismi vitali che rispondono abisogni pratici più che etici- si legge nel libro – Devono garantire unacomunicazione fluida ed efficaceprima di farsi veicolo di istanze simboliche e identitarie». Parliamo quindi della volontà delle singole persone di deciderecome venire chiamate: che sia avvocata anziché avvocato, che sia ragazzə anziché ragazzo o ragazza. La “nota dolente” che viene evidenziata (nel libro e, in generale, in tanti altri contesti) è la difficoltà di lettura, di pronuncia e di comunicazione dellinguaggio inclusivo. «Questo piccolo pamphlet – continua il libro – serve a ricordare che la lingua può concorrere a “creare mondi” ma chele diseguaglianze risiedono essenzialmente nelle cose: nei diritti negati, nelle discriminazioni, nel gender gap, nella cronica mancanza di donne in posizioni apicali, nel sessismo quotidiano». Quindi dovremmo relegare la questione linguistica in secondo piano? Forse, ma non è anche vero che, essendo le parole il principale mezzo di comunicazione, sono proprio queste adare senso e significatoa ciò che diciamo/scriviamo? D’altronde, come spesso ripetiamo,le parole sono importanti. Sono così importanti perché capaci di cambiare e formare il nostro pensiero sui più disparati temi. Anche De Benedetti sembra essere d’accordo: «Questo non significa che la lingua non abbia una suaprofonda valenza simbolica, che non condizioni il nostro modo di pensare e agire […] Non bisogna però mai dimenticareche il cuore del problema sta quasi sempre altrove». E qui ritorniamo sulgender gap, sulsessismoquotidiano, sullediscriminazione razziali, sull’abilismo.Ma, di nuovo, non è forse il linguaggio un buon punto di partenza (non l’unico) per scuotere i pensieri e sensibilizzare le persone al cambiamento? Nonostante il focus sia lo schwa, il libro analizza le parole anche dal punto di vista“maschile/femminile”,spiegando come in realtà questo mancato binarismo sia una convenzione «che aiuta i parlanti a gestire in maniera snella ed efficace il sistema degli accordi […] Il fatto che poi le donne non riescano ancora araggiungere posizioni apicaliresta certamente un enorme problema, anzi il problema, ma la morfologia a quel punto non c’entra più nulla». Tornando allo schwa, il capitolo tre analizza icosti e i beneficidi questo discusso simbolo: permette di superare il maschile sovraesteso, di comunicare correttamente (e rispettosamente) con una persona anche quando non si conosce il genere, «cancellerebbe dalla lingua il privilegio maschile di marca patriarcale». Maa che prezzo,si chiede De Benedetti? «Si tratterebbe di impiantare un suono nuovo pressoché dal nulla. In che modo? […] Di sicuro non basta confidare nell’evoluzione spontanea della lingua». Eppure, grazie allo schwa, a questa “e” a testa in giù, moltissime persone trovano un modo diraccontarsi e identificarsi con linguaggio. E, per questo motivo, tuttə noi potremmo (per non dire dovremmo) fare più attenzione, così da rendere reale la diversità del mondo. Perché, come spesso ribadisce la sociolinguista Vera Gheno, ladiversità è ricchezzae deve essere nominata con le giuste parole. Non è proprio questo il loro potere? Dare forma ai pensieri? Intanto, mentre ladiatriba tra “sì schwa” e “no schwa”continua, noi ci facciamo attenzione e continuiamo a utilizzarlo. Con tuttə.