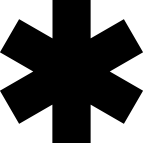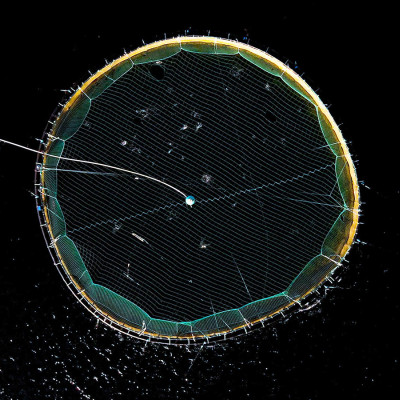Educazione ambientale, questa eterna sconosciuta

L’educazione ambientale nelle scuole italiane è una materia sussidiaria, vale a dire che stringi stringi, dipende dalla buona volontà dei singoli istituti o, peggio, da quella di pochi docenti illuminati.
Dal punto di vista legislativo le norme non mancherebbero. Questo insegnamento è stato introdotto nel nostro paese nel 1986 con la legge quadro sulla protezione dell’ambiente in base alla quale è fatto obbligo per le scuole di includere tale percorso formativo nei curricula e di promuoverlo attraverso attività e progetti specifici.
Sono seguiti poi: il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ha introdotto il Piano di gestione dei rifiuti urbani e ha sancito l’obbligo per gli istituti scolastici di promuovere tematiche relative alla gestione dei rifiuti; la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha istituito la figura del Referente scolastico per l’educazione allo sviluppo sostenibile; il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 129 del 3 aprile 2013, che ha varato il Piano nazionale per l’educazione ambientale con relativo impegno da parte delle scuole di partecipare a iniziative e progetti nazionali e locali; il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, che ha introdotto la figura del Referente per l’ambiente, il cui compito è promuovere la conoscenza delle tematiche ambientali tra gli studenti, il personale docente e non.
In sintesi, sulla carta le scuole in Italia sono tenute da vincoli giuridici a offrire lezioni di educazione ambientale per tutti i livelli di istruzione. Ciò però solo integrando tale insegnamento in materie differenti come scienze, geografia, educazione civica e tecnologia.
Ovviamente si potrebbe fare di meglio. Per esempio, introdurre un percorso obbligatorio e a sé stante e solo successivamente integrarlo a tutte le altre discipline, in modo da creare una cultura della sostenibilità che permei l’intero sistema educativo.
I docenti, naturalmente, dovrebbero essere i primi a ricevere una formazione specifica così da trasmettere ai nostri giovani le conoscenze necessarie per comprendere e affrontare i problemi connessi alla preservazione e alla rigenerazione del nostro patrimonio naturale.
Le scuole poi, dovrebbero compiere lo sforzo di promuovere progetti concreti che coinvolgano gli studenti in attività pratiche, come la gestione dei rifiuti, la creazione di orti didattici o la produzione di energia rinnovabile. Anche collaborando con le comunità locali e al di fuori del contesto prettamente scolastico.
Ma la realtà da noi è un’altra, poiché all’atto pratico la gran parte degli istituti non dispone di risorse e competenze necessarie per fare fronte a quanto richiesto dalle norme vigenti. Grasso che cola se i nostri figli vengono coinvolti in sporadiche visite all’orto botanico della città o nella piantumazione di due alberelli nei sempre più scalcinati parchi metropolitani.
In Italia, dunque, l’ambiente resta purtroppo fuori dalle classi; stanze dove, tanto per dirne una, i cestini per la raccolta differenziata sono una rarità. Così molto spesso gli alunni si vedono costretti a gettare torsoli di mela, bottigliette di vetro, fogli di carta e contenitori in plastica o in tetra pack, in un unico calderone, in barba alle più elementari regole di tutela ambientale.
L’apice della diseducazione avviene poi nelle mense dove, in nome di una igiene ormai convertita in asetticità, ogni alimento viene distribuito con la sua bella (si fa per dire) confezione in plastica monouso, ovvero non riciclabile.
In una scuola elementare di un quartiere popolare di Roma, nell’arco della settimana vengono distribuiti, tra merende e pasti, pizzette rosse e bianche, cracker, muffin, crostatine, biscotti, panini, yogurt e frutta.
Raccolti e pesati i relativi imballaggi abbiamo stimato che ogni bambino produce suo malgrado 9,4 grammi di plastica al giorno, ovvero 47 grammi a settimana che, moltiplicati per una media di 20 alunni, fanno 940 grammi di polimeri immessi nell’ambiente da ogni classe in cinque giorni di scuola.
In un istituto di dimensioni medio-piccole, diciamo di 5 sezioni per un totale di 25 classi, ciò si traduce in 23,5 chilogrammi di plastica a settimana, che diventano 94 in un mese e 846 in un anno scolastico (da settembre a giugno). Considerando che nel nostro paese ci sono circa 30.000 scuole primarie otteniamo il quantitativo annuale shock di almeno 25.380 tonnellate, più o meno il peso di due torri di Pisa.
Ora, lungi da noi sostenere che gli istituti scolastici siano tra le cause principali dell’inquinamento da plastica nel nostro Paese, ma è fuori di dubbio che il messaggio che passa è in molti casi tutt’altro che educativo.
A eccezione di pochi comuni virtuosi, non solo la formazione ecologica è carente, ma si fa passare quella logica malsana secondo cui diversamente proprio non si può fare. Invece non è così. Basterebbe che le suddette confezioni fossero in materiale organico (bioplastica o meglio ancora carta) e che fossero impiegati contenitori riutilizzabili in acciaio inossidabile o in alluminio.
Insomma, non sta a noi fornire soluzioni, ma è certo che un’alternativa c’è. Sarebbe sufficiente prendere esempio da quanto avviene in Paesi all’avanguardia in questo campo come la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, la Germania e il Canada. Sia chiaro, non fanno niente di straordinario: semplicemente varano le leggi e le rispettano.
Educare attraverso l’esempio – diceva Albert Einstein - non è una maniera di educare, è l’unica. Noi che modello intendiamo fornire alle future generazioni?