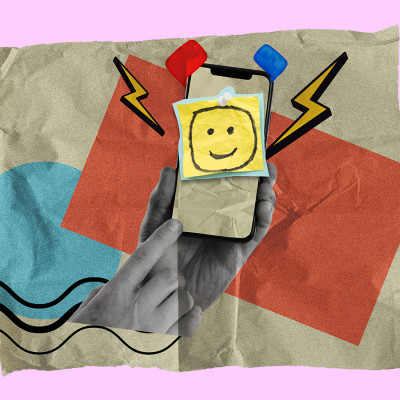Perché supportiamo le cause ma odiamo gli attivisti?

- Indice dei contenuti
- La rabbia
- La colpa
- La responsabilità
All’inizio ci furono Greenpeace e Peta; per alcuni anni le Femen rubarono la scena in tanti eventi internazionali; in seguito arrivò Greta Thumberg, poi Extinction Rebellion e Ultima Generazione, solo per citare i movimenti più famosi.
Militanti. Aggressivi. Mascoline. Indecorose. Terroristi. Polemici e polemiche. Odiano gli uomini. Odiano gli altri. Egoisti. Hippy. Sporchi. Pelose. Frigide.
Queste sono, semplificando e al netto degli insulti, le parole con cui viene descritto chi fa attivismo. Ed è particolarmente importante soffermarsi sui significati più estesi che queste parole portano con sé, perché a livello semantico ci possono fornire chiavi di lettura connotative interessanti.
È importante perché l’attivismo conta. Sembra più necessario che mai. Ed è più visibile di quanto non lo sia stato da decenni, con nuovi movimenti che emergono per sfidare problemi vecchi e sempre più urgenti, come Black Lives Matter, Me Too e gli scioperi scolastici per il clima.
Mi sono chiesta perciò, negli anni di attivismo, come mai ci sia questa percezione diffusissima per la quale le cause sono fondamentali (nessuno si direbbe contro la parità di genere, la violenza contro le donne o la distruzione del Pianeta) ma chi fa attivismo è visto nella migliore delle ipotesi come una persona un po’ strana, esagitata, insomma: fuori dalla realtà.
È singolare che chiunque supporti le cause, ma nessuno abbia voglia di dirsi ambientalista o femminista. Perché succede questo?
Mi sono data alcune risposte che hanno come centro tra parole chiave: rabbia, colpa, responsabilità.
La rabbia
Difficile non pensare alla rabbia come motore di cambiamento quando abbiamo a che fare con le proteste, sociali o ambientali; ma la rabbia non è che l’altra faccia della medaglia che ha su scritto: impotenza.
Non ci piace sentirci impotenti di fronte a qualcosa, esattamente come non ci piace sentirci arrabbiati, perché culturalmente questa emozione è connotata come negativa. In realtà, esattamente come le altre, non è giusta né sbagliata: semplicemente è umana. E la proviamo quando qualcosa non va come vorremmo, quando qualcuno si comporta in modo che disapproviamo, anche noi stessi. Più in generale quando un nostro bisogno non è soddisfatto.
La rabbia, nelle sue varie sfumature, è quindi innanzitutto l’allarme di qualcosa che per noi è insoddisfacente. È particolarmente complesso venire a patti con la rabbia in un contesto sociale e culturale volto a controllare ciò che viene visto come negativo. Gli aspetti della nostra personalità che rinneghiamo (che la nostra cultura e la nostra famiglia ci insegnano come inaccettabili) diventano aspetti scissi dal nostro sé. Individuandoli e giudicandoli negli altri ci forniscono un’eccellente copertura da queste proiezioni.
La rabbia può rimanere impigliata in altre fonti personali di reattività. C’è la battaglia per tutta la vita con le figure autoritarie nella nostra infanzia, per esempio. C’è la rabbia indossata come una maschera abituale per altri sentimenti che non possiamo esprimere, in particolare per gli uomini a cui è stato insegnato che altre emozioni compromettono la loro mascolinità. E c’è la rabbia che copre il dolore. Può essere più facile infuriarsi contro chi lancia della zuppa su una protezione di plexiglass in un museo piuttosto che affrontare la nostra desolazione perché consapevoli di non avere gli strumenti di pensiero adatti.
Condannare la rabbia negli altri ci mette al riparo dal dover fare i conti con la nostra o la frustrazione che deriva da altre emozioni che proviamo a ricacciare indietro.
La colpa
Il senso di colpa è un’altra proiezione di questo tipo: sapere che c’è un problema ma non agire. Al di sotto di questa coltre c’è una complicità più profonda che non vuole essere riconosciuta. Il lavoro della studiosa femminista Sara Ahmed è incentrato sull’idea che coloro che descrivono il problema diventano il problema. Una reazione allergica all’attivismo aiuta a distogliere l’attenzione dal nostro ruolo personale nella questione presa di volta in volta in esame.
Oh, quanto ci mette in discomfort sentire un o una attivista che ci dice che siamo complici nel razzismo o nel sessismo quando ci definiamo progressisti! E quanto è più facile cercare, sempre di volta in volta, delle motivazioni anche molto articolate sul perché stiano sbagliando: saranno troppo emotivə, o troppo arrabbiatə. O comunque non è questo il modo di protestare. C’è sempre un’eccezione, una deroga. La stessa deroga la applichiamo su noi stessi, diventando l’eccezione del caso: non sto facendo niente ma posso proteggermi negando la mia responsabilità nella questione, senza intaccare la mia identità di persona buona. Insomma, il nostro cervello mette in campo un sacco di stratagemmi creativi quando si tratta di lavarsi la coscienza.
Non ci piace sentirci in colpa. Non ci piacciono le persone che ci ricordano, con parole e azioni, che non stiamo riciclando abbastanza plastica o prendendo posizione in ufficio con il collega che continua a fare scherzi offensivi sulle donne o sulla comunità Lgbtqa+. Non ci piace per nulla. Meglio concentrarsi, di nuovo, sulla zuppa sul plexiglass.
La responsabilità
Quanto siamo responsabili delle decisioni prese sopra la nostra testa o alle nostre spalle? 2 fattori importanti sembrano essere il nostro potere di influenzarle e la nostra conoscenza delle loro conseguenze.
Immaginiamo di essere sopra una nave. È piena di persone ma non tutte hanno la stessa voce in capitolo sulla direzione che la nave prenderà. Supponiamo che la nave stia andando dritta verso un iceberg. Ovviamente, le persone responsabili dell’imminente destino della nave sono quelle incaricate di governarla: il capitano, il navigatore e chiunque altro sia al timone con loro e possa influenzarli e salvare la nave e tutte le persone a bordo.
Ma cosa succede se le altre persone sulla nave, a esempio i passeggeri paganti, sono in grado di vedere l’iceberg? E se, inoltre, fossero in grado andare verso il timone e urlare al capitano che la nave deve cambiare subito rotta?
Ora supponiamo che non si tratti di un iceberg e che i passeggeri della nave non corrano alcun pericolo. La nave si sta dirigendo verso un banco di balene in via di estinzione ed è la stagione degli amori: stanno per dividere le povere balene proprio in uno dei momenti più importanti dell’anno, mettendo in pericolo la sopravvivenza della loro specie. In questo caso la responsabilità è meno facile da attribuire, soprattutto supponendo che nessuno degli esseri umani coinvolti sia consapevole del danno che sta per fare. Ma cosa succede se a bordo c’è un biologo marino che li avverte?
È chiaro che in situazioni come queste, in cui una formazione sociale è coinvolta nel causare un danno a se stessa o ad altri, ci sono alcuni fattori che incidono sul modo in cui assegnare responsabilità.
Uno è la distribuzione del potere: chi è al timone ha più potere di manovra di un passeggero qualunque ed è colui o colei che dovrebbe essere spinto ad agire prima. Un altro fattore è l’accessibilità della conoscenza: causare accidentalmente un danno (o non riuscire inconsapevolmente a prevenirlo) è chiaramente una questione diversa dal saperlo e farlo comunque (o saperlo e non fare nulla).
Rimane il fatto che chiunque sulla nave può vedere le balene e, ora che il biologo ha avvertito del problema, fare qualcosa. Chi lo farà e chi, invece, rimarrà sul ponte a dire che questo o quello non è il modo giusto di salvare le balene? Chi dirà che spetta al capitano o al timoniere fare qualcosa? Chi si arrabbierà contro quei passeggeri che vogliono strappare il timone dalle mani del capitano e virare?
Questo esempio, nella sua banalità, ci racconta in realtà molto di come le dinamiche dell’attivismo siano percepite sulla parte di popolazione che attivista non è.
Però di nuovo, esattamente come la zuppa sul plexiglass (e non sui Girasoli di Van Gogh) o la vernice lavabile su Palazzo Vecchio, è un modo quanto mai sofisticato di fare action policing: un tone policing rivolto alle azioni e non al modo di esprimere un’idea.
Ci concentriamo non sul contenuto fattuale o logico di un’azione ma sul modo in cui questa azione viene compiuta (troppo violenta, aggressiva, indecorosa etc.) ignorandone completamente l’utilità o lo scopo.
Lo dicevo, il nostro cervello inventa modi eccezionalmente creativi quando si tratta di non prendersi responsabilità. È il motivo per cui, tra le altre cose, siamo allergici a quelle che definiamo “etichette”. Amiamo l’ambiente e la parità. Ma no, noi siamo persone, mica ambientalisti o femministi.