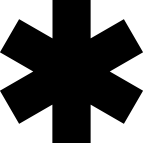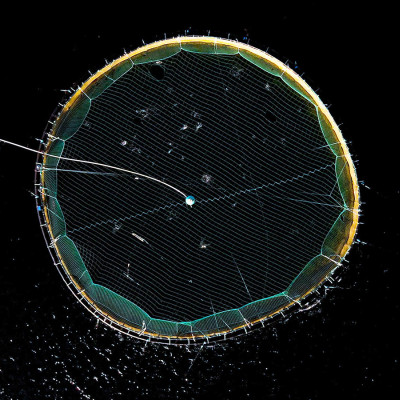Verità (anche) per Emanuela Orlandi

La risata sguaiata e isterica con cui Fedez, in Muschio Selvaggio, introduce una puntata dedicata a Emanuela Orlandi è l’ultima, inspiegabile beffa nell’infinita, triste vicenda legata alla ragazza romana scomparsa nel giugno del 1983. Ma non è certo la peggiore. Non a caso, il fratello di Emanuela, instancabile cercatore della verità, non punta alcun dito contro il rapper. Lo sovrasta moralmente, dichiarando di apprezzare in ogni caso chi parli di sua sorella: «Fedez lo ha fatto per un’ora dopo la risata»
A precedere l’ultimo ennesimo atto beffardo nei confronti di una famiglia sospesa da quel 22 giugno 1983 sono 40 anni di misteri, coperture, intrighi, affari torbidi con mafie e mafiette, connivenze che vedono sovrapporsi un numero infinito di attori ma che ruotano sempre attorno al luogo geografico, politico e spirituale in cui Emanuela viveva con la sua famiglia, il Vaticano.
Uscita nel pomeriggio di quel giorno, nel giugno ’83 per recarsi al corso di flauto vicino a Piazza Navona, la 15enne non vi ha fatto più ritorno. Da allora la vicenda, che inizialmente sembrava essere di semplice risoluzione, fin dai giorni successivi si è tinta di nero finendo per trasformarsi in uno dei misteri più importanti della storia d’Italia.
Per 40 anni esatti si è navigato a vista tra inabissamenti, atti eroici e penosi tentativi di insabbiamento e, se non fosse stato per i famigliari - il papà deceduto nel 2004, la madre, le 3 sorelle e Pietro, l’instancabile fratello - il caso sarebbe sepolto assieme alla verità.
Grazie, con molta probabilità, all’uscita sulla piattaforma Netflix di The Vatican Girl - prodotta dalla società inglese Raw, scritta e diretta da Mark Lewis - negli ultimi mesi la vicenda Orlandi ha vissuto una vera e propria accelerazione. Oltre ad aver fortemente animato il dibattito in Italia, e nel mondo, il prezioso docufilm ha suscitato grande scalpore e rafforzato le tesi di chi da anni punta il dito contro gli intrighi della Curia vaticana che arriva, in alcuni casi, a collegare il caso Orlandi agli scandali interni della Chiesa, finanche alle dimissioni di Benedetto XVI. La morte di quest’ultimo, poi, ha preceduto di qualche giorno la decisione di Papa Francesco di aprire (non riaprire, perché non era mai successo prima) un processo interno.
La serie, in 4 episodi, se possibile, aumenta la mole di oscura perplessità, mentre su una cosa non lascia dubbi: al centro dell’intrigo c’è il Vaticano. Le ipotesi sarebbero 2.
Papa Giovanni Paolo II, infervorato per le lotte politiche di Solidarność in Polonia - Sindacato autonomo dei lavoratori “Solidarietà” - e desideroso di sostenerle in chiave marcatamente anticomunista, lancia una campagna finanziaria con soldi poco limpidi di cui si occuperà il fido vescovo americano Paul Casimir Marcinkus a capo dello Ior - Istituto per le Opere di Religione - in collegamento col Banco Ambrosiano, che si rivolgerà alla mafia. A seguito del crack della banca e della indisponibilità di liquidi da restituire alle formazioni criminali, sarebbero state queste ultime a organizzare il rapimento di un elemento in qualche modo riconducibile al Vaticano, per chiedere riscatto e risarcimento.
L’ipotesi risulta debole: tutta la parte precedente alla sparizione di Emanuela è vera, ma è verosimile che la mafia decida di rapire una 15enne figlia di un dipendente vaticano senza alcun ruolo nella Curia e assolutamente ininfluente nei giochi di potere?
Più credibile la seconda pista che porta diritta agli scandali legati alla pedofilia che hanno travolto la Chiesa. Secondo alcune testimonianze di amiche della ragazza, Emanuela avrebbe subito le attenzioni di alti prelati nei mesi precedenti alla sparizione i quali, temendo per un’uscita pubblica e un successivo scandalo, si sono rivolti alla Banda della Magliana, con cui i vertici della Chiesa erano in stretto contatto. Prova ne è, tra le altre, l’incredibile sepoltura con tanto di sarcofago monumentale concessa a Renatino De Pedis, leader della nota formazione criminale, nella prestigiosissima chiesa di San Mercuriale a due passi da Piazza Navona, dal Cardinal Poletti (ndr).
Che cosa sia successo dopo, se sia stato deciso di ucciderla subito, rapirla e trasferirla per toglierla di mezzo senza arrivare all’omicidio, consegnarla ad altre forze occulte o altro, non è dato di saperlo. Chi siano, poi, i presunti alti prelati è una delle domande più inquietanti, forse la più importante. Di certo il livello è altissimo e qualcuno si spinge addirittura a chiamare in causa Giovanni Paolo II.
Su tutto grava oltre che la certezza del coinvolgimento del Vaticano, la scarsissima collaborazione degli organismi ecclesiastici preposti e di chi sa bene - o sapeva, dopo 40 anni molti sono morti - cosa sia successo. L’inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma, tra mille fatiche, si avvicina alla verità ma, quando la distanza si riduce, succede sempre qualcosa in Vaticano che la ristabilisce. Giancarlo Capaldo, il procuratore a capo delle indagini, ha di recente dichiarato a La Stampa: «Qualche prelato sa e ha fatto anche carriera. La Chiesa non ha mai collaborato, io ero vicino alla verità ma sono stato fermato». Non solo da esponenti del Vaticano, ma anche dalla Procura di Roma che, nel maggio 2015, con a capo Giuseppe Pignatone ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta.
Ora che il Vaticano, per scelta di Francesco, ha deciso di aprire un processo, le speranze di avere almeno bagliori di verità si rinfocolano. Riusciranno i magistrati vaticani a essere lucidi e a tirare fuori le evidenze anche se fossero pesantemente sporche come qualcuno sospetta? Certo, il fatto che a guidare il tribunale dello Stato della Città del Vaticano sia proprio quel Giuseppe Pignatone, che aveva frettolosamente archiviato 8 anni fa, chiamato a quel ruolo direttamente da Papa Francesco nel 2019, lascia qualche maliziosa perplessità.