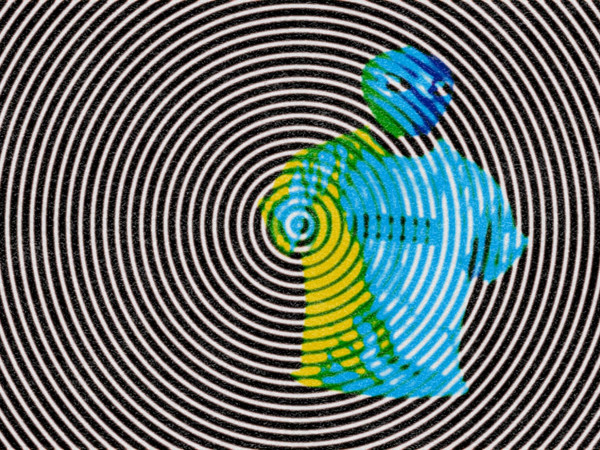C’era una volta una giornalista che sapeva quel che scriveva

C’era una volta una giornalista che si alzava alle cinque e mezza e andava a letto alle nove. Durante la giornata preparava merende e cene, accompagnava e riaccompagnava a scuola due ragazzini, suonava un po’ il piano, studiava il tedesco, lavorava e quando era triste andava a scuola prima ad ascoltare le voci dei bambini in giardino oppure, persino, in chiesa. Non tanto perché si sentisse particolarmente cattolica ma perché le sembrava l’unico luogo rimasto dove qualcuno ricordava che le atrocità commesse dalle persone – quelle che lei faceva fatica sempre più a sopportare – un giorno sarebbero state punite, che ci sarebbe stata giustizia.
Se le parole sono azioni
Con vent’anni di giornalismo alle spalle, lei sapeva esattamente cosa e come scrivere nei suoi articoli senza incappare in errori. Di più: aveva maturato un distacco sistematico dal mondo dei giornali inteso come cronaca ansiogena, titoli falsi e inutili, articoli emotivamente avvelenati, capaci di distruggere le giornate. Si dedicava all’approfondimento, al giornalismo come scoperta quasi scientifica, alla cura della parola, perché le parole sono azioni e possono essere come una violenza fisica, come quel dottorato su Hannah Arendt le aveva insegnato. Sui social network cercava di fare lo stesso: dopo molti anni e qualche errore, sapeva che il registro migliore era l’ironia, seguita dal racconto. Meglio scrivere meno che troppo, meglio rileggere due volte che una. Dedicava un’attenzione minuziosa a non mettere foto private e quando pubblicava una foto in strada si premuniva di cancellare persino le targhe visibili.
Un giorno venne a trovarla una sua cara amica da fuori Roma. Fu un incontro che la toccò, non so per quale motivo. Parlarono della fatica di tutti i giorni, della durezza dello stare in coppia, di quanto a volte ci si trovi di fronte a dilemmi dolorosi, restare insieme, lasciarsi. E della paura di restare povere, e dell’ansia verso i figli. La sua amica ripartì e fu allora che, forse, scrisse quel post, perché a dir la verità quando dopo ripensò al momento esatto in cui lo pubblicò non fu in grado di ricostruire nulla, come se si fosse cancellato dalla memoria. In sostanza prese una foto che girava in rete, su un politico che detestava - anzi peggio - e su sua moglie e disse che lei disprezzava non solo lui ma anche lei, attribuendo anche a lei la “connivenza” con i suoi (di lui) valori, essendone la moglie. Possibili attenuanti, come la povertà, il non potersi separare, non erano tali, la disistima era totale, scriveva.
Proteggersi dalla tempesta di pietre e fango
Che qualcosa fosse andato per il verso sbagliato lo capì quando cominciarono ad arrivare i primi messaggi, sempre più fitti, poi con un ritmo regolare, fino ad arrivare a centinaia e centinaia, sui suoi profili sociali. Messaggi tutti uguali, insulti, anche a suo marito e ai suoi figli, alcuni velate e meno minacce.
Una persona normale, magari un po’ fragile, soprattutto meno consapevole dei meccanismi delle reti sociali e del mondo mediatico avrebbe vacillato. La giornalista invece non lo fece perché non poteva farlo. Perché sapeva che se ti vuoi salvare in queste occasioni occorre la massima lucidità. Tolse il post incriminato dove ormai i commenti si contavano a centinaia, disattivò tutti i profili social.
Lo fece per due motivi: primo, perché quando una tempesta di fango e pietre ti sta scaraventando addosso tu devi toglierti e proteggerti, dunque non è pavidità ma legittima difesa. Secondo, perché voleva evitare che “quei” giornalisti potessero frugare nei suoi profili, con le loro mani sporche e il loro animo bestiale.
Ma non bastò. La macchina si era avviata e la giornalista nulla poté fare. Il post circolò probabilmente in qualche chat, fu ripreso da Matteo Salvini – l’inizio della fine – e il giorno dopo Libero e Il Giornale, fecero una paginata ciascuno con richiamo in prima, parlando di caccia all’uomo - Lorenzo Fontana, ndr - e a sua moglie, di “linciaggio” nella pubblica piazza, di odio viscerale, di riduzione a bestia e non uomo. Evocarono il fascismo, persino gli anni di piombo e la vicenda Calabresi. A cascata seguirono decine e decine di altre testate, che come cani di Pavlov ripresero il tutto senza azionare mai il pensiero, senza chiedersi cosa fosse accaduto e di che stessero scrivendo. Parlano di squadrismo radical chic, attacco choc, orrore, giornaliste che odiano le donne, gogna pubblica etc. Il pezzo finì sul Corriere della Sera.
Finiti i loro raid violenti, il giorno dopo si dedicarono ad altro. Intanto, avevano però distrutto una persona e una reputazione. Forse.
Post pubblici e inconscio privato
Forse perché in verità la giornalista rimase quasi indifferente a tutto questo. Sapeva che quella persona contro cui era stato gettato tanto fango non era lei. Che nessuno sapeva niente di lei - appassionata di libri per bambini, spartiti musicali e biografie di santi - che si era trattato di una operazione politica, mediatica volutamente diretta a strumentalizzare per diffamare e distruggere. Non era la prima né sarebbe stata l’ultima. Provava più che altro un senso di stupore. Soprattutto verso se stessa.
Perché aveva scritto quel post sgangherato e in parte assurdo, anche se quasi certamente non passibile di diffamazione? Anche mettere la foto era senz’altro sbagliato, anche se quella foto – le sembrava – era stata ripresa in un contesto totalmente pubblico, infatti girava ovunque e anzi qualche giorno dopo il settimanale Gente la riprese a piena pagina. Forte di anni e anni di analisi, non ci mise molto a capire che il suo inconscio forse le aveva giocato un brutto scherzo. Forse, paradossalmente, si era identificata nella donna verso cui aveva espresso disprezzo e di cui in effetti nulla sapeva. Forse il tema del post - stare in coppia, separarsi o non separarsi, i bambini - la riguardava più da vicino.
Questo la tranquillizzò in parte, anche se non placò l’indignazione che pure c’era. E che aveva a che fare con quello che a suo avviso era una incredibile, gigantesca, macroscopica sproporzione: quella tra un post scritto su un profilo, neanche la sua pagina ufficiale, e paginate sui giornali nazionali con richiamo in prima, decine e decine di pezzi, linciaggio vero sulla pubblica piazza. Ancora di più la indignava il metodo, tanto sottile quanto violentissimo: prendere un frammento da un contesto e lanciarlo nello spazio mediatico, in modo da assegnargli – in quel modo – la violenza che in sé non aveva.
La giornalista incontrava gente che le diceva stupita e irata “Cosa hai scritto??”, come se ciò che aveva scritto lo avesse messo in un discorso in televisione a reti unificate, in un discorso parlamentare, come se ci avessi costruito sopra un film, uno spettacolo di teatro, come se avesse preso un megafono e fosse andata in tutte le piazze di Italia a urlarlo. Niente di tutto questo era accaduto, ma l’aver assegnato al post quella visibilità assurda che mai avrebbe avuto lo aveva reso un proiettile. Scagliato poi contro la giornalista. Cioè contro di me.
Un mondo mediatico senza gerarchie tra contenuti
La morale di tutto ciò è tanta e la porrò sotto forma di domande, lasciando da parte quelle su un Ordine dei giornalisti che non fa nulla, non interviene, non ha più alcun senso e alcuna funzione. Anzitutto: è possibile vivere in un mondo mediatico dove non ci sono gerarchie tra contenuti? Dove una parola è uguale a un’altra, indipendentemente da dove e in che contesto e con quale visibilità è stata detta? Proprio su questa eguaglianza giocano queste macchine del fango. È ovvio che il fatto che io fossi giornalista aveva un peso, ma la fine, appunto, delle gerarchie è un fenomeno devastante.
In secondo luogo: questa cosa è accaduta a me che ho spalle emotive e professionali forti. Ma cosa sarebbe successo se al posto mio ci fosse stata una persona fragile? Esattamente come quegli adolescenti, ovviamente già fragili di loro, che però quando finiscono in una shit storm di piccole dimensioni impazziscono dal dolore e talvolta si fanno del male, perché non hanno imparato a distinguere tra realtà e realtà digitale, a capire che il colpito non è una persona in carne e ossa, ma un’icona virtuale che ciascun aggressore si immagina diversa a suo piacimento?
Ma gli interrogativi non sono finiti. Come si può dare in mano una clava a chi poi la usa in maniera impropria e folle, come i migliaia che mi hanno insultata e che un tempo non avrebbero avuto la possibilità di aggredire, per fortuna non solo di chi è aggredito ma anche loro? E ancora: ma se io, che ho vent’anni di professione alle spalle e venticinque di analisi, ho sbagliato, se anche a me, che ho una cura certosina della parola, è sfuggito un post scritto male, anzi malissimo, anche se privo di insulti – il disprezzo resta una opinione - e non diffamante, quanti errori potranno mai fare quelli che non hanno la mia esperienza? Che, appunto, mi ha aiutato anche a capire qualche esatta emozione avesse guidato la mia mano in quel modo?
La riflessione finale è che, forse, anzi sicuramente, occorre tornare a un mondo mediatico dove ci siano mediazioni. Dove i contenuti, prima di apparire e vista la violenza con cui possono farlo, siano riletti possibilmente da chi quel contenuto non lo ha scritto. Come accade nei giornali o per un discorso pubblico. Questo non accade nei social e per questo io credo che forse sarebbe opportuno uscirne. Questo tema già era presente nella mia mente da un po’, ciò che ho vissuto lo ha rafforzato. Non è che i social media siano pericolosi in particolare, lo sono tutte quante le comunicazioni rese pubbliche senza controllo e in base alle emozioni. Anche in una chat di Whatsapp la violenza può circolare incontrollata, lo sappiamo benissimo, ma è ovvio che Facebook, Instagram e tutti gli altri social sono comunicazione pubblica non mediata per eccellenza.
La violenza di una comunicazione senza corpo
Ma senza mediazione significa anche senza corpo. Perché l’altro problema fondamentale della comunicazione digitale, dei social, delle chat è che è incorporea. Ovvero il corpo non c’è più. Ci si mandano frasi e insulti senza che sia possibile vedere un volto, i suoi movimenti facciali, i movimenti del corpo. Tutte cose che attutiscono, che rendono la comunicazione meno violenta e più umana. Parlando faccia a faccia è difficile arrivare a livelli di odiosità verbale come quelli virtuali. È molto più facile che si trovi, invece un accordo.
La cosa paradossale, dunque, è che nella società dei social e della comunicazione virtuale abbiamo ancora tutti gli aspetti negativi del corpo, ovvero che ci rende mortali, ma abbiamo eliminato tutti i suoi aspetti positivi. E cioè il fatto che ci renda umani e renda la nostra comunicazione umana, ricca di emozioni giuste, meno atta a fraintendimenti. A pensarci bene, si tratta di una vera tragedia. Non so se siamo in tempo per tornare indietro, ma dobbiamo impegnare tutte le nostre forze perché ciò accada.
Quanto a me valuterò cosa fare rispetto a chi mi ha aggredito, se questa aggressione verrà riconosciuta come tale da qualcuno più esperto di me. Ma la cosa che più mi preme capire e decidere è se uscire dal mondo dei social network. Perché un altro errore potrebbe ricapitare, se è capitato. Perché in questi giorni di silenzio ho capito che ho migliaia di amici ma non ne incontro mai nessuno, né posso abbracciarli. Non voglio dire che non ci sia vita all’interno della vita virtuale, ma se guardo le ore passate sui social, tantissime, rispetto a quelle che impiego per incontrare persone, pochissime, non c’è partita.
Forse possiamo ricominciare da qui. Rendendole, quando meno, uguali. E non usando mai e poi mai la comunicazione digitale per un litigio o uno scontro, perché non è da quel tipo di comunicazione che potrà arrivare un accordo e una riconciliazione. Cominciamo a farlo noi, insegniamolo ai nostri figli e chi può vada in giro a dirlo, forte e chiaro, nelle scuole. Mettendoci, appunto, tutto il corpo possibile.