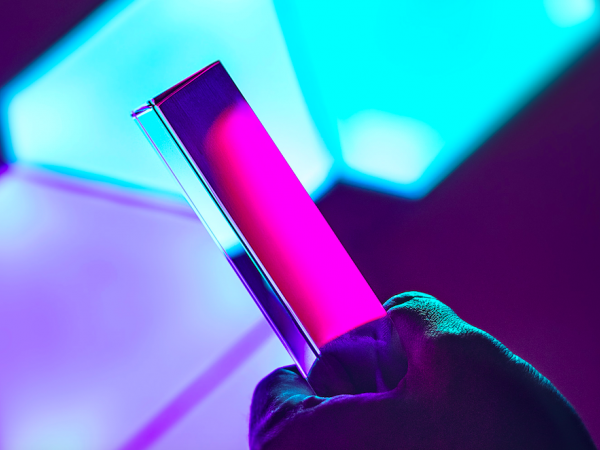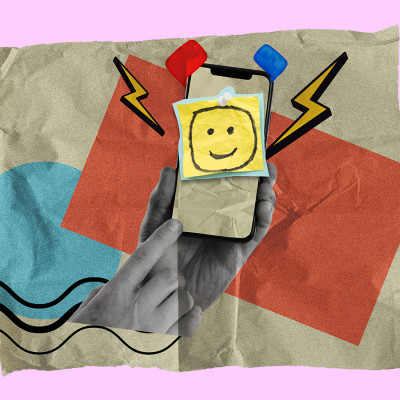Siamo ciò che compriamo (e compriamo tantissimo)

Fino a dieci anni fa la mia suoneria del cellulare era una canzone. Ricordo ancora quale fosse, Invaders must die dei Prodigy. Quando il telefono iniziava a squillare la canzone partiva, quasi in sordina, per poi lanciarsi nei suoni in ritmi mobili e duri. Spesso, molto più di quanto ammettessi allora, lasciavo che suonasse solo per sentirla e, per anni, non mi ha stufato.
Oggi, quasi non ho idea di quale sia la mia suoneria. La riconosco, certo, come tutti, ma non ho idea del suo nome e, certamente, non l’ho selezionata. So solo che è la suoneria di default dell’iPhone e quando la sento mi attivo in automatico per rispondere. Naturalmente, non mi piace lasciare che suoni a vuoto e se non voglio rispondere alla chiamata, la muto.
Cosa è cambiato in questi 10 anni in me e nel mondo che abito? Semplicemente, lo status symbol ha completato la sua adesione all’identità. Prima di scegliere una suoneria, prima, ci impiegavo del tempo. Valutavo quale mi piacesse sentire e quale mi piacesse che gli altri sentissero provenire dal mio cellulare. La mia scelta, era, e me ne rendo conto solo ora, un’espressione, un tassello nel puzzle che offrivo agli altri per scorgere chi fossi o, sotto certi aspetti, non farlo mai davvero. Mi coprivo sotto quella patina di suoni, uno schermo invisibile che sparava campionamenti e breakbeat dietro cui spiare le reazioni altrui. Mi lasciavo intravedere a pezzi serenamente protetta dietro gli spigoli e le punte del suono.
Noi late millennial abbiamo iniziato l’adolescenza quando i Nokia imperversavano e ci passavamo sotto banco, alle medie, i codici per comporre suonerie. Li scaricavamo, addirittura, pagando fino a 50 centesimi un numero che poteva inviarci codici o addirittura suonerie complete. Abbiamo scoperto, con gioia, l’arrivo delle polifoniche che hanno dischiuso l’accesso ai nostri gusti musicali. Avevano una dimensione pubblica, performativa e adolescenziale. Ci raccontavamo in quell’attimo di attesa prima di rispondere ai genitori in apprensione per il ritardo o, più frequentemente, per l’uscita guadagnata con l’inganno, i compiti vuoti e inerti sulla scrivania.
Sono arrivati poi gli schermi a colori, le immagini mobili, le videocamere che ruotavano a 180 gradi al sicuro nei nostri telefoni a conchiglia. Poi, con l’era degli smartphone e degli schermi esposti, si è affacciato al mondo l’iPhone, il cellulare che è stato sin da subito l’oggetto del desiderio diffuso. Per allora già avevamo confinato molti dei nostri gusti musicali tra le mura digitali di Apple, in playlist ordinate di canzoni scaricate illegalmente da quell’amicə bravissimə. Erano gli iPod a custodire chi fossimo, la nostra appartenenza subculturale, ma ancora suonavamo nelle suonerie. Io, come dicevo, nella mia ho abitato almeno fino a 10 anni fa, forse 7.
Oggi, in metro come in caffetteria, appena sento il suono distintivo della suoneria preimpostata dell’iPhone mi attivo, allungo le mani nella borsa e scavo, tra i libri, le chiavi, il taccuino, la busta delle medicine, la borraccia d’acqua, finché le dita non tastano qualcosa di liscio incorniciato in qualcosa di gommoso. Un artiglio con il suo premio. Nemmeno faccio caso ai gesti se non nel momento in cui me lo trovo in mano e interrogo lo schermo, inattivo e non illuminato da una chiamata. Una voce che dice “pronto” colloca il suono, era un’altra persona a essere cercata in quel momento.
Osservo come rispondo in fretta allo stimolo, e quando è il contrario e sono io la persona richiesta alla cornetta - no, nemmeno quelle si usano più - noto la stessa automatica ricerca negli altri. Stessi gesti, stessa emozione, a metà tra l’apprensione, il nervoso e l’entusiasmo di essere cercati. Non posso nemmeno immaginare che musica piaccia loro, posso solo sapere che hanno un iPhone.
Ed ecco il punto. A contare non è esattamente chi siamo - e onestamente non è mai stato quello il punto - e nemmeno chi vogliamo essere, piuttosto ciò che abbiamo. Non costruiamo più la nostra identità avendo cura di essere percepiti in qualche modo, nemmeno ci curiamo di mentire per la nostra immagine, vogliamo solo che si sappia cosa possediamo e su quello imperniamo la nostra identità, intima e pubblica.
Siamo ciò che compriamo, e compriamo tanto, tantissimo. Pur di essere quell’acquisto scendiamo a compromessi: l’iPhone sì ma le ferie dimezzate, il nuovo Samsung prenotato prima ancora che esca - la vendita prima del prodotto, l’acquisto che sancisce più della merce l’identità sono il parto finale della cultura consumistica - il pagamento dilazionato in rate spalmate su 2 anni, pur di avere tra le mani l’oggetto. Lo stesso, che in un anno ci parrà esteticamente obsoleto, incapace di farci sentire ciò che vorremmo essere.
Senza nemmeno saperlo, ci siamo trasformati in uno spot pubblicitario che respira e trasporta merce in ogni angolo, sul tavolo dei pranzi della domenica, nella tasca della giacca indossata alla messa sempre di domenica, nei tram e nei vagoni della metro, al bar e a casa di amici. Il desiderio di possesso compete, ed è caccia all’ultimo modello. Addirittura, sorge lo specchio del disequilibrio di genere nelle coppie in formato palmare, lei che eredita il vecchio iPhone quando lui lo compra nuovo, lui che deve avere il modello più grande e più grosso - si dice PRO - e lasciarlo scintillare su ogni superficie per riacciuffarlo appena la conversazione diventa noiosa o cala il ritmo, perché noi umani con le nostre pause e le nostre menti non possiamo essere scintillanti e costanti come lo stimolo che si annida negli smartphone.
Scorrono le dita sugli schermi e se qualcuno ha la malaugurata idea di telefonare saltiamo tutti, ci attiviamo per capire quale telefono stia suonando. Vogliamo che gli altri sentano il nostro potere di acquisto, che lo riconoscano e, perché no, lo invidino.
Ieri in macchina ho risentito i suoni rettangolari della canzone con cui lanciavo esche o sabotavo la percezione di me. Ho guardato il mio iPhone e l’ho messo silenzioso. Perché in realtà già lo era, dopotutto, non parlava mai di me.