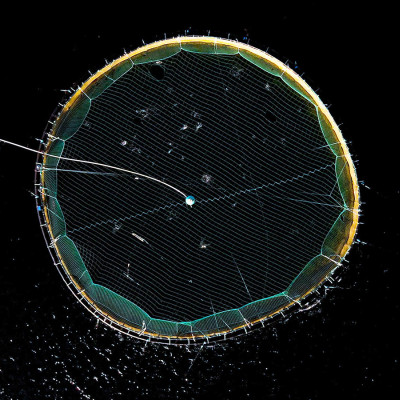Giuliana Sgrena: “è la modest fashion che ha sdoganato il velo”

«L’imposizione del burqa in Afghanistan non mi ha sorpreso, non ho mai pensato che i “nuovi” talebani fossero diversi da quelli che avevano costituito il primo emirato (dal 1996 al 2001): sono gli stessi cacciati nel 2001 e poi riportati al potere».
Partendo da qui, Giuliana Sgrena (in libreria con Donne Ingannate - Il velo come religione, identità, libertà, per Il Saggiatore) racconta a La Svolta come ha accolto la notizia delle giornaliste afghane costrette a indossare il burqa in diretta tv: «Era questione di tempo. I talebani hanno subito imposto l’uso del velo, sebbene il burqa sia divenuto obbligatorio solo in seguito».
Una domanda banale. Quanti tipi di velo ci sono?
Ne esistono diversi, i più diffusi sono: l’hijab, omologato al ciador iraniano, che lascia scoperto il viso; il niqab che copre anche il viso lasciando una fessura all’altezza degli occhi e il burqa che all’altezza degli occhi ha una rete.
Da dove proviene l’usanza del velo?
Il velo non è una prescrizione del Corano e non è nemmeno una tradizione. Se rispettasse la tradizione, ogni paese avrebbe un velo diverso ma, se risaliamo indietro nel tempo, il velo era già stato abolito da decenni. In Afghanistan l’obbligo del velo è stato abolito dalla costituzione nel 1923.
Nel giro di 30/40 anni le donne della famiglia reale sono apparse in pubblico a capo scoperto. Ma anche in Iran, Algeria, e Egitto le donne non portavano il velo prima del processo di reislamizzazione. Negli anni ‘60-‘70 le donne andavano in giro in minigonna a Kabul come a Tehran. È stato Khomeini, arrivato al potere nel 1979, a imporre il velo obbligatorio alle donne iraniane come segno di identità.
Perché il velo islamico è un simbolo di oppressione e non di libertà da parte della donna che lo indossa? Lo è anche nel caso in cui sia la donna a decidere di utilizzarlo o è una “donna ingannata”, per dirla con il titolo del libro?
Il velo serve al maschio, ossessionato dal corpo della donna, per controllare la sua sessualità. La donna con il velo, infatti, nasconde le parti del corpo che potrebbero provocare un desiderio nell’uomo. Sono sempre gli obblighi e/o i condizionamenti sociali a indurre la donna a portare il velo.
A meno che non sia una scelta ideologica, l’appartenenza all’Islam globale viene esplicitata anche nel modo di vestire. Persino in questo caso, tuttavia, è solo la donna che, per mostrare l’appartenenza alla comunità dei musulmani, deve coprire il proprio corpo.
Per le sue posizioni rispetto al velo islamico si è mai sentita tacciare di islamofobia o ha temuto che potesse accadere?
Mi succede di essere accusata di islamofobia, ma penso che islamofobi siano coloro che peccano di relativismo culturale e non riconoscono che i diritti delle donne sono universali. Considerare le donne musulmane diverse da noi, pensare che debbano accettare imposizioni che le privano della loro libertà per me è una forma di razzismo.
Nel libro sostiene che molte femministe occidentali difendono il diritto di indossare il velo, pur non usandolo ovviamente. Perché secondo Lei non è un modo corretto di affrontare la questione?
È paradossale che mentre nei paesi musulmani si lotta per liberarsi dal velo, in Occidente lo si consideri una libertà: le donne che si tolgono il velo in Iran finiscono in carcere, le donne algerine che negli anni ‘90 si sono rifiutate di portarlo sono state uccise dagli integralisti islamici.
Che ruolo hanno le grandi case di moda nel rilancio del velo islamico?
Il velo e l’abito islamico hanno dato vita a quella che viene definita “modest fashion” (moda modesta o meglio, pudica) su cui investono le case di moda di tutto il mondo e rappresenta un giro d’affari di centinaia di miliardi. Il velo è stato “sdoganato” anche dalle modelle che sfilano sulle passerelle con l’hijab, ma si tratta di una moda poco modesta, a dispetto del nome.
La prima collezione lussuosa per il Ramadan (il mese sacro del digiuno, per i musulmani) è stata lanciata da Dolce & Gabbana nella penisola arabica, ma ci sono anche collezioni più economiche come quelle lanciate da H&M e Zara.
Quanto l’esperienza del rapimento e in generale del giornalismo di guerra la influenza ancora oggi?
Il rapimento ha cambiato la mia vita, ma non il mio modo di fare giornalismo. Ho sempre pensato che occorresse verificare le notizie prima di pubblicarle, anche e soprattutto nei teatri di guerra. In contesti del genere la propaganda è usata da tutti gli attori in campo e rende difficile il lavoro del giornalista, ma non ci si può fermare alle apparenze, occorre rappresentare la complessità della situazione.
Purtroppo, invece, l’informazione sull’invasione russa dell’Ucraina mi sembra poco approfondita e per certi aspetti embedded (incorporati o arruolati, un termine usato per definire i giornalisti al seguito degli eserciti). Prevale un pensiero unico, chi si pone delle domande viene subito accusato di essere “putiniano”. Così il giornalismo perde credibilità.