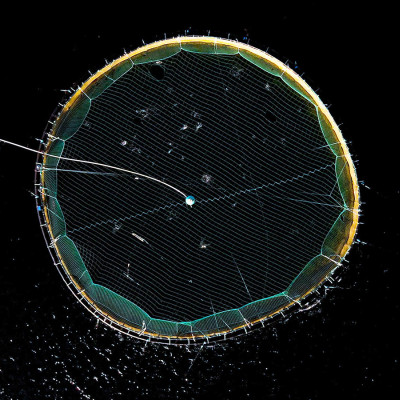Un’arma climatica contro Putin

La guerra in Ucraina ha sparigliato le carte degli equilibri energetici mondiali e aperto nuovi, incerti, scenari per la decarbonizzazione. Aumenti dei prezzi, corsa alla diversificazione degli approvvigionamenti, riscoperta del carbone, ritorno dell’atomo, corsie preferenziali alle rinnovabili.
Basta vedere il caos generato dallo stop di qualche giorno fa alle forniture di gas in Bulgaria e Polonia da parte di Mosca. L’azione ardita ha fatto di nuovo schizzare i prezzi, favorendo così Putin che in questa fase ha bisogno di quante più risorse economiche possibili. E appare oramai evidente che l’uso dell’energia come arma economica contro la Russia rischia di essere estremamente complicata e impattante sull’economia europea (dunque quella mondiale), soprattutto se usata impropriamente. Si urla troppo, manca il sangue freddo.
Pensare semplicemente di fermare l’acquisto dell’energia fossile russa non è di per sé un’arma. Infatti i prezzi stellari del gas e del petrolio sui mercati globali per tutto il 2022 (e forse anche parte del 2023) che deriveranno dall’inevitabile escalation energetica favoriranno i Paesi asiatici, che potranno accedere a un prezzo calmierato alle risorse russe invendute. In questo modo Putin continuerebbe ad avere un afflusso costante di risorse minimizzando gli impatti delle sanzioni.
Per fermare la corsa dei mercati energetici delle energie fossili serve un’arma-fine-di-mondo: una rigida politica climatica sulle emissioni a livello globale. Perché? Provo a spiegarlo.
Mai come in queste settimane l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici offre una sponda importantissima nel tentativo di fermare l’insensata invasione russa. Se dagli Usa, dall’Ue e dal resto delle nazioni schierate contro la Russia arrivasse un segnale per un phase-out delle fossili (stop ai mezzi a combustione entro il 2035 oppure un annuncio importante sui consumi di metano), spingerebbe le grandi aziende dell’oil&gas a accelerare la vendita degli asset e darebbe un boost fortissimo al settore delle rinnovabili, portando a realizzare in 12 mesi quanto in uno scenario normale servirebbero 5 anni.
In questo momento non c’è un migliore amico di Putin di Joe Manchin, il senatore democratico che ha bloccato il piano Biden per la decarbonizzazione, Build Back Better, o di politici come Salvini o Calenda, che piangono per la pace ma spingono per aumentare i consumi di fossili.
Ora arriva il difficile: la vendita degli asset aumenterebbe però l’offerta di fonti fossili sul mercato, incrementando nel breve termine i consumi e dunque le emissioni, rendendo più difficile raggiungere gli obiettivi a breve termine sulla riduzione delle emissioni. Si tratta di un paradosso inevitabile.
In questo scenario il mare di petrolio e gas che verrebbe immesso sul mercato soprattutto da quei Paesi con importanti riserve (Emirati e Arabia Saudita) sarebbe una spina nel fianco per Vladimir Putin, poiché potrebbe costare fino a 9 punti di PIL e eliminare un terzo delle risorse economiche pubbliche, necessarie per pagare i professionisti nell’esercito e mantenere l’ordine nelle istituzioni.
Per compensare l’effetto collaterale della manovra, ovvero il conseguente aumento delle emissioni della sbornia fossile, servirebbe a quel punto sostenere uno sforzo sovrumano sul medio termine di incentivi senza precedenti su solare, eolico, efficientamento energetico e mobilità non fossile, finanziato proprio – paradossalmente – dal surplus fossile convenzionale.
Con prezzi davvero ridotti sui veicoli elettrici, in uno scenario di abbondanza di benzina e prezzi contenuti, si potrebbe avere competizione andando a invertire la curva delle emissioni al 2030, rendendo a quel punto operativi meccanismi finanziari globali sui prezzi della CO2 (mercati delle emissioni o carbon tax), come previsto proprio dall’Art.6 dell’Accordo di Parigi.
Ecco il risultato ipotizzabile: la Russia in ginocchio, il mercato delle fossili sempre più nel panico, risorse ingenti per la transizione ecologica giusta (cioè accessibile anche ai ceti più bassi, come a esempio il sostegno all’efficientamento energetico domestico delle abitazioni dei più poveri) e dopo qualche anno di crescita delle emissioni di gas climalteranti (che sarebbe in ogni caso inevitabile fino al 2025) si vedrebbero i risultati di questa azione globale.
Per poter realizzare uno schema di questa complessità serve innanzitutto unità politica. Se in Europa le ultime settimane hanno visto importanti segnali di unità, in Nord America, dove a esempio i repubblicani americani farebbero di tutto pur di difendere l’industria statunitense del gas e petrolio, rimane da costruire una forza tale in grado da portare avanti un piano così complesso quanto necessario. Difficile anche includere la Cina, o persino l’India da sempre chiare sulla responsabilità storica nelle emissioni di gas climalteranti del mondo occidentale.
Eppure un meccanismo internazionale, entro cui persino la Russia è inserita, esiste. Ed è esattamente l’Accordo di Parigi, operativo e ben definito. Nell’Accordo esistono numerosi meccanismi per finanziare questa immensa operazione di transizione ecologica globale come arma fine-di-mondo contro lo Zar. Per sostenere la pace non servono le bandiere ai balconi quanto fare scelte a basse emissioni di CO2. Sfruttando il miglior risultato mai ottenuto dalla diplomazia globale e dalle Nazioni Unite, con buona pace dei critici da tastiera di questo importante meccanismo.