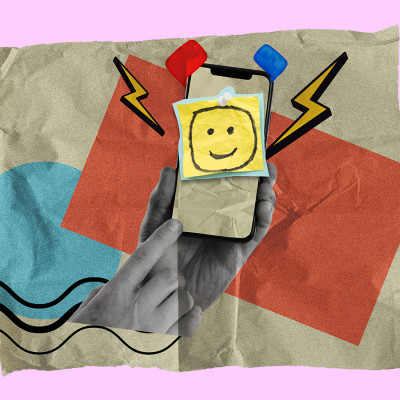Contro la performance del dolore

Le immagini dei cadaveri di Bucha riempiono i nostri schermi da giorni. La mano della donna con lo smalto rosso, l’uomo riverso a terra ancora a cavalcioni della bicicletta, i corpi abbandonati per le strade. Anche se i mezzi d’informazione cercano di oscurare questi contenuti truculenti, mettere avvisi, trigger warning (come si dice ora, mutuando il linguaggio della psicologia) li vediamo lo stesso. Sono ripubblicati dalle persone che seguiamo, corredate da frasi di commento che praticamente non leggiamo, frasi che esibiscono dolore e sgomento. Oppure, quando va male, teorie del complotto e accuse ai “nazisti ucraini”, ma restiamo sulla prima ipotesi, quella umana, quella con un minimo di adesione al reale. Le frasi che vediamo sui social a corredo di quelle immagini raccapriccianti non aggiungono niente a quello che già sappiamo, non propongono – ovviamente – soluzioni, non spostano nulla che non sia il nostro senso di nausea e terrore nel vederle. E allora, perché la gente continua a postarle?
Ci sono vari motivi per cui la foto di un cadavere finisce sul feed di una persona che non è l’autore della foto, non è sul luogo del massacro e non può, quindi, dire di “fare informazione”. Il primo, e forse più comprensibile, è la necessità di condividere l’orrore con altre persone e nel farlo sentirsi meno soli: l’ho visto io, dovete vederlo anche voi. Non un sentimento molto rispettoso delle sensibilità altrui, anzi, un tantino egoista, ma senza dubbio umano. Fa parte di quelle cose che facciamo quasi senza pensarci, cercando negli altri una sponda, una risposta che ci confermi che sì, quella cosa è orribile, orribile oltre ogni misura, oltre ogni comprensione. Una risposta che ci dica che le persone con cui siamo in relazione condividono la nostra stessa reazione davanti ai crimini di guerra.
Il secondo motivo viene invece rivestito di una valenza politica: la foto viene ripubblicata con un testo che quasi sfida i follower, dovete guardare, dovete guardare anche voi! Non potete ignorare o girarvi dall’altra parte! Peccato che ignorare o girarsi dall’altra parte sia possibile ormai solo a patto di avere spento televisione, radio, cellulare, computer e perfino lo smartwatch da due mesi, per non dire da anni, dato che le immagini di corpi senza vita sono dappertutto sempre, come le notizie che illustrano. Ci vuole un certo impegno, per ignorare certe informazioni: è una scelta, uno sforzo, non certo una casualità. Se lo sapete voi, del massacro di Bucha, lo sa anche lo zio Gianni. Lo sa anche la cugina Samantha. L’inutile violenza fatta a loro, oltre che a quei corpi martoriati che non hanno chiesto di essere esibiti, serve solo a chi posta per ricordare al mondo quanto è più bravo, engagé e sensibile degli altri.
Perché in fondo si tratta di questo, di una forma di performance, l’ennesima a cui i social ci spingono ogni giorno. Che sia un cadavere abbandonato o la foto a bordo piscina taggata #èperlavoro, tutto finisce per essere personal branding. Le emozioni, anche autentiche, diventano messa in scena, costruzione dell’immagine, curatela dei contenuti, o peggio: la ricerca affannosa dell’approvazione altrui. Non sia mai che ti venga rimproverato di non esserti indignato abbastanza, di non aver reagito nel modo appropriato, al volume appropriato, davanti a una tragedia umanitaria. Se poi quell’immagine è costruita anche solo in parte intorno a contenuti politici, il rischio è di venire sollecitati a esprimersi anche “a nome di”: e se non lo fai, allora non sei all’altezza. Anzi, il tuo silenzio viene letto come complice. Si rischia meno con una bella foto splatter, tanto il cadavere mica è quello di un tuo parente o di un tuo amico: può essere esibito come simbolo per consentirti di scrivere qualche frase di circostanza sulla bruttezza della guerra e sugli abissi dell’umano.
Tacere, non sapere cosa dire, non voler dire niente perché si è sopraffatti dall’orrore è una cosa normale. È normale provare empatia per quei corpi rannicchiati nel fango, domandarsi cosa possano aver pensato pochi secondi prima di morire, se abbiano sofferto o se la morte sia arrivata all’istante. È quasi automatico, siamo umani, ci rivediamo negli altri esseri umani. Non dovrebbe essere necessario mettere in scena quell’empatia, tantomeno farne un contenuto che si perde nel flusso di mille altri contenuti, un contenuto che ha l’unico scopo di proiettare un’immagine pubblica di noi al di sopra di ogni critica, ma non ha alcun impatto positivo sulla realtà.